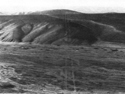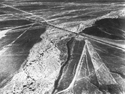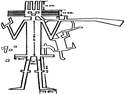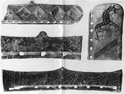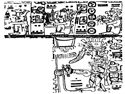Memories From the Future
Pseudoscience
* * Back * *

VIAGGIATORI DEL TEMPO - Peter Kolosimo
I - La saga di holger / II - I cacciatori di dinosauri / III - Civiltà sconosciute / IV - Ipotesi extraterrestri / V - I segreti dei mounds / VI - Gli astri venuti dal nord / VII - Alchimia cinese / VIII - Città d'argento, colline d'oro / IX - Dal loch ness al sahara / X - I custodi della luce / XI - Presenze ignote / XII - Realtà fantastiche / XIII - I dominatori del cielo / XIV - Sbarcano gli «alieni» / XV - La via delle stelle
Capitolo I - Viaggi nel passato: La saga di Holger
Holger Carlsen era sdraiato sulla spiaggia pietrosa e sparava, sparava, con la Luger che gli bruciava in mano. Dalla strada piovevano le raffiche dei mitra nemici, sempre più nutrite, sempre più vicine. Le acque del Sund battevano sulle rocce, indifferenti, indifferenti brillavano le stelle e, al di là del mare, baluginavano le luci tranquille della costa svedese.
Holger continuava a sparare. Non sapeva se ce l'avrebbe fatta, non sapeva se i suoi compagni sarebbero riusciti, con lui, a condurre a termine la missione. Sapeva soltanto che si trattava di un'operazione importantissima, forse decisiva per le sorti del conflitto: trasportare al di là del Sund, in Svezia, un personaggio di cui ignorava tutto, identità, professione, scopi.
«Udì un miagolio di pallottole intorno al capo, l'urlo di un uomo che, colpito al petto, tossiva sangue. Holger prese ancora la mira, tornò a sparare. Poi tutto il suo mondo esplose in una fiammata e fu il buio».
Si svegliò, ed era giorno. Una pallottola lo aveva colpito di striscio al capo, ma non era più sulla spiaggià. Si alzò nel cuore di una foresta sconosciuta, dagli alberi immensi, annosi, coperti di muschio. Una foresta vergine in Danimarca? No, non poteva esistere, come non sarebbe potuto logicamente esistere tutto quanto doveva scoprire subito dopo: un gigantesco cavallo nero bardato d'argento, una lancia, una daga, un elmo, un'armatura, una spada e uno scudo. E sullo scudo spiccavano, in campo d'oro, tre cuori rossi e tre leoni azzurri.
Così hanno inizio le tumultuose peripezie di Holger Carlsen, sbalzato di colpo da un incantesimo dalla Danimarca occupata dai nazisti, contro cui combatteva, in pieno medioevo, nel mondo delle saghe carolinge, dove sta scatenandosi un altro tremendo conflitto che opporrà le forze della Luce a quelle del Caos e del cui esito egli è chiamato dal destino a decidere, come lo fu, inconsciamente, sulle sponde del Sund.
Eventi che egli aveva creduto vivi soltanto nella sfera delle antiche Chansons de Geste lo attendono, con personaggi altrettanto fiabeschi: la strega Gert, il nano Hugi, il viscido Alfric, duca del Mondo Fatato, draghi volanti, unicorni, esseri mostruosi, la splendida e perfida Fata Morgana, la candida, bellissima Alianora, la Vergine-Cigno.
L'eroe vivrà sino in fondo la sua straordinaria avventura, riuscirà a dare la vittoria ai buoni ed a rituffarsi nel nostro mondo e nella nostra era, che non è forse la sua.
Vagherà poi, infatti, alla ricerca di testi antichi e di libri modernissimi, di trattati di magia e di volumi sulle più recenti speculazioni matematiche, sulle probabilità, sul caso, sulle possibilità alterne. Perché l'amore per la Vergine-Cigno lo richiama «laggiù».
«Ormai non lo vedo da tempo», conclude l'autore della storia, «e da tempo non ho sue notizie. Talvolta mi chiedo se sia tornato dalla sua Alianora... e spero che sia riuscito a farlo».
L'autore è Poul Anderson, la storia s'intitola «Tre cuori e tre leoni»: è una bella, poetica versione in chiave di fantascienza della saga di Holger Danske, Ogier le Danois per i francesi, fratello di Alda, la moglie di Orlando. La leggenda vuole che dorma sotto una delle possenti torri del castello di Kronborg, pronto a ridestarsi ed a brandire la sua invincibile spada Cortana ogni volta che la Danimarca e la Francia si trovino in pericolo.
Leggenda a parte, Anderson sembra aver fatto compiere al nostro eroe un viaggio nel tempo e si appoggia, per questa sua escursione letteraria, ad alcune teorie delineate nel finale.
Ma è davvero possibile viaggiare nel tempo?
Capitolo II - Viaggi nel passato: I cacciatori di dinosauri
«L'avviso era grande, bianco e autorevole quanto mai. Si alzava repentinamente dalla zona erbosa e spiccava contro il cielo azzurro come la mano alzata di un vigile quando arresta il traffico. Sull'avviso, in caratteri grossi e neri, si leggeva:
SALTO NEL TEMPO AMMESSE SOLO LE PERSONE AUTORIZZATE
«Owen faceva un salto indietro nel tempo ogni due settimane quasi...».
Siamo di nuovo nel pieno di un romanzo di fantascienza, pur se di altro genere e Owen è la guida destinata a condurre gruppi di sfaccendati ben paganti cento milioni di anni a ritroso dalla nostra era, in un safari diretto a spacciare qualche dinosauro, da lasciare ovviamente sul posto ad evitare spiacevoli complicazioni.
Ma su quale principio si basa questa fantastica impresa? Owen non perde tempo in disquisizioni scientifiche, ma si limita a chiarire il concetto ai suoi turisti con un semplice esempio:
«Immaginiamo che il tempo sia un disco fonografico. Un disco con il solco a spirale, inciso. Voi ponete la puntina, e questa si muove verso il centro del disco. Rendo l'idea?
«Ora facciamo un secondo passo: ammettiamo che l'incisione esterna del disco sia il passato e i solchi più interni siano il presente. Quando si suona un disco, la puntina procede dal passato al presente, no?
«Il punto cruciale è semplice. Parecchia gente, erroneamente, crede che il passato sia morto, scomparso. Ma se paragoniamo il tempo a un disco inciso, possiamo vedere che il passato è sempre là, coesiste con il presente. Per esempio, quando suoniamo il disco, le prime note passano con i primi giri della puntina, ma non sono morte, scomparse. Basta rimettere la puntina sul margine esterno del disco ed esse rivivranno.
«Tutto ciò che fa il salto nel tempo è un movimento brusco della puntina, in realtà. In altre parole, esso fa saltare la puntina dai solchi più interni, che rappresentano il presente, ai solchi più esterni, che rappresentano il passato».
Nel corso della spedizione guidata da Owen qualcuno muore. Ma il ricordo dell'esistenza di costoro svanisce nella mente dei superstiti e, al loro ritorno nel presente, anche in quella dei familiari degli scomparsi: per loro, per tutto il mondo, è come se non fossero mai vissuti.
Il tempo, secondo il romanzo di Marften, rimargina le proprie ferite: è un ragionamento che al protagonista, riferendosi ad un certo Masterson, uno degli uccisi, sembra scontato.
«È una legge elementare. Una cosa non può esistere e non esistere nello stesso tempo. O Masterson era esistito, o non era esistito. Se era morto nel periodo giurassico, non poteva essere vissuto ai nostri tempi».
Secondo noi, è tutt'altro che elementare: è, anzi, piuttosto difficile che il tempo provveda a cancellare di colpo, a beneficio dei partecipanti a safari del genere, la memoria di persone esistite sino a poco tempo prima, con tutte le implicazioni e le complicazioni che la loro vita comporta.
Qui ci troviamo, piuttosto, davanti al famoso paradosso temporale: che cosa accadrebbe di me se potessi trasferirmi nel passato e uccidessi mio padre prima che conoscesse mia madre?
Pare che Einstein si mostrasse abbastanza ottimista circa le possibilità future di valicare le frontiere del tempo. Nel 1962 l'astronomo sovietico Kosirev scrisse. «La tecnica umana consentirà ben presto di manipolare il tempo». E il professor Slovski dichiarò: «I progressi nell'esplorazione del cosmo ci daranno modo di esplorare anche il tempo».
Questa sembra essere pure l'idea dell'ingegnere francese Émile Drouet, il quale avrebbe addirittura progettato una «macchina» per viaggiare nel passato. Solo che la sua invenzione ha un piccolo difetto: non consente il ritorno al presente.
Se esiste la possibilità di viaggiare nel tempo, essa è - come tale - puramente illusoria: realizzandola, infatti, noi non ce ne andremmo a spasso per quello che è stato il passato o sarà il futuro del nostro pianeta, ma in un'altra dimensione, proprio come nel tuffo che Poul Anderson fa compiere a Holger Danske.
Perché - scrive Fredric Brown - «abbiamo un numero infinito di universi coesistenti e tutti gli universi concepibili esistono. C'è, per esempio, un universo in cui in questo momento si svolge questa stessa scena, con la sola eccezione che tu, o il tuo equivalente, porti scarpe marrone invece di scarpe nere. C'è un numero infinito di permutazioni dei caratteri variabili, per cui in un altro caso avrai un graffio in un dito e in un altro ancora corna purpuree...
«... e c'è un numero infinito di universi, naturalmente, in cui noi non esistiamo affatto, vale a dire non esistono creature simili a noi, anzi, in cui la razza umana non esiste affatto. Ci sono, ad esempio, infiniti universi in cui i fiori sono la forma di vita predominante, oppure in cui non si è mai sviluppata né mai si svilupperà alcuna forma di vita. E infiniti universi in cui le fasi dell'esistenza sono tali che noi non abbiamo parole né pensieri per descriverle o immaginarle».
Quando ci sarà consentito andare a caccia di dinosauri, viaggiando nel tempo o in altre dimensioni?
Non ve lo possiamo anticipare.
Possiamo presentarvi, però, un signore che a caccia di dinosauri è già andato e va tuttora: il dottor Cabrera.
Uomini e mostri
Il dottor Cabrera è un viaggiatore del tempo. Ha conosciuto la Terra qual era milioni di anni fa, gli indescrivibili cataclismi che l'hanno travagliata, dilaniata, il plasmarsi e il riplasmarsi dei continenti, la faticosa ascesa dei primi esseri pensanti, i loro conflitti con creature mostruose, le loro vittorie e le loro sconfitte, le loro sbalorditive conquiste cancellate da altri eventi di portata cosmica.
Il dottor Cabrera - o, per l'esattezza, Javier Cabrera Darquea - non è il personaggio di un romanzo di fantascienza: è direttore della Sezione ricerche dell'università peruviana, medico all'ospedale operaio della città di Ica, a sud di Lima, membro del jury del Consiglio regionale e membro corrispondente del Collegio internazionale di chirurgia.
È anche, però, studioso di biologia, di preistoria, di antropologia, e proprio questo lo ha condotto a percorrere a ritroso il lungo e tormentoso cammino dell'umanità.
Interessante è il fatto che la città di residenza di Cabrera appartenne allo stato di Chincha, che, nella valle omonima, in quelle di Pisco, Ica e Nazca, dominava incontrastato là dov'era un tempo fiorita la civiltà di Nazca, estinta dopo la formidabile espansione della leggendaria Tiahuanaco.
Deduzioni? Intuizioni? Ipotesi tessute su vaghe tracce?
Niente di tutto ciò. Del suo sorprendente viaggio nel remoto passato il ricercatore possiede le testimonianze, custodite nel suo museo privato in Ica, in Plaza de Armas, ospitante una straordinaria collezione di ciottoli arrotondati, di pietre piatte, di blocchi di andesite, quasi tutti neri o grigi: 11 mila pietre, le cui dimensioni sono diversissime; alcune sono molto piccole, altre più grandi, altre ancora pesanti cento, duecento chili. Ma tutte sono incise, da una o più parti, con disegni fini, accurati, tali da lasciare senza parole.
«E sono pietre», scrive Robert Charroux, che ha avuto la fortuna di visitare il museo e d'intrattenersi con lo scienziato, «le quali danno alla preistoria e allo studio delle antiche civiltà una luce che sconvolge le tesi inesatte ed ormai scadute che s.'insegnano nelle università».
«Le mie pietre», afferma, dal canto suo, il dottor Cabrera, «provengono dalla civiltà dei primi uomini colti della nostra Terra. Per una ragione sconosciuta, forse un cataclisma naturale, questa civiltà scomparve, ma gli uomini dell'antica Ica vollero lasciarci una testimonianza indistruttibile o almeno suscettibile di superare i pericoli del tempo. Questi archivi appartengono ad un popolo culturalmente vicino a noi, ma erede diretto delle conoscenze dei nostri grandi antenati.
«Si può logicamente pensare che questi antenati siano stati gli Atlantidei sfuggiti allo sprofondamento del loro continente, giunti nei pressi di Ica, dove lasciarono le loro "pietre parlanti".
«A torto si data l'avvento dell'Homo sapiens due o tre milioni di anni prima del nostro tempo. L'uomo è molto più vecchio di quanto si dica ed ha certo conosciuto i grandi mostri che stabilirono la loro dittatura sul regno vivente dell'era secondaria.
«Io posso attestare che questi mostri (plesiosauri, diplodochi, iguanodonti e così via) vissero alla fine del Secondario, sopravvissero nel Terziario sino ad un'epoca in cui gli uomini li conobbero ed ingaggiarono con loro la lotta per la supremazia sul globo.
«Ho iniziato a collezionare le mie pietre nel 1966, ma le prime furono trovate da huaqueros, cercatori di vasellame».
Cominciarono a raccoglierle nel 1955 i fratelli Carlos e Pablo Soldi, ed alla loro morte esse passarono al museo regionale di Ica. Li seguì il comandante Elias, direttore del museo navale di Callao fino al 1973, il quale ne comprò circa trecento dagli scavatori abusivi, depositandole nel suo istituto.
Anche l'architetto Santiago Agurto Calvo, già rettore dell'università nazionale del Genio civile, assieme al professor Alejandro Pezzia, direttore del museo di Ica, rinvenne tre sassi incisi in tombe precolombiane, e la loro scoperta venne citata nella rivista Domenical del giornale Le Commerce dell'11 dicembre 1966.
È certo che dal 1965 parecchi appassionati, studiosi e non, approfittarono dell'incuria delle autorità culturali peruviane per sottrarre chissà quanti dei preziosi documenti, per cui non c'è più da pensare neppure lontanamente che la raccolta venga ricostruita nella sua completezza.
Il maggior lavoro, comunque, è stato compiuto dal dottor Cabrera, il quale lo iniziò con un pezzo donatogli dall'amico Felix Lhona e senza dubbio rinvenuto da un huaquero.
L'architetto Calvo e il professor Pezzia erano semplici collezionisti di oggetti curiosi e non si preoccuparono di studiare quanto avevano trovato, ma ebbero un grande merito: quello di dimostrarne l'autenticità, assieme a molti altri ricercatori che sarebbero seguiti.
Il mineralologo Mauricio Hochschild, di Pisco, esaminato il materiale, analizzatolo minuziosamente, ha dichiarato che sia a coprire l'incisione che la superficie non graffita è la medesima ossidazione naturale. Lo scienziato non si è azzardato a fissare una data, aggiungendo però che l'età delle pietre stesse è, per lo meno, di parecchi secoli.
Il colonnello Omar Choino Carranza, direttore del Museo dell'aeronautica peruviano, ha detto, reciso: «Non c'è dubbio: si tratta di un messaggio lasciato in eredità da un popolo molto antico, di cui la storia ha perso il ricordo. Queste pietre sono state incise parecchi millenni fa. Da tempo sono conosciute in Perù e il mio museo ne possiede oltre quattrocento».
Ma c'è, naturalmente, chi si ostina ad esprimere un parere diverso.
Preistoria sepolta
Nel 1968 un professore statunitense, John Rowe, ebbe occasione di osservare a Lima una delle pietre del dottor Cabrera. La guardò, la girò e la rigirò, la soppesò e dichiarò, perentorio: «È un falso!».
False, quindi, sarebbero tutte le altre, come si affrettarono a dichiarare gli amici di Rowe.
«Gli studiosi classici di preistoria sono vittime dei loro pregiudizi, dei loro paraocchi e dei loro decreti-legge», replicò Cabrera.
Ed a ragione.
Come sarebbe possibile falsificare le migliaia di pietre incise che lo studioso di Ica conserva nel suo museo privato, come scoprirne continuamente altre?
«Da un quarto di secolo queste pietre incise si rinvengono nella regione di Ica e ne restano ancora migliaia e migliaia da scoprire», dichiara il dottor Cabrera. «Io non pretendo di spiegare tutto, ma è indiscutibile che le pietre esistono, e in numero tanto grande (forse centomila) che ogni idea d'impostura dev'essere scartata».
Lo scienziato ha richiesto l'intervento di una commissione di esperti atti a dirigere le ricerche del materiale non ancora reperito, consigliando però prudenza, e ciò per ottime ragioni: «Ho potuto riunire 11 mila pietre, ma ne esistono molte di più ed io desidero arricchire al massimo la collezione. Rivelando il luogo in cui si trovano le altre, curiosi, amatori e turisti andranno a fare un disastro, rovinando la completezza della biblioteca. Occorre quindi, prima di tutto, riunire gli specialisti. Il governo peruviano dovrebbe, poi, garantire la preservazione dei luoghi stabilendo una guardia permanente».
Va ancora notato che le pietre sono di andesite, con un'età di 80 milioni di anni, risultate dalla disgregazione del massiccio andino durante il Mesozoico e presentano una forte patina di ossidazione che, come abbiamo detto, copre le incisioni e ne assicura l'autenticità.
Purtroppo le precauzioni che il medico voleva prendere sono giunte in ritardo, e lo ha scoperto lo stesso Charroux al chilometro 325 della desolata strada tra Ica e Palpa, dove sorge il villaggio di Ucucaje, formato da una ventina di case miserabili, poste qua e là senza ordine sullo sfondo di un deserto privo di un albero e di un filo di erba.
«L'arrivo della nostra macchina destò sensazione», scrive lo studioso francese, «e un nugolo di ragazzini curiosi, a volte sfacciati, ci circondarono e ci assalirono. Senza dubbio non eravamo i primi turisti a rendere loro visita. Delle bambine ci tirarono per le maniche in direzione delle loro capanne: "Señor, por alli... Desea usted piedras?"».
«Un segreto di Pulcinella», commenta Charroux. E fu proprio l'identificazione del luogo a far sì che parecchi giornali scandalistici si scatenassero, sulle tracce di Rowe, contro il dottor Cabrera con le affermazioni più assurde, battendo persino moneta falsa, come si suol dire, pur di «dimostrare» che le pietre da lui raccolte erano frutto d'imbroglio.
Il Correo di Lima del 25.1.1975, ad esempio, tentò di provarlo con un articolo firmato da un certo Ravines, in cui si asseriva che lo studioso di Ica avrebbe imitato un docente di Würzburg, Juan Bartolomé Beringer, collezionista di pietre strane.
Dice Charroux: «Ce ne sarebbe abbastanza per spedire l'autore in tribunale per diffamazione, se il dottor Beringer non fosse morto da un paio di secoli. Il señor Ravines è un ignorante. Eccone la prova: il dottor Beringer non ha mai collezionato pietre, né vere né false!».
Una tale W. dichiarò alla pubblicazione svizzera 24 Hebdo, sempre nel 1975: «Le pietre di Ica sono false, ne ho la prova scritta... il dottor Cabrera è ricercato dalla polizia». Il 9 giugno fu costretta a smentire pubblicamente, specificando che «le persone ricercate e interrogate dalla polizia erano dei meticci e non il dottor Cabrera».
Il colmo venne però raggiunto dagli inviati del periodico peruviano Mundial, i quali - riferisce sempre Charroux - «piovvero ad Ocucaje, ponendo i poveri contadini del luogo di fronte ad una precisa alternativa: o confessare di essere violatori di tombe, ladri e trafficanti illegali, o dichiarare di avere inciso le pietre, spacciandole poi per rinvenimenti».
Un lavorante agricolo, Basilio Uchuya, e una donna del posto, Irma de Aparcana, furono facilmente convinti a sostenere quest'ultima versione. Ad Uchuya, poi, fu commissionata una pietra falsa, con la quale venne ripreso dai cronisti.
Stralciamo dalla rigorosa inchiesta di Charroux: «I giornalisti del Mundial confessano, nel loro reportage, di avere pagato Irma Gutierrez de Aparcana [...].
«Mundial ha pubblicato nove foto, che mostrano tutte il viso ansioso, impaurito, del povero diavolo (Uchuya). Nove foto "bidone", come si dice in stile giornalistico, perché Basilio non aveva né un laboratorio d'incisione, né pietre di riserva, né attrezzi per incidere, niente che potesse attestare la sua attività d'incisore [...] e le nove foto riproducevano sempre la stessa pietra! [...]
«Nella sorprendente "confessione" che fu costretto a scrivere, Basilio dichiarò che in dieci anni aveva inciso tutte le pietre componenti il museo del dottor Cabrera».
A parte il fatto che un'impresa del genere risulta matematicamente impossibile per un uomo dedito, come da sua dichiarazione, al duro lavoro dei campi, digiuno della minima nozione scientifica o storica, sorvolando sui due giorni che gli furono concessi («Mi si forza!», disse egli stesso), non riuscì che a mettere insieme un ridicolo sgorbio, neppure lontanamente paragonabile agli originali, sentiamo ancora Charroux:
«Si calcolano a circa 50 mila i ciottoli disseminati nel mondo intero, asportati dagli archeologi, nascosti in musei privati, segnatamente negli Stati Uniti, dove il signor Hamilton C. Foreman ne possiede duemila.
«Se Basilio ha inciso le 11 mila pietre del dottor Cabrera, chi ha inciso le altre 39mila?»
«È ben chiaro che Basilio e Irma hanno mentito!».
Le dichiarazioni a favore dell'autenticità delle pietre di Ica sono numerosissime. Ci limitiamo qui a riassumere le principali.
il Museo Arqueologico di Carlos Belli (membro corrispondente di parecchie associazioni scientifiche americane e professore del Collegio Nazionale), aperto ad Ica il 7 dicembre 1940, presenta, fra l'altro, parecchie pietre scoperte ad Ocucaje nel 1909.
Gli archeologi Hans Dietrich Disselhof e Sigwald Linné, autori dell'opera L'Amérique précolombienne, edita da Albin Michel, a Parigi, nel 1961, in base a ricerche molto anteriori, parlano abbondantemente delle tombe e dei ciottoli graffiti di Ocucaje.
Il dottor Alejandro Pezzia Assereto, conservatore del museo di Ica, scrive nell'opera Ica y el Perú Precolombino (Imprenta Ojeda, lca 1968): «Nella valle di Ica, dopo il 1961, è apparso sul mercato un gran numero di pietre incise che si manifestano come nuove vestigia artistiche elaborate dai precolombiani di Ica.
«È interessante notare che le pietre di cui parliamo comparvero per la prima volta nel 1960 (è un errore di data del dottor Pezzia). Si trovano in modo particolare nei giacimenti nascosti sotto i versanti delle colline delle haciendas di Ocucaje e Callango, nella valle del Rio Ica, all'entrata della zona delle piste.
«L'importanza di queste pietre è sottolineata dalla ricchezza dei loro disegni e del loro simbolismo, databili all'epoca della progressione culturale precolombiana di Ica».
Il fatto più importante consiste però nella conoscenza dei ciottoli dal 1626. È in quell'anno, infatti, che il gesuita spagnolo Pedro Simon parla delle «pietre incise dell'Ica» nel suo libro Noticias Historiales, che tutti possono consultare presso la Biblioteca nazionale francese.
Misteri di pietra
Ma veniamo ad altro. Il 9 febbraio 1856 il periodico The Illustrated London News riportava una stranissima notizia proveniente dalla Francia, poi ripresa dalla rivista inglese Fate del maggio 1964. Eccone la traduzione letterale:
«Scavando un tunnel della ferrovia tra St-Dizier e Nancy, si trovò un pipistrello gigante dall'apertura alare di 3,22 metri. L'animale era nero, lanciò grida e morì. Uno scienziato locale lo identificò come uno pterodattilo preistorico. Le rocce in cui l'animale fu scoperto risalivano ad oltre un milione di anni. Una cavità nella roccia corrisponde esattamente al corpo dell'animale».
Chiaramente la notizia è troppo sensazionale per essere accettata ad occhi chiusi, anche perché manca la sia pur minima documentazione. Se dovesse essere vera - azzarda Charroux - «potrebbe forse trattarsi di un caso d'ibernazione relativa di un animale preistorico nutritosi con l'acqua-madre delle rocce».
Esseri ritenuti scomparsi da epoche lontanissime sono stati rinvenuti, viventi, ma non certo in quelle condizioni, dal Coelacanthus (che si credeva estinto da almeno 500 milioni di anni) al Vampyroteuthis infernalis e al «mollusco di Panama» (considerati estinti rispettivamente da 170 e 300 milioni di anni) ed altri ne stanno affiorando dalle profondità oceaniche.
Si è, poi, andati alla ricerca di mostruose creature preistoriche segnalate in luoghi pressoché inaccessibili, senza successo.
Ora, noi non vogliamo assolutamente sostenere che i giganteschi eredi di una fauna estinta si aggirino ancora in giungle inesplorate, savane e ghiacciai, ma è fuori dubbio che esemplari del mondo animale preistorico furono raffigurati dall'uomo in epoche remote. Abbiamo citato alcuni esempi clamorosi in un nostro precedente lavoro ed a questi vanno aggiunti moltissimi reperti del dottor Cabrera, in cui sono chiaramente disegnati dinosauri, branchiosauri, tylosauri, pterodonti, tirannosauri, brontosauri, protoceratops, stegosauri, styracosauri e parecchi altri esseri che popolarono la Terra in tempi in cui l'uomo - ci dice la scienza tradizionalista - non esisteva ancora.
Invece l'uomo esisteva già o (se la vogliamo mettere al contrario) molti rappresentanti della fauna preistorica esistevano ancora. Come potrebbe essere stato altrimenti se l'uomo stesso non ha mancato di graffire e di scolpire questi «mostri», se ha lottato con loro?
Un'affermazione gratuita? Andremmo cauti ad affermarlo se, alle testimonianze riportate nel lavoro citato, aggiungiamo la chiarissima riproduzione, sulle «pietre di Ica», di uomini in lotta con giganteschi sauri, e se teniamo conto di un'indiscutibile prova: le ossa di un toxodonte (un grosso erbivoro che dovrebbe essere scomparso 3-4 milioni di anni fa) su quelle di un essere indubbiamente umano, scoperte in Sudafrica.
Stranissimo è il fatto che tra i reperti del dottor Cabrera troviamo, con le raffigurazioni di creature preistoriche, quelle di animali che - come l'uomo - sarebbero dovuti comparire parecchio tempo dopo, e non tutti in America: struzzi, canguri, pinguini, aironi, pipistrelli, cammelli ed altri ancora.
«Toccherà agli specialisti risolvere la faccenda, se lo potranno», sorride lo studioso di Ica. «Il fatto che certe incisioni rappresentino l'attacco di un uomo ad uno stegosauro potrebbe significare che qui, in Perù, le condizioni ecologiche che hanno permesso la vita di animali detti preistorici si sono mantenute fino a tempi molto più recenti di quanto sia accaduto in altre regioni del globo».
Non soltanto in Perù, a quanto pare: graffiti di questi enormi rettili sono stati reperiti in Amazzonia, mentre nell'Unione Sovietica, a 30 chilometri da Baku, riferisce Charroux, «si leva una roccia tagliata in forma di dinosauro. I geologi, scartata l'ipotesi di un'erosione naturale, pensano trattarsi di un'opera umana risalente a circa 10 mila anni fa, ossia a 50 milioni di anni dopo la scomparsa della specie rappresentata».
E le sorprese non sono finite. Ma una delle più straordinarie resta quella di Acambaro, in Messico.
Capitolo III - Viaggi nel passato: Civiltà sconosciute
Un giorno del 1945 un commerciante di chincaglierie tedesco, Waldemar Julsrud, percorreva a cavallo, assieme al suo collaboratore indigeno Odilon Tinajero, le pendici delle colline che formano i primi contrafforti della Sierra Madre, presso Acambaro (160 chilometri a nord di Città del Messico, sulla strada di Celaya) quando vide affiorare da una scarpata un oggetto rossastro. Credette trattarsi di un vaso, scese da cavallo e lo estrasse senza il minimo sforzo.
Notò, con sorpresa, trattarsi di una figurina, e si chiese se nei dintorni ne esistessero altre. Ne parlò a Tinajero, il quale promise di cercare: il tedesco era curioso, colto, appassionato di archeologia, e si trovava proprio nella terra un tempo abitata dai Taraschi, una delle più enigmatiche popolazioni messicane dell'antichità.
Di là a qualche giorno l'indigeno tornò con una carriola carica di 38 statuette fra le più strane che fossero state mai viste.
«Le figurine di ceramica», nota Charroux, «rappresentavano animali fantastici, che il tedesco riconobbe come dinosauri, brontosauri della fine del Secondario. Ma c'erano pure dei rettili (molti serpenti), cammelli, lucertole, personaggi estremamente diversi per i volti, le espressioni, la statura, i vestiti, le forme.
«Ma - e questa è la cosa più sorprendente - qualche ceramica raffigurava esseri umani, soprattutto donne, riconoscibili dai loro seni prepotentemente eretti, che parevano giocare con specie di coccodrilli, di mesosauri o di stegosauri (275 milioni e 60 milioni di anni), oppure con serpenti. Incontestabilmente persone e animali vivevano in buona armonia e sembravano dare una dimostrazione di quella che era l'Età dell'oro dei poeti».
Julsrud aveva dunque scoperto una straordinaria civiltà messicana del tutto sconosciuta, assolutamente non collocabile tra quelle, sia pur numerosissime, proprie al paese, una civiltà i cui tipi, inoltre, erano diversissimi gli uni dagli altri.
Elettroni nel passato
L'archeologo improvvisato diede l'incarico a Tinajero e ai suoi due figli di cercare altre statuette. Se ne rinvennero 32mila, costituenti la più grande e la più strana collezione del mondo. Alle ceramiche si unirono le pietre, la giada, l'ossidiana, alle immagini singole e a coppie scene con più personaggi.
Ancora una volta si gridò al falso ed ancora una volta le accuse caddero dinnanzi al numero di oggetti e ad altre considerazioni: come avrebbero potuto, ad esempio, il messicano e i suoi rampolli - capaci appena di leggere e di scrivere, senza nozioni scientifiche, privi di attitudini artistiche - fabbricare una raccolta del genere? Per metterla insieme, poi, sarebbero occorsi, come fu calcolato, con tre persone, almeno 300 anni!
Malgrado queste elementari considerazioni, le dispute continuarono, finché nel 1972 tre figurine giudicate false dall'archeologo Di Peso vennero analizzate con il metodo della termoluminescenza nei laboratori statunitensi del Pennsylvania Museum.
La loro età risultò identica: 2.500 a. C.
«Siamo stati tanto particolarmente interessati da questa data straordinariamente antica», scrisse il 13 settembre 1972 il dottor Froelich Rainey al signor Arthur Young, il quale gli aveva affidato le figurine, «che il signor Mark Han, dei nostri laboratori, ha eseguito in media diciotto controlli su ogni campione, il che rappresenta un test dei più seri. Le tre figurine hanno dato esattamente la stessa età (2.500 a. C.). I laboratori sostengono questa datazione per la collezione di Julsrud».
Che cos'è il metodo della datazione mediante termoluminescenza? Ascoltiamo ancora Charroux:
«È stato constatato che diverse radiazioni cosmiche sono integrate da materiali cristallini e segnatamente da quelli che entrano nella composizione del vasellame. Quando una ceramica subisce gli effetti di una radiazione cosmica si producono modificazioni strutturali al livello della corona di elettroni componenti l'argilla. Ora, si è scoperto in laboratorio un procedimento per studiare gli elettroni che, nuovamente perturbati, emettono una quantità di luce proporzionale a quella ricevuta dalla radiazione originale».
Di qui i calcoli relativi alla quantità delle radiazioni stesse e la datazione. Ma Charroux osserva che il cosmo non è il solo a «giocare con gli elettroni dei corpi cristallini», che a tanto contribuiscono anche molti fenomeni terrestri, tra cui, primo, quello della radioattività, concludendo che il metodo in discorso non è molto più preciso di quello del carbonio 14.
Comunque stiano le cose, è certo che la collezione di Julsrud non è un insieme di falsi e che i reperti risalgono a circa 4.500 anni fa.
Ma 4.500 anni fa non esistevano più da tempo dinosauri, brontosauri e compagni. Anche ammesso che qualcuno fosse sopravvissuto, una varietà come quella espressa dalla raccolta messicana è impensabile.
E allora? Non c'è che una spiegazione: gli autori delle figurine devono aver copiato opere precedenti, non ancora scoperte, oppure di cui si è persa ogni traccia.
Ma sul fatto che l'uomo sia convissuto con gli enormi sauri di cui la scienza «ufficiale» assicura l'esistenza molto prima della sua comparsa, non esistono dubbi.
Umani ma non troppo
In alcuni dei petroglifi di Ica esaminati e fotografati da Charroux si notano strani esseri che non sono certo del tutto uomini: nella scena dell'attacco al dinosauro, ad esempio, in cui si scorge una di queste creature travolta dal bestione, ed in una di quelle del parto, dove l'operatore è assistito da un piccolo individuo con scaglie dorsali. Graffiti in un ciottolo, poi, se ne stanno accoccolate di fronte a due specie di «primati» con un corpo simile al nostro, una lunga coda e la testa che ricorda quella dei sauri.
Lo studioso francese si chiede, di conseguenza, se in tempi antichissimi non siano esistiti esseri - poi estinti - a mezza via tra l'uomo e i sauri stessi, e conclude che tanto non dovrebbe essere escluso a priori, dato che creature semiumane sono vissute anche in epoche molto posteriori ed in tempi vicini ai nostri.
Non possiamo fare a meno di accostare a queste constatazioni quelle che riguardano la favolosa collezione di Guanajato, comprendente, fra l'altro, animali preistorici che, stando ai dati «ufficiali», dovrebbero essersi estinti da oltre 70 milioni di anni.
«Al centro di una piastra», scrive Jacques Ber-gier, «si vede una specie di dinosauro, a sinistra un plesiosauro e, tra le due figure, una maschera somigliante a quella delle Gorgoni elleniche. Sul raggio superiore si trovano elefanti, all'estrema destra si scorge una figurina che richiama l'Estremo Oriente antico. In più c'è una fila di mummie [...]. Abbiamo, poi, animali favolosi, le cui caratteristiche anatomiche sono curiosissime. Alcune forme umanoidi hanno lingue biforcute, mani e piedi palmati».
Secondo il paleontologo argentino Fiorentino Anneghino, vissuto nel secolo scorso, il primo essere eretto sarebbe stato sudamericano. Egli lo battezzò Homunculus patagonicus, affermando che da lui si sarebbero staccati due rami distinti, quello umano e quello delle scimmie antropomorfe, con una serie di «anelli» in seguito estinti, i Prothomos.
Sia che si accetti o no la teoria di Ameghino, la presenza nel passato di creature che la scienza tradizionalista tenta faticosamente d'inquadrare (senza riuscirvi) nella cornice dell'evoluzione qual è da essa concepita, è indubbia.
C'è chi asserisce che strani esseri, i quali potrebbero venir considerati, in apparenza, lontanamente imparentati con noi esisterebbero ancora, sia pure ridotti a pochi esemplari, o sarebbero esistiti sino a poco tempo fa.
Da Tahiti, lo studioso Yves Morel assicura che sulle alte montagne del Vietnam del Sud vive un popolo di uomini villosi con una testa enorme, mani e gambe molto grosse. Sono ancora cannibali e temuti dai Mois. Tutti questi selvaggi hanno la colonna vertebrale terminante con una piccola coda lunga da 3 a 5 centimetri. Un amico vietnamita di Morel abitante a Papeete ha visto parecchi di questi esseri che, catturati dai Mois, hanno lavorato nella piantagione di sua madre.
Nel 1953, nelle vicinanze di Trelak (oggi Malaysia Occidentale) decine di persone osservarono tre strane creature zannute, d'aspetto semiscimmiesco, con un volto pallido e liscio e le capigliature lunghe fin quasi alle reni, mentre qualcuno afferma che in Sri Lanka (Ceylon) sopravvive ancora qualche sparuto discendente dei Nottaewo, timide «scimmie» dal viso quasi umano, rossicce, che si ritengono generalmente estinte dalla fine del XVIII secolo.
Insomma, i mostri non mancano, in ogni tempo e in ogni luogo, dai piccolissimi Pùu, «scesi da un altro mondo a frugare nelle viscere della Terra» ed a scavare, secondo la leggenda, le fantastiche grotte di Loltùn, nello Yucatan, ai giganteschi ciclopi, dagli gnomi e dai folletti nordici agli yeti asiatici ed americani, al misterioso essere «venuto dal freddo», rinvenuto in un blocco di ghiaccio nel Mare di Bering, studiato dal famoso professor Heuvelmanns, dell'Accademia delle scienze belga, da noi a suo tempo esaurientemente descritto, disegnato e fotografato.
A proposito di questa creatura (alta 1,80 m, battezzata familiarmente «Bozo», ufficialmente Homo pongoides, finita in un istituto scientifico statunitense) non si è mai più saputo nulla dal 1969. Senza dubbio sarà stata estratta, scongelata, esaminata, si sarà tentata una sua classificazione.
Ma perché questo silenzio mantenuto su un essere sicuramente assai più importante dell'irreperibile «uomo delle nevi», un silenzio che non giova certo al progresso scientifico?
Che qualche pontefice del sapere tema di veder traballare, sotto le poderose braccia di Bozo, le sue intoccabili teorie?
Non possiamo affermarlo, ma neppure negare che qualcuno è stato sfiorato dal dubbio.
Tempo di Apocalisse
L'ipotesi di Much secondo la quale il diluvio universale sarebbe stato causato da un asteroide precipitato sul globo è attendibilissima: è stato infatti calcolato che una meteorite con 50 chilometri di diametro che cadesse al largo di Capo Verde provocherebbe un raz di marea capace di sommergere le installazioni portuali dell'Atlantico, determinando un cataclisma che sconvolgerebbe l'intero pianeta e potrebbe portare allo spostamento dei Poli, il cui equilibrio (specie quello del Polo Sud) non è molto stabile. Oltre i 100 chilometri di diametro, il diluvio universale sarebbe assicurato.
Per nostra fortuna, attorno alla Terra non circolano planetoidi tanto grandi. L'astrofisico S. T. Butler, dell'università di Sydney, espresse il timore, con alcuni suoi colleghi, che uno di essi, Icaro, potesse entrare, nel 1968, in collisione con la Terra stessa. Non accadde nulla, ma se l'evento si fosse verificato, si sarebbe già avuta una catastrofe inimmaginabile. Icaro non è molto grande, ma il suo impatto sarebbe stato pari alla potenza esplosiva di mille bombe H.
Com'è noto, alcuni asteroidi hanno orbite molto bizzarre. Ecco quelli che, con Icaro, circolano nelle vicinanze del nostro pianeta:
Hermes, del diametro di 1.200 metri, Adonis, di forma oblunga, 400 metri di lunghezza, Amor, uno scoglio roccioso di qualche centinaio di metri,
Eros, simile ad un peso da sollevamento, lungo 40 chilometri.
A questi corpi celesti si aggiunge la tanto temuta cometa di Halley, che ripasserà nei nostri paraggi nel 1986, ma sulla consistenza della quale esistono parecchi dubbi.
Sino al 1967 si supponeva che l'ultima glaciazione terrestre, quella di Würms, dovesse essersi scaglionata, con uno scioglimento molto lento, da 100 a 150 mila anni.
Il quadro, però - nota Charroux - venne totalmente cambiato dalle recenti osservazioni di grandi glaciologhe, come S. Jelgersma, V. Romanovski ed A. Cailleux, le quali condussero all'accertamento dei seguenti fatti:
1 - L'ultima fusione dei ghiacci si produsse circa 12 mila anni fa;
2 - Fu estremamente brusca e verosimilmente causata da un urto contro il nostro globo o, comunque, da un fenomeno cosmico di grande portata;
3 - Il disgelo ebbe un carattere universale, tutti i ghiacciai polari si fusero nello stesso tempo. Il globo terrestre venne spazzato, sconvolto da gigantesche mareggiate.
Tanto contribuisce appunto, con le restanti considerazioni, ad appoggiare la tesi di Much, come pure la sorreggono le prove scientifiche portate a dimostrare che 12 mila anni or sono la velocità di sedimentazione nei fondali marini diminuiva considerevolmente, mentre un brusco cambiamento di clima colpiva tutto il pianeta.
Atlantide scompariva, le Ande venivano sbalzate alla loro attuale altitudine, si formavano le cascate del Niagara e (come hanno permesso di constatare gli ultimi sondaggi) nella fossa marina di Cariaco, 350 chilometri ad est di Caracas, nel Venezuela, il fondale emergeva a vedere il Sole.
Pochi furono gli uomini scampati al diluvio universale, e non certo tali da poter dare un rapido impulso al risorgere della civiltà: gli abitanti delle alte zone montane (in genere pastori, cacciatori, boscaio-li) e coloro i quali vi approdarono a bordo di alcune imbarcazioni.
Mentre il Noè biblico si salvava sull'Ararat, Xisuthrus, in Caldea, riparava sul monte Korkoura, il Manu degli Indù sui pianori dell'Himalaya, Bochica, nell'America del Sud, sull'altipiano delle Ande e Coxcox, uno dei Noè messicani, nella Sierra Madre. Gli indiani dell'America del Nord parlano delle Montagne Rocciose, le tribù africane dell'acrocoro etiopico. Ora, tutte queste regioni hanno picchi che superano i 4.000 metri di altitudine.
Non sarà inopportuno notare che elefanti sorpresi dal brusco innalzamento delle terre sono stati rinvenuti, congelati, a 4.000 metri sul livello del mare in Asia Centrale, mentre i cavalli (che si ritenevano un tempo importati in America dagli europei) si sono dimostrati preesistenti alla «conquista», estinti del tutto forse in seguito al diluvio. In alcune pitture rupestri delle alte Ande, a Kelkatani, si vedono cavalli risalenti a circa 10 mila anni fa. Forse furono diluviani, o gli ultimi sopravvissuti alla catastrofe.
Alcuni studiosi (ormai pochi) «nemici del diluvio universale» sostengono che esso non ha mai avuto luogo perché il cataclisma (pur citato abbondantemente dagli Indù, dai Babilonesi, dai Caldei, dagli Ebrei, dai Nordeuropei, dagli Amerindi e da altre popolazioni del globo, come abbiamo visto) non è ricordato, dagli Egizi, presso i quali si trovano soltanto accenni mitologici, attinti probabilmente da altre civiltà o da catastrofi locali.
Ma la ragione di questo silenzio è molto semplice, poiché la valle del Nilo ha solo 12 mila anni, è, cioè, postdiluviana: prima di quel tempo il fiume non si gettava nel Mediterraneo.
Dopo il disastro nacque così, circa 8 mila anni fa, una delle più grandi civiltà del periodo storico, fondata probabilmente da genti provenienti dall'acrocoro etiopico e dai superstiti di Atlantide che, approdati fortunosamente ai nuovi lidi, apportarono alla cultura in embrione il prezioso retaggio dei loro ricordi, così come fecero, in condizioni però assai più dure, dati gli ostacoli frapposti dalla natura, gli scampati sulle opposte sponde oceaniche. Perché l'ascesa fu tanto lenta? Perché i superstiti furono pochi e non certo in grado di sfruttare in buona parte le realizzazioni delle culture precedenti.
Immaginiamo che ad un futuro cataclisma sopravvivano alcune migliaia di sovietici e di americani: tra loro non si troveranno, ovviamente, molti scienziati e tecnici. E che cosa potranno fare questi pochi su una terra devastata, se non descrivere ai figli le meraviglie della radio, della televisione, degli aerei, dell'energia atomica, delle cosmonavi?
Con il succedersi delle generazioni, poi, anche queste conoscenze andranno perdute o distorte in miti e leggende.
È ancora Charroux a prospettare l'idea che il diluvio universale sia stato ricordato pure in America non solo attraverso tradizioni e leggende, ma anche con chiare raffigurazioni, una delle quali incisa sulla pietra detta «degli astronomi» appartenente alla collezione di Ica.
Ecco gli elementi che - secondo lo scrittore francese - emergerebbero dal petroglifo:
- Due persone intente a studiare un importante fenomeno celeste per mezzo di un telescopio.
- Un oggetto volante diretto verso il cielo.
- Delle comete (almeno tre) provenienti da un firmamento sconvolto.
- Stelle che brillano di uno splendore insolito. Alcune sono enormi, mentre altre, senza dubbio più lontane, sembrano estranee allo scompiglio cosmico.
- Un'immensa nuvola che, con striature orizzontali simboleggianti la pioggia, segue la coda di un'enorme cometa. Piogge diluviali precipitano probabilmente sulla Terra.
- Continenti (riconoscibili dai loro tratteggi e dalle loro curve) semisommersi da questo diluvio, tanto da rassomigliare ad isole.
- Una stella precipitata su un vasto continente o una grandissima isola.
- Come motivo dominante, un'imbarcazione naviga sull'oceano celeste o terrestre, portando a bordo tre personaggi, forse scampati al cataclisma.
«Quest'ultima spiegazione può sembrare arbitraria, soggettiva», precisa Charroux, «ma è irresistibilmente suggerita dall'imbarcazione, dall'oceano, dalle stelle, dalle isole e dalle comete».
Tali raffigurazioni si riferirebbero ovviamente all'ultimo diluvio universale, quello verificatosi, secondo Much, nell'8496 a. C., secondo altri da 11.500 a 12.000 anni fa.
In precedenza il nostro globo aveva senza dubbio subito terribili sconvolgimenti che ne avevano mutato l'aspetto. Ebbene, il dottor Cabrera ritiene che altre due pietre di Ica riproducano il volto della Terra nell'era secondaria. In una, ad est delle due Americhe si scorge Atlantide, ad ovest Mu, i continenti sommersi, nelle loro forme primitive, mentre nell'altra sarebbero visibili l'Europa, l'Africa, l'Asia-Lemuria e l'Australia.
Le strane linee serpeggianti visibili in entrambi i petroglifi segnerebbero, poi, correnti marine o rotte intercontinentali.
Del diluvio parla in questi termini un'opera del gesuita Anello Oliva, «Vita degli uomini illustri della Compagnia di Gesù del Perù», scritta nel 1631 e tradotta in francese nel 1957 da H. Ternaux Compans:
«Catàri racconta che, dopo il diluvio universale, del quale gli Indiani avevano una perfetta conoscenza e che chiamavano pachacuti, i primi uomini che vennero in America, sia di proposito, sia spinti dalla tempesta, approdarono a Caracas, dove si moltiplicarono, diffondendosi in tutto il Perù».
Prima di questi uomini, però, qualcuno doveva aver abitato il continente, lasciando tracce non indifferenti.
«Manco, spaventato dalla tempesta», prosegue la narrazione, riferendosi a Manco Capac, il mitico fondatore della dinastia degli Incas, «risoluto a non andare più lontano di Yca ed a penetrare di là, nell'interno delle terre... [interruzione]
«I suoi compagni lo scoprirono più tardi in una spaziosa caverna del lago Titicaca, scavata da mani umane. Le pareti erano ricoperte da ornamenti d'oro e d'argento, e non vi si penetrava che attraverso una porta strettissima... [interruzione]
«Per riconoscersi, i compagni di Manco si forarono le orecchie e vi misero grossi anelli di una specie di giunco chiamato aotora (aotora = totora = giunco). Questa pratica sembra aver dato origine alla casta degli Orejones ("grandi orecchie").
«Manco uscì un mattino dalla caverna, al sorgere del sole, in un abito fatto di placche d'oro, e non stentò a farsi riconoscere come re.
«Fu così che fondò la monarchia degli Ingas [Incas]».
Il diluvio, Ica, il Titicaca, con quello che ha tutta l'apparenza d'essere un ricettacolo dei tesori della leggendaria Tiahuanaco: non è un po' troppo per trattarsi di un seguito di coincidenze messo insieme secoli prima che i più audaci investigatori della scienza se ne occupassero?
Capitolo IV - Viaggi nel passato: Ipotesi extraterrestri
Quelle che in Perù si chiamano pampas non hanno niente a che vedere con le sterminate distese verdi argentine: da Lima ad Arequipa non sono che desolate piane di sabbia e pietrame: deserti, insomma, senza traccia di vegetazione e di vita animale.
Nessuno senza l'intervento dei primi, appassionati studiosi, ne avrebbe mai parlato, eppure questi deserti comprendono una serie di sbalorditivi, titanici atlanti dal significato tanto misterioso quanto importante nella storia dell'umanità, da disegni straordinari a «piste» smisurate.
Nel 1973 non troviamo ancora in un solo manuale di archeologia il minimo accenno a queste meraviglie che si stendono tra il Pacifico e la Cordigliera delle Ande, nelle pampas di Villacuri, a sud di Pisco, di Los Castillos, di Huayuri, di Colorada e di Los Corados, tra Ica, Palpa e Nazca, ovvero nella Pampa Jumana, ora Pampa San José.
Eppure gli aviatori delle linee interne conoscevano benissimo da tempo gli strani tratti, ma la loro professione faceva ovviamente sì che li sorvolassero senza attribuirvi grande importanza. Da terra, d'altra parte, non si potevano scorgere che linee senza apparente significato: ed è ovvio, poiché i disegni, nella loro completezza, non sono visibili che da centinaia di metri di altezza.
Poi venne il giorno in cui qualcuno vi attirò l'attenzione, ed i rappresentati più intraprendenti nello studio del passato si mossero.
Primo fu, nel 1939, il professor Paul Kosok, della università di Long Island, assieme al suo assistente John Harward, a studiare sistematicamente le tracce. Poi, verso il 1948, fu l'archeologa Maria Reiche, dell'università di Amburgo, ad occuparsene, pubblicando anche un libriccino illustrato, finché il servizio fotografico del Ministero dell'Aria peruviano decise di effettuare rilievi precisi dei disegni.
Suggestive illustrazioni furono presentate in seguito, e tra queste va ricordata la ricchissima documentazione raccolta dai fratelli Adriano e Damiano Zecca ed anticipata in parte, con altri affascinanti enigmi dell'America precolombiana, in un loro volume. Per chi vuole fare una capatina in quella che è una delle più appassionanti ed enigmatiche zone archeologiche del mondo, l'impresa è, da pochi anni, un po' meno complicata: sul posto esiste un albergo, con una torre alta una decina di metri, che consente la visione di due disegni vicini.
Occorre prendere un Piper e salire 200-300 metri per avere un panorama discreto ed osservare in particolare un certo numero di tracciati, ma solo a 700-800 metri ci si può rendere conto - o quasi - di tutta la grandiosità dell'opera.
Ecco la splendida descrizione di Charroux: «Nella Pampa Colorada hanno inizio le grandi linee (13mila) che in tutte le direzioni, scalando o scendendo pendii, burroni, montagne e barancos, si perdono all'orizzonte, secondo un tracciato rigorosamente rettilineo.
«Nemmeno in aereo, da mille a duemila metri, si distingue, generalmente, la fine di queste linee, stando l'inizio, per noi, all'orlo della valle del Rio Ingenio. Tuttavia numerose linee mettono capo a "piste" oppure, più di rado, finiscono in un centro
comune dal quale si dipartono come i raggi di una ruota o i raggi del Sole.
«Si vedono migliaia e migliaia di linee di diversa lunghezza, tracciate in ogni possibile direzione, da Nord a Sud, da Est ad Ovest e verso tutti gli altri punti della rosa dei venti. Esistono linee particolarmente lunghe e piste di larghezza differente, da 3 a 100 metri ed oltre.
«Tutto è impeccabile, tirato a filo, perfettamente triangolare o rettangolare e, anche se si distingue qualche raro arrotondamento, esso è tracciato con straordinaria maestria, da cui emerge come il disordine non sia che apparente. Ci è incomprensibile, certo, ma per cervelli diversamente condizionati dai nostri deve avere una spiegazione, una logica. [...]
«I tracciati di Nazca sono opera di un popolo notevolmente civile, provvisto di uno spirito geometrico eccezionale, un popolo molto antico, anteriore a quello degli Incas, probabilmente della stessa razza dei costruttori della Porta del Sole in Bolivia e degli osservatori astronomici dell'America precolombiana».
Lasciate le piste, eccoci ai grabados, agli strabilianti disegni del deserto di Nazca. Ne sono stati contati sino ad oggi (1980) 788, con oltre 100 spirali.
Le figure che, in particolare, vengono mostrate dall'aereo ai turisti, sono quelle del ragno, la cui struttura fa pensare ad un aracnide preistorico, della scimmia lunga un centinaio di metri con un'enorme coda arrotolata a spirale, di un condor ad ali spiegate (180 metri) ed un uccello in cui alcuni vedono la gigantografia di un colibrì: il suo becco misura 100 metri.
Ma accanto a queste rappresentazioni, indubbiamente affascinanti, esiste una quantità di altri bellissimi e talvolta stranissimi disegni: cani, gatti, lama, uccelli, pesci, sauri, serpenti con più teste, animali sconosciuti, oggetti ignoti dalle forme indescrivibili.
Di certo si sa ben poco sulla data in cui i disegni sono stati tracciati. Un test al carbonio 14 ha dato un'età di circa 1.500 anni.
L'archeologo americano Gerald Hawkins sostiene che la civiltà di Nazca dovrebbe essersi sviluppata tra il 300 a. C. e l'800 d. C.
Date le particolarità di alcune figure, si potrebbe pensare ad un'epoca ben più remota: ma se la datazione è certa, non si può che formulare l'ipotesi di ricordi trasmessi attraverso innumerevoli generazioni.
I disegni di Nazca non sono gli unici ad essere osservabili soltanto dall'alto. Ne troviamo un po' in tutto il mondo, ed un elenco quasi completo, con descrizioni e commenti, richiederebbe un grosso volume. Accontentiamoci, quindi, di una panoramica su alcuni tra i più suggestivi.
Ancora in Perù, nella Pampa di Villacuri, circa 30-40 chilometri a sud-sud-est di Pisco, si vedono figure rappresentanti un uomo, un lama e un condor. Appartengono ad un altro stile, e quindi non alla cultura di Nazca. È impossibile esaminarle da vicino, perché non esistono né strade né piste. Ma si tratta, poi, di un lama? La lunga coda fa pensare piuttosto ad uno strano animale di quelli che si trovano sulle pietre del dottor Cabrera, mentre la stilizzazione del «condor» induce ad altre ipotesi circa la natura del volatile.
Nel deserto di Atacama, che si stende lungo la costa cilena per circa 600 chilometri, viveva un tempo una popolazione dispersa nei luoghi dove una polla d'acqua le dava modo di sostentarsi miseramente. È dovuto a queste genti il disegno detto del curaca (stregone o sovrano), che, lungo circa 120 metri, è solo visibile dall'alto. Si tratta della rozza sagoma di un uomo con il capo sormontato da una specie di corona con tre denti o tre piume. Dalle tempie e dalle guance si dipartono otto grandi linee parallele simboleggianti senza dubbio la sua origine sacra, solare. Nella mano destra tiene qualcosa che potrebbe essere una fionda, nella sinistra un'ascia.
Un'altra figura, tracciata sulla collina Unitas, alta pure 120 metri, sembra rappresentare un gigante con una tromba (o qualcos'altro che, allungato, si diparte dal suo viso) ed una piccola creatura che gli si aggrappa al braccio e che gli giunge appena dal gomito ai fianchi. È stata denominata appunto «il gigante con la tromba», ma c'è chi, per la sua struttura rigidamente geometrica, per le mani simili a tenaglie, per le incomprensibili sporgenze al capo, al bacino e alle ginocchia, lo ha ribattezzato «il robot gigante».
Sempre sul Cerro Unitas, sul versante occidentale, si scorge un gigante simile al curaca di Atacama: la sua destra è tesa in direzione del Perù, la sinistra impugna un bastone o un'ascia; accanto gli sta un animale che potrebbe essere un sauro, una lucertola o un'iguana.
Numerosi altri disegni di proporzioni notevolissime sono visibili in Cile: per questi rimandiamo gli appassionati alle importanti opere dei professori Lautaro Nunez Atencio, Hans Niemever e Lotte Weisner.
In California, è incisa nel deserto, presso Blythe, una figura umana dal torso stranamente rettangolare, dagli arti lunghi e sottili. Spirali identiche a quelle di Nazca sono state rinvenute un po' ovunque nell'America nordoccidentale ed altre sono state scoperte in Siberia dall'ingegnere e pilota tedesco August Steimann.
Quanto ai giganteschi, bellissimi disegni britannici, le loro descrizioni e le loro fotografie si trovano in «Italia, mistero cosmico».
Archivio stellare
Ma come vennero eseguiti questi disegni e, in luogo principale, quelli di Nazca, che sono senza dubbio i più famosi?
Con molti altri studiosi, l'ingegner August Steimann pensa che siano stati tracciati per essere visti dall'alto. L'aviazione, ci dice (e lo vedremo in seguito), è più antica di quanto si creda.
Steimann, pilota durante la seconda guerra mondiale, affaccia l'ipotesi che gli autori dell'opera ed i suoi ammiratori si siano serviti di rudimentali alianti, mentre altri si orientano verso gli aerostati. I primi tra i sostenitori di questa teoria furono Jim Woodman e Julian Knott, che imitarono i presunti antichi aviatori peruviani sorvolando con un pallone (il «Condor 1») le pampas di Kawachi il 28 novembre 1975.
La domanda più appassionante che si pone l'archeologia a proposito di Nazca concerne, ovviamente, gli scopi per cui furono tracciati gli enormi disegni.
Alcuni studiosi li vogliono specie di ex voto o di suppliche rivolte alle divinità per una buona caccia, un buon raccolto, com'è il caso di parecchie incisioni preistoriche, ma l'ipotesi non è sostenibile: chi si sognerebbe, infatti, bottini di ragni, di lucertoloni, di scimmie, e ricche coltivazioni di strane margherite?
Un ragionamento analogo vale per chi parla di raffigurazioni di dei. Perché, poi, i disegni sarebbero stati fatti in un luogo che è sempre stato deserto? Come avrebbero potuto ammirarli i fedeli, se dal basso non si scorgono, come abbiamo detto, che vaghe linee terminanti chissà dove?
E, infine, a che cosa sarebbero servite le piste?
C'è chi opta per l'astronomia, dicendoci che gli ignoti autori avrebbero rappresentato, con simboli diversi dai nostri, pianeti, stelle, costellazioni.
Charroux non ne è affatto convinto. «Abbiamo studiato bene Nazca», scrive. «Linee e piste vanno in ogni possibile direzione e non c'è che l'imbarazzo della scelta per decidere di aver preso di mira Sirio o Venere, Marte o Aldebaran».
La dottoressa Maria Reiche, tuttavia, è del parere che si tratti di un gigantesco calendario astronomico in cui ogni geroglifo designerebbe una sequenza, sia un solstizio che il tempo delle piogge, della semina, del raccolto e così via.
Un altro studioso delle linee e dei disegni, padre Alberto Rossel Castro, ritiene che la grandiosa opera vada divisa e classificata in quattro gruppi principali:
I - Linee costituenti sia un progetto d'irrigazione che di spartizione agraria.
II - Apachitas o tumuli. Il vocabolo «tumuli» sta a significare, in archeologia, un ammucchiamento di sassi, in genere posto su una tomba. Qui sotto non si trovano, però, ossa umane: soltanto uno cela lo scheletro di un vizcacha, un roditore americano che potrebbe essere stato sacrificato al dio del Cerro Bianco.
III - Stilizzazione di arti tessili e coreografiche, destinata a simboleggiare le danze eseguite al tempo del raccolto con gli abiti portati in quest'occasione da uomini e donne.
IV - Parte di un osservatorio astronomico: qui le conclusioni del dottor Rossel Castro coincidono con quelle a cui erano pervenuti il dottor Kosok e la dottoressa Reiche.
L'archeologo peruviano dottor Toribio Mejia Xesspe propende per strade ed indicazioni di carattere religioso congiungenti vari luoghi sacri, mentre il dottor Manasses Fernandez Lancho, medico e docente universitario, considera l'opera come un compendio del pensiero filosofico e cosmico dei suoi autori.
«I Nazca», così ne riassume il pensiero il professor Josue Saul Lancho Rojas, che ci ha tratteggiato anche le altre ipotesi, «con i loro criteri comunistici, materialisti e dialettici, tracciarono, duemila anni prima di Darwin, il panorama generale dell'evoluzione della specie, dai protozoi all'uomo. Là, nelle pampas, giace la dimensione materializzata che vince il tempo e lo spazio.
«La cosa più sorprendente è che le figure suggeriscono l'anello possibile tra una specie e l'altra.
«Tutti i disegni sono stati eseguiti partendo dalla linea del solstizio, con il Sole come centro del tratto che va dalle Ande al mare, dal quale emergono tutte le specie conosciute sulla Terra. E tutte le specie appaiono unite da un cordone ombelicale che rappresenta l'energia solare (le linee che collegano le figure non sono state studiate da altri esperti).
«L'autore, nel suo semplice stile personale, ritiene che la volta celeste sia stata, per le culture occidentali ed orientali, la casa degli dei. Là viveva il Sole, il dio onnipotente che stabiliva i cicli della vita e della morte, con la Luna, causa di stupore e di paura con le sue fasi e le sue eclissi, le stelle, le costellazioni piacevoli da ammirare, capaci di consigliare quando necessario. E là vivevano anche le comete con le loro code splendenti, le nuvole che offrivano la loro pioggia gentile, i venti, i tuoni e i fulmini.
«Tutti gli dei vivevano "lassù", ed era proprio "lassù" il luogo a cui si levavano le preghiere, le offerte e i sacrifici. Questo meraviglioso mondo delle pampas potrebbe essere stato un santuario dove i Nazcas avevano disegnato tutti gli esseri del loro mondo, come per offrirli agli dei. Le figure avevano proporzioni gigantesche per essere viste dagli dei dal cielo: il fatto che la gente, qui sulla Terra, non potesse vederle bene, non importava».
Non mancano poi, naturalmente, le «ipotesi spaziali», secondo le quali le linee, le piste, i disegni di Nazca sarebbero stati segnali di un vero e proprio cosmodromo extraterrestre.
È un tema, questo, che va affrontato con estrema prudenza, una prudenza consigliata, tra gli altri, dall'archeologo Guillermo Illescas Cook, il quale inizia una sua opera sul vasellame peruviano e i disegni di Nazca con un ironico ringraziamento al defunto George Adamski per avergli aperto gli occhi ed averlo convinto della serietà degli studi da lui (Illescas Cook) portati a termine ed offerti agli appassionati in un suo interessante lavoro.
«La tecnica psicologica», scrive l'archeologo nella presentazione del suo libro, «gli consigliò che, preparato l'animo del lettore, gli avrebbe potuto ammannire la sua storia, proprio come procede il chirurgo per operare un paziente: prima lo anestetizza. Adamski anestetizza l'atteggiamento critico del lettore, per poi passare a dire che i dischi volanti (OVNI = UFO), di cui ci offre l'evidenza fotografica (leggi fotomontaggio) sono scesi con i loro equipaggi: uomini di bell'aspetto, dai capelli biondi, i quali, con segni e gesti, si pongono in contatto mentale con lui e gli fanno capire che vengono dal pianeta Venere. Non potrebbe essere diversamente, e con ciò la sua stessa fantasia lo denuncia: a maggior ragione, perché si sa che il pianeta Venere è avvolto da una spessa atmosfera, irrespirabile per il tipo di abitanti che descrive».
A proposito di Nazca, Illescas Cook propende, come altri suoi colleghi, per raffigurazioni astronomiche, e porta, a dimostrazione, alcuni disegni che potrebbero mostrarci le costellazioni rese con figure diverse da quelle adottate nel mondo mediterraneo ed ancor oggi definite con i nomi di un tempo. E le immagini sulle ceramiche (in molti casi corrispondenti a quelle del deserto) ne fornirebbero una conferma.
Ora, sappiamo benissimo che, prima e dopo Adamski, sfruttando l'ufomania, visionari e pazzoidi, speculatori e truffatori hanno imbastito tante e tali storie sui turisti cosmici, da fare rizzare i capelli a tutte le persone di buon senso, mentendo, bluffando, vestendosi da profeti di una «nuova» archeologia, guazzando negli stagni di ogni possibile travisamento scientifico.
Oggi le azioni di questi venditori di fumo (non sarebbe giusto omettere che alcuni - ma pochissimi - sono stati anche in buona fede) vanno fortunatamente calando, se non sono già crollate.
Non dobbiamo tuttavia neppure dimenticare che gli enigmi a cui ci troviamo dinnanzi sono spesso inquietanti e sembrano aprire la strada a deduzioni fantastiche. Tutto sta a vedere fino a qual punto sono davvero puramente fantastiche, senza lasciarci suggestionare né dai dogmi dei conservatori ad oltranza, né dai vaneggiamenti degli ufomani.
L'Universo palpita di vita, e la vita intelligente non vuole né ha mai voluto restare inchiodata sul suo mondo per l'eternità. Le nostre sonde vagabondano nel sistema solare. Domani andranno oltre: teoricamente ne hanno già la possibilità. Negare che altri, in passato, l'abbiano tradotta in pratica, è tanto assurdo quanto sostenere che gli sbarchi di marziani e venusiani hanno tuttora luogo o che noi siamo gli eredi diretti dei cosmonauti di Proxima Centauri, di Sirio, di Altair o di chissà dove.
I figli di Chimera
Nell'introduzione al suo libriccino su Nazca, parlando del Perù, Maria Reiche nota, giustamente: «Si sa degli Incas, dell'ultima dinastia dominante che, fino a poco prima dell'invasione spagnola, aveva sottoposto a tributi il paese intero, dalle montagne alla costa. Ma la dominazione incaica fu soltanto l'ultimo stadio di un lungo sviluppo culturale, i cui inizi risalgono al secondo millennio prima della nostra era [e c'è chi ritiene ancora anteriormente]. Non tutto è stato esplorato e non è stata detta l'ultima parola sugli uomini che da tempo hanno popolato il paese più fittamente di adesso.
«Ogni anno vengono alla luce nuove conoscenze, vengono scoperte sconosciute città preistoriche, fatti nuovi scavi. Ma tutto ciò infittisce spesso ancor più il mistero. È possibile, sì, distinguere diversi periodi, classificare secondo concentrazioni locali i vari elementi culturali, ma si vorrebbe sapere molto di più. Si vorrebbe sapere perché certi motivi delle incisioni e del vasellame si ritrovano in tutto il continente, fino all'America centrale. Si suppone che sia esistita una scrittura e si dispone in proposito di numerosi indizi.
«Un giorno tutto quanto si sa oggi verrà fuso con le conoscenze di un prossimo futuro in una sintesi grandiosa e si avrà una chiara immagine del passato di questo grande paese».
Lo speriamo di cuore. Intanto, però, come sottolinea Maria Reiche, gli enigmi si aggiungono agli enigmi. E la matassa è aggrovigliata quanto basta: le leggende e le tradizioni incaiche e preincaiche si mescolano, si confondono, i personaggi si trasformano, gli elementi reali, già distorti nel ricordo, si disperdono in decine e decine di versioni fiabesche.
Ognuna di esse ha senza dubbio un fondo di verità, ma come conciliare le innumerevoli piccole tessere disposte in mosaici diversi, come giungere a ricostruire quello originale?
Sentiamo il gesuita Anello Oliva descriverci lo sbarco dei primi Incas, guidati da Manco Capac. Ma lo stesso Manco compare sulla scena in modi differenti e le sue avventure conoscono numerosissime varianti, pur avendo punti in comune.
Nella narrazione più diffusa si vede una bella ragazza, Mama Ocllo, e suo fratello, Manco Capac, venire dall'Est, spediti sulla Terra da papà Sole, impietosito dallo stato miserevole in cui si trovano gli uomini, barbari, senza leggi e senza case, simili alle bestie.
Il loro compito di civilizzatori non era certo facile, e se ne dovettero subito rendere conto quando furono depositati sul lago Titicaca.
Non partivano, però, del tutto sfavoriti: il genitore aveva consegnato loro un magico bastone d'oro, con la raccomandazione di cercare, ogni tanto, di piantarlo nel terreno. Là dove fossero riusciti a conficcarlo senza grande fatica, sarebbe stato il luogo destinato a diventare la capitale di un grande regno.
Tanto accadde in una fertile vallata del fiume Urumba, a 3.300 metri sul livello del mare. E sorse Cuzco, l'«ombelico del mondo», futuro centro di Tahuantinsuyo, quella che noi chiamiamo terra degli Incas.
Tahuantinsuyo significa «quattro cantoni» e stava ad indicare un dominio esteso dal sud della Colombia al nord dell'Argentina, dall'Amazzonia al mare.
La data di nascita dell'impero incaico è sempre più in forse. C'è chi la fissa nel 494 d. C., chi punta sul 565, chi avanza fino al 1130, e non è finita. In ogni caso, si tratta di affermazioni discutibilissime, ed a confondere gli studiosi intervengono anche le sfasature delle leggende, a cui abbiamo accennato.
Com'è possibile che Mama Ocllo e suo fratello abbiano creato il vasto regno già fiorente in tutto il suo splendore alla presunta data del loro arrivo alla futura Cuzco? Come può Viracocha essere il dio bianco del Quechua (esistente, dunque, da tempi immemorabili), se la storia ci dice che fu l'ottavo imperatore a chiamarsi così?
È assai probabile che la tradizione sia stata deformata attraverso i secoli e che l'ottavo sovrano abbia assunto il nome della divinità. Nulla spiega, comunque, il fatto che affacciandoci alla storia del Perù ci troviamo di fronte ad una cultura già evolutissima. L'ipotesi che sia sbocciata così, improvvisamente, dal nulla, e che dal nulla abbia raggiunto in brevissimo tempo lo sviluppo che conosciamo, è ovviamente inammissibile. Non ci resta, quindi, che tentare un viaggio a ritroso nel tempo, alla ricerca di qualche altra traccia.
Sconfiniamo così nel fantastico, è vero. Ma dobbiamo ammettere che questa strada, pur se ci apre squarci da fantascienza, non è forse assurda come a prima vista potrebbe sembrare.
Non indugiamo a brancolare sulla pista dei romanzi utopici chiedendoci quale strano congegno elettronico possa essere stato il magico bastone d'oro, non soffermiamoci a cullare la supposizione (logicissima, d'accordo) che il Sole della leggenda sia la trasposizione del concetto di divinità ad una sua manifestazione tangibile.
Passiamo alle cronache, proviamo ad approfondire il significato dell'espressione «venuti dall'Est» riferita a Mama Ocllo ed a Manco Capac.
Da Levante, dal mare? Sicuro: le tradizioni che parlano di una specie di Eden «posto al di là delle acque» sono numerosissime in Colombia, in Perù, in Bolivia, in Brasile. Non è dunque difficile fantasticare di Atlantide, di una terra scomparsa i cui sopravvissuti approdarono alle coste atlantiche sudamericane. «Venivano dal paese delle montagne, dall'Olimpo del Sole e del Fulmine», ci dice un autorevole ricercatore sulla traccia di storie innumerevoli. «Venivano dal paese di Chimera, patria degli dei, culla degli astri, matrice della creazione».
I segni di un misterioso passaggio attraverso le misteriose foreste brasiliane sembrano essere evidenti. Julio Cesar Tello, il «padre dell'archeologia peruviana», scrive: «L'origine delle popolazioni andine va cercata nel cuore delle giungle amazzoniche».
Circa il termine «origine» non possiamo essere d'accordo. Il fatto che numerose comunità abbiano abbandonato l'inferno verde per cercare terre più ospitali sulla Cordigliera ci pare accettabilissimo, ma con questo non arriviamo certo alle proposizioni iniziali del problema.
Le vediamo delineate, piuttosto, in quanto ci hanno tramandato gli antichi cronisti. Garcilaso de la Vega, il più misurato, ci parla del XVII secolo: «Prima degli Incas vivevano i Collas, salvatisi dal diluvio universale». Huaman Poma de Ayala, pochi anni dopo, ci conferma che Manco e sua sorella furono «soltanto i capi della seconda dinastia, preceduti dagli Apo Capac, dominanti in tempi molto anteriori, subito dopo lo sconvolgimento che cambiò il volto della Terra».
Alla catastrofe si riferisce anche Castelnau, uno scienziato che, verso la metà del secolo scorso, diresse una spedizione mirante a fare luce sulle origini dell'impero incaico. Stando a lui, Manco Capac sarebbe stato «il discendente di uno dei grandi re di Tiahuanaco, Huyustus», deciso a «fare rivivere le leggi e il culto dei suoi antenati, scomparsi al tempo del diluvio, al quale seguì un lungo periodo di barbarie».
Del medesimo parere è una studiosa francese, Simone Waisbard, che identifica il personaggio in uno dei più famosi sovrani di Tiahuanaco, Mallcu Capac, sopravvissuto al cataclisma. Riferendosi al nome, che potrebbe destare perplessità, nota: «È difficilissimo trascrivere la lingua parlata dei Quechua in caratteri latini. Essi non pronunciano alcuna sillaba come la pronunciamo noi: basta consultare i primi vocabolari stampati del XVI secolo per rendersi conto della difficoltà di trascrizione. Una medesima parola non è mai scritta in maniera uguale da due autori. Sovente, anzi, non si riconoscono termini esprimenti lo stesso concetto».
L'identificazione del leggendario Manco in Mallcu ci sembra sostenibile anche sulle basi di moltissime leggende, deformate quanto si vuole, ma costruite su un nocciolo indubbiamente comune. Ed i richiami di questi racconti al diluvio sono troppo ricorrenti, troppo precisi per far pensare a pure favole.
Torniamo così ad Atlantide, vediamo nei suoi figli gli antenati dei Quechua, ma l'origine prima continua a restarci oscura. Potremmo forse sognarla con Eudoxio H. Ortega, che, dopo lunghe, meticolose ricerche, scrive:
«In tempi antichissimi vivevano i Variruna, esseri giganteschi, costruttori di enormi città, figli della Terra, creati dal loro dio Japallan Camayoc. Furono sterminati dagli Aucacuna, giunti dal paese dove nasce il Sole, e per punire questi ultimi Japallan Camayoc scatenò un tremendo cataclisma. Lampi e tuoni scossero le fondamenta del mondo, sussulti spaventosi lo sconvolsero e caddero grandi blocchi di grandine, distruggendo la vegetazione.
«Poi una pioggia che durò due lune annientò gli animali, le cui carogne imputridirono, dando luogo a spaventose epidemie. Infine le acque si ritirarono, formando vasti mari che prima non esistevano, sommergendo centri popolosi.
«Tutti gli Aucacuna morirono. Japallan Camayoc chiamò allora tre condor e disse loro di portare sulla Terra, per ripopolarla, tre coppie di un mondo lontano. Queste tre coppie furono deposte dai volatili a Pincosmarca e da loro discesero tutte le genti del continente andino. Per tale ragione esse adorarono il condor e scolpirono la sua immagine nella pietra».
La versione spaziale della leggenda si presenta qui ancora una volta con affascinante prepotenza. Condor o aquila, falco o sparviero, uccello del fulmine o uccello del tuono, il favoloso volatile si affaccia nei miti di tutto il globo. Ed in Perù lo vediamo più che altrove come trasfigurazione di un veicolo interstellare. Per quanto tendiamo a frenare l'immaginazione, come possiamo sottrarci alla suggestiva immagine di un'arca cosmica?
Non sappiamo né potremo mai sapere con chi vada identificato Japallan Camayoc. Forse è soltanto un pretesto per tradurre in termini mitologici l'impressione di un agente determinante esterno.
Gli abbagli e gli sbagli sono inevitabili. Impressionante è, tuttavia, il richiamo ad esseri venuti dallo spazio, che ritroviamo in altre tradizioni, raccolte da Elisée Reclus e riassunte dalla signora Waisbard: «Gli Indi credevano che un tempo gli uomini nascessero da uova d'oro, di argento o di rame deposte dai condor sulle montagne».
Uova metalliche piovute dal cielo?
Il concetto di capsule astronautiche ci è oggi assai più vicino.
La nostra mentalità, le nostre cognizioni, ci inducono piuttosto a relegare nel regno della fantasia i giganti che incombono sulle saghe di tutto il mondo. Eppure essi dominano anche la scena del Perù preincaico, presentandosi con caratteri analoghi, quando non identici, a quelli tratteggiati dalla mitologia mediterranea.
Nella sua opera «Vita degli uomini illustri della Compagnia di Gesù del Perù», che abbiamo già citato, padre Anello Oliva ci narra, in connessione con le vicende degli «Ingas» (Incas) una curiosa storia di giganti.
«Otoya, uno dei due figli del cacicco Tumbe (o Tumba), era crudele e ubriacone. Sfuggì ad un complotto e si diede ad estorsioni che furono stroncate solo dall'arrivo di un gruppo di giganti, i quali lo fecero prigioniero ed oppressero coloro che erano stati soggetti ai suoi cattivi trattamenti.
«Essi non avevano donne con loro e si abbandonarono al delitto contro natura, tanto che Dio, irritato, li fece perire tutti con il fuoco celeste.
«La tradizione riferisce che questi giganti erano venuti su zattere formate da grossi pezzi di legno e che erano tanto grandi che la testa di un uomo normale arrivava appena alle loro ginocchia.
«Essi scavarono fossi molto profondi, che si vedono ancora oggi a Punta S. Elena e che sono pieni d'acqua dolce. Si trovano ancora in questi luoghi ossa umane di una grandezza straordinaria e denti che pesano 14 once [430 grammi!]. Me ne sono stati mostrati di così enormi, che avrei stentato a credervi se non li avessi visti.
«È probabile che questi giganti fossero della medesima razza di quelli che approdarono nella Nuova Spagna [il Messico] e dei quali si scoprono ancora ossa nel distretto di Tlascala».
Cieza de Leon esagera certo affermando che prima del diluvio vivevano in America «esseri misuranti sei metri di altezza», ma è per lo meno strano che padre Velasco, anni dopo, insista sulla medesima asserzione senza essere al corrente delle cronache di Leon, aggiungendo che i titani «scolpivano statue a loro somiglianza, alte circa 8 varas [oltre 6 metri], le une nude, le altre vestite con sottane, ornate con mitre ed insegne religiose», il che è verissimo.
Gutierrez de Santa Clara parla di creature di altissima statura arrivate in Perù «da vaste isole del mare australe». «Non avevano armi, ma sapevano fabbricare clave e lanciavano massi enormi sui loro nemici», precisa.
Non ci troviamo qui davanti ad una raffigurazione dei famosi ciclopi omerici? E gli emuli di Odisseo non si contano: lo stesso Gutierrez insiste nella narrazione delle epiche lotte sostenute dagli indigeni americani contro i giganti.
Cercando le prove dell'esistenza dei titani nel «nuovo continente», dobbiamo ancora rifarci a Simone Waisbard, che scrive: «Il 4 dicembre 1970 un pescatore vide emergere dal mare, 250 chilometri a nord di Santiago del Cile, uno scheletro umano misurante 2,38 metri. A circa due metri di profondità, nel medesimo luogo, furono poi rinvenute ossa di animali preistorici, assieme al vasellame dei "titani", i disegni del quale non sono comparabili ad alcuna cultura conosciuta».
La statura non è certo impressionante come quella dei ciclopi di Cieza de Leon. I reperti sembrano comunque interessantissimi, anche perché comparabili con quelli esaminati dalla studiosa a Ilave, non lontano dal Titicaca. Abbiamo, fra l'altro, una tibia «lunga il doppio di quella di un indigeno dei nostri giorni», con ulteriori reperti in prossimità di massi che fanno pensare a menhir ed a tombe preistoriche.
Il luogo si chiama Karit-Amaya, che, tradotto, significa «il cadavere stanco di Kari». E i Kari - ci dice uno dei più grandi esperti in materia - sarebbero stati giganti occupanti una regione estesa da Cuzco al Cile!
Nelle vicinanze di questa località - aggiunge il quotidiano di Lima El Comercio, - sono state scoperte incisioni risalenti a circa 10 mila anni fa, con disegni in rosso, bianco e nero riproducenti scene di caccia, danza, cerimonie religiose. Anche qui dominano figure di statura considerevole. Si tratta di una deformazione magica o di un'«Altamira dei giganti»?
Non azzardiamo un tentativo di risposta. Potrebbe solo essere fantascientifico, e noi non abbiamo avuto la minima intenzione di romanzare l'enigmatico passato dei Quechua. Il nostro scopo è stato solo quello di presentare alcuni tratti della loro storia sotto la luce meno conosciuta, come cercheremo di fare con quello che è il centro più strettamente legato a quanto abbiamo esposto dall'inizio, un altro polo tentatore per gli appassionati di «enigmi cosmici» sudamericani: la favolosa Tiahuanaco.
Il nido del Condor
Nella regione di Tacna, al confine tra Perù e Cile, dove si leva il vulcano Descabezado Grande («il gran decapitato»), inquietanti fenomeni spargono da anni il terrore fra la popolazione: boati che certo non provengono dal sottosuolo, bagliori improvvisi, colorati, scie di fuoco nel cielo e, quel che più sorprende, la comparsa di «grandi piatti colorati luminosi come il Sole».
La gente del posto non ha mai sentito parlare di «dischi volanti», ma stranamente collega tali manifestazioni ai «diavoli della notte che vengono dal cielo», affermando anche di averne scorto qualcuno, in forma non umana, nei dintorni delle città di Mollendo (in Perù) ed Arica (in Cile).
Sia per tranquillizzare gli abitanti della zona, sia per cercare di chiarire l'origine dei fenomeni, un gruppo del Centro Spedizioni Andine organizzò una serie di sistematiche operazioni. Non venne a capo di nulla, ma attraverso l'osservazione aerea scoprì due estesissime piattaforme di fronte al vulcano. Ed alcuni studiosi affascinati dalle leggende stellari non tardarono a vedervi astroporti di una razza sconosciuta costruiti in tempi immemorabili sulla Terra.
Questi «cosmodromi» sono posti a 3.200 metri di altitudine, misurano circa 700 metri quadrati e sono formati da almeno 270 blocchi di lava connessi, ognuno dei quali dovrebbe pesare circa 10 tonnellate. «Vi si notano curiosi segni neri», aggiungono due membri del Centro, «che fanno pensare ad impronte lasciate dalle fiamme di veicoli spaziali».
Essi affermano, inoltre, di aver scorto l'ingresso di una misteriosa galleria. Possiamo crederci o no: sta comunque di fatto che gli indios conservano il ricordo di una tradizione secondo cui un lungo tunnel partirebbe dal Descabezado Grande per terminare al confine tra Perù, Cile e Bolivia, a poca distanza dal lago Titicaca, dove - si dice - sarebbe esistita un'altra piattaforma simile alle due scoperte dalla spedizione andina.
Altre gallerie collegherebbero (o avrebbero collegato) il Titicaca a Cuzco, terminando nello splendido tempio di Coricancha, dedicato al Sole. «L'edificio», scrive la studiosa Simone Waisbard, «sempre secondo le fantasie indie, era circondato da meravigliosi giardini con alberi rari, uccelli e animali esotici, nonché da statue di oro puro raffiguranti misteriosi personaggi a grandezza naturale.
«Leggenda o realtà? Gli archeologi peruviani da me consultati in proposito (i più qualificati per risolvere questo problema) non hanno voluto pronunciarsi né in senso negativo né in senso affermativo, anche se io so perfettamente che molti di loro, da bambini, si sono avventurati ad esplorare quegli oscuri e pericolosissimi sotterranei - denominati chinganas - ove numerosi cercatori d'oro e di tesori hanno trovato la morte per asfissia. Altri, invece, ne sono usciti letteralmente impazziti o ammutoliti dal terrore.
«Secondo gli indios, molti tronchi di questi labirinti nascosti sotto terra esisterebbero ancora e sarebbero, anzi, intatti. Ne hanno parlato quasi tutti i conquistadores».
È un bizzarro lago il Titicaca: posto a 3812 metri sul mare, misura 8.300 chilometri quadrati e costituisce ancor sempre un grosso rompicapo per la scienza, soprattutto per il suo notevolissimo contenuto salino. Basti dire che nel giugno 1970 una missione francese escluse immediatamente la possibilità di usarne le acque per l'irrigazione: se tanto fosse stato fatto, il terreno circostante sarebbe diventato un deserto.
Nella lingua degli Aymarà (gli indigeni peruviani - circa 500 mila - discendenti da stirpi preincaiche), Titi significa «puma» e Caca sta ad indicare il colore fulvo, ma è anche il nome di un pesce locale avente un ruolo considerevole nelle leggende sulla creazione e sul diluvio. La tendenza più recente è quella di tradurre la denominazione dello specchio d'acqua con «Lago del puma e del pesce sacro», rifacendosi appunto alle tradizioni che ce lo descrivono come «grembo dell'umanità».
Qui Viracocha, il dio supremo degli Incas, avrebbe compiuto il suo ingrato lavoro teso a creare una razza perfetta. Quattro volte avrebbe fallito, annientando i frutti dei suoi errori con i fuochi dei vulcani, un diluvio tremendo, epidemie di una virulenza senza pari e, infine, pietrificando i disobbedienti alle leggi divine.
Si tratta di credenze (ricordate ancor oggi) che trovano riscontro in tutto il globo, che vediamo riflesse nel Popol Vuh dei Maya, nei racconti mesopotamici, nei testi sacri indiani, tanto per citare qualche esempio. Ma qui, sull'enigmatico lago, incontriamo qualcosa di più, vediamo uno spunto fantascientifico nelle parole rivolte dall'imperatore Atahualpa a Pizarro: «Ecco l'impronta lasciata dal Sole quando prese lo slancio per salire al cielo».
Di quale impronta si tratta? «Di un'enorme bruciatura sulla pietra», apprendiamo dai cronisti della Conquista. E tanto ci riporta ai «cosmodromi» di Tacna!
E siamo soltanto all'inizio dei sogni di fantascienza. Procediamo con Garcilaso de la Vega, uno dei più misurati storici (1537-1616), che ci racconta di essere disceso in gallerie scavate sotto la laguna di Urcos, fra Cuzco e il Titicaca, dalle quali - stando ad antichissime tradizioni indigene - sarebbe «salito al cielo un enorme serpente d'oro».
È il serpente Amaru, registrato sul calendario degli antichi peruviani e dei polinesiani a segnare l'inizio dell'anno. E tale periodo coincide, sia per gli uni che per gli altri, con la prima riapparizione delle Pleiadi, le stelle che hanno lasciato la loro impronta sui miti più sconcertanti dell'umanità.
Le stesse gallerie che si aprirebbero dal Titicaca non solo verso il Descabezado Grande, ma in parecchie altre direzioni, disegnano costellazioni note e ignote. Lo afferma lo scrittore W. McCarthy, riferendosi ad autorevoli cronisti iberici, fra cui Cieza de Leon.
«Il grande viaggiatore francese Alcide d'Orbigny», riferisce, dal canto suo, Simone Waisbard, «notò, nel secolo scorso: "Si vedono dappertutto [nei pressi del lago] bocche sotterranee". Esagerava? Un suo emulo, l'austriaco Tschudi, parlò di "strade sotterranee che si estendevano in tutta la regione, a volte allargandosi a formare grandi sale accuratamente costruite", asserendo di averne visitato alcuni tratti purtroppo ostruiti». E l'archeologo Kauffman Doig dichiara che la Porta del Sole di Tiahuanaco «potrebbe celare l'ingresso di uno smisurato tunnel» dalle diramazioni imprevedibili.
Eccoci dunque a Tiahuanaco, una delle più misteriose e suggestive città morte del globo. Oggi dista oltre 25 chilometri dal lago, il cui livello si abbassa sempre più, ma in tempi già vicini a noi le acque lambivano questo maestoso complesso.
«In un titanico palazzo c'è una sala lunga 45 piedi e larga 22, con un tetto costruito come quello del tempio del Sole di Cuzco», ci dice Cieza de Leon. «Questa sala ha molti grandi portali e molte finestre. La laguna bagna i gradini che portano nell'atrio. Gli indigeni dicono che è il tempio consacrato a Viracocha, il creatore del mondo».
Le leggende concordano, dunque, comprese quelle del diluvio e dei giganti. C'è chi vuole, infatti, la città edificata dai titani (come dargli torto di fronte a tale imponenza?), gli stessi che, «disobbedienti», sarebbero stati cancellati dalla faccia della Terra dal dio. Ed è per lo meno curioso il fatto che li si ricordi tuttora, con un chiaro riferimento alla loro pietrificazione, nel corso di cerimonie magiche. Lo studioso Bennett fu ammesso nel 1932 a parteciparvi e venne accomiatato, al termine, con le parole rivolte dal sacerdote a tutti i presenti: «Avete visto. Non tornate mai più in questo luogo, o sarete fatti roccia come i giganti».
Al diluvio ed ai titani sembrano volerci rimandare anche le tentate interpretazioni del nome di questo enigmatico centro. Secondo L. E. Varvarcel si dovrebbe pensare al «luogo dove si congiungono terre ed acque» (dai monosillabi Ti = insieme, Wa = terra, Na = unione, Co = acqua). La spiegazione è forse troppo semplicistica, ma alcuni termini ricorrono pure in altre versioni (Miguel de los Santos Taborga: Tia-I-Huanabco, «il paese sotto l'acqua di dio»; Robert Schultz: Tiawa-Hake, «la città del Sole e dell'acqua»; Felipe Cossio del Pomar: Tiahua-Na-Ku, «la città eterna dell'acqua», eccetera).
Comunque sia, pare che la metropoli sia stata danneggiata seriamente proprio 9.500 anni prima della nostra era, in seguito al cataclisma che causò lo sprofondamento di Atlantide ed elevò la Cordigliera delle Ande alla sua attuale altitudine.
Quando gli Incas giunsero sul Titicaca, trovarono Tiahuanaco già distrutta e deserta. È quindi impossibile stabilirne l'età. C'è chi la fa risalire a 16 mila anni fa con l'ingegner Posnansky (a cui dobbiamo moltissimo per quanto concerne la conservazione delle ultime vestigia), ma senza dubbio le rovine poggiano su resti di centri ben più antichi. Gli scavi condotti dal Centro Investigazioni Archeologiche di Tiahuanaco, sotto la direzione dell'archeologo Carlos Ponce Sangines, con la collaborazione dei geologi Max Mille e Girardo Mogrovio Terrazas hanno portato a conclusioni stupefacenti: «Cinque città giacciono sepolte, con carcasse di toxodonti, di mammiferi ungulati di età antidiluviana. [...] Lo studio delle stratificazioni rivela che lunghi secoli di splendore furono troncati d'improvviso, che seguirono periodi di decadenza e spettacolose rinascite».
Una datazione sia pure approssimativa è impossibile. Ci converrà tenerci lontano, comunque, dai milioni di anni (si va da 5 a 250!) che gli ufomani assegnano alla prima metropoli, dicendola fondata da colonizzatori marziani o da belle venusiane orecchiute in vena di zoofilia.
Appare comunque significativa l'analogia rilevata da Charles Wiener tra la rampa di accesso alla piramide di Puma Punku e le costruzioni dei primi abitanti della vallata del Mississippi: «Le ossa umane riportate alla luce sulle rive di questo grande fiume nordamericano, geologicamente più vecchio del Nilo, sotto quattro diversi strati di foreste, risalirebbero a circa 57 mila anni fa».
Non occorrono certo sciocche fantasie per attribuire a Tiahuanaco l'appellativo di «città magica», dunque, conferitogli da tanti studiosi. È sintomatico, tra l'altro, scorrere alcuni passi delle antiche cronache.
Garcilaso de la Vega parla di una splendida collina artificiale, di giganteschi monumenti, di portali costruiti con unici blocchi di pietra, Diego d'Alcobaga di una piazza di 24 metri quadrati, su un lato della quale si stende una sala coperta lunga 14 metri, dicendoci come la piazza e la sala siano state ricavate da un solo pezzo. Jimenez de la Espada ed altri cronisti ci narrano di meraviglie inconcepibili, di palazzi immensi, di sale che potevano ospitare migliaia di persone, di statue «tanto perfette che si crederebbero vive».
Un capolavoro è anche rappresentato dalla piramide le cui rovine si trovano poco lontano: essa fu edificata con blocchi il cui peso supera le cento tonnellate. Come furono trasportati (in genere sono lunghi otto metri, larghi oltre quattro e spessi due), resta un mistero. Si sa soltanto che i costruttori usarono strumenti di una lega resistentissima (qualcuno è stato ritrovato) e colavano tra masso e masso rame, piombo o bronzo fusi, tanto da ottenere una coesione che ha resistito ad ogni agente distruttore per chissà quanti millenni.
Molto, molto poco resta di queste splendide testimonianze di una sconosciuta, grandissima civiltà. Nessuno potrà mai stabilire quanto è stato rubato a Tiahuanaco e disperso in innumerevoli collezioni private di tutto il mondo, ma ci basta pensare ai monumenti frantumati ed usati per la costruzione di strade, palazzi e chiese, per comprendere la portata delle azioni vandaliche compiute.
A dare un addio tanto affascinante quanto triste alle speranze di fare luce sulla «Baalbek del nuovo mondo» (così la chiama l'archeologo inglese E. G. Squier) è rimasta la Porta del Sole, il più grande monolito scolpito sulla Terra, formato di un blocco alto tre metri e largo due. Secondo Posnansky si tratterebbe di un calendario e di uno strumento astronomico allo stesso tempo. Altri studiosi scorgono nelle sue raffigurazioni simboli della creazione, della potenza celeste, del diluvio, di fantastiche realizzazioni umane.
Interessante ci sembra l'interpretazione data da Max Uhle, stando al quale il personaggio posto al centro sarebbe il reggitore dell'Olimpo andino, «il signore del tuono e del fulmine, vestito di stelle», lo stesso che, con i medesimi attributi, viene adorato in Amazzonia. Uhle, raccogliendo con un paziente e minuzioso lavoro le tradizioni aymarà, pensa di poter così definire gli altri sconcertanti esseri:
Lliphi-Lliphi, esperto in razzi ed esplosivi,
Chijchi, guardiano delle munizioni,
Akarapi, padrone del freddo e della pioggia,
Kada, sorella di Akarapi, signora dei ghiacci,
Ritti, dea delle nevi,
Nina, guardiana del sacro fuoco del fulmine,
Nina Pichinquilla, divinità dei vulcani,
Waira, scatenatore di uragani,
Yallpa Kharkati, lo spirito dei terremoti,
Keko, il dio che scaglia i lampi.
Attorno a questi attributi si potrebbero ricamare innumerevoli fiabe cosmiche, alimentate dalle credenze ancora vive fra gli indigeni. Fiabe o riflessi di un'insospettabile realtà, come affermano i sovietici Kasanzev e Zirov, che vedono nelle figure della Porta del Sole rappresentazioni di scafandri spaziali e di motori astronautici?
Una risposta è impossibile, ma le tentazioni sono molte.
In un documento antichissimo, scoperto solo di recente, Simone Waisbard ha trovato la lista segreta degli Uomini-Condor-Pakajes, che «regnarono su Tiahuanaco, grande e sacra sede religiosa posta sotto la protezione degli dei». Si chiamavano anche Zapanas, dal nome del «braccialetto magico» che portavano e di cui parleremo in seguito.
Simone Waisbard ritiene di avere rinvenuto la loro sede originale e scrive: «La traccia sembra terminare al Titicaca, per scomparire, anzi, proprio sotto le onde del Lago Sacro, a due chilometri circa dal piccolo porto boliviano di Guapì, in una località denominata Zapana (significativa coincidenza!), dove, su indicazione di alcuni indios, ho potuto trovare i resti di un palazzo monumentale, le cui fondamenta, quasi celate, sulla riva, da una spessa coltre di fango, emergono tuttora dalle acque fino ad una considerevole distanza dalla sponda. Dagli stessi indigeni sono stata informata che altre rovine giacciono, coperte totalmente dalle acque, sul fondo del lago, e che, secondo le leggende indie, quelle vestigia apparterrebbero alla vera città degli Uomini-Condor. Gli storici della regione le fanno risalire a trenta o quaranta secoli or sono».
Catari, vissuto negli ultimi tempi dell'impero incaico, riferendosi alle parole dell'«onnipotente Huyustus, re degli Uomini-Condor», riferisce che «il primo grande capo dei Pakajes era biondo ed aveva occhi azzurri».
Da dove veniva? Nessuno lo saprà mai, benché le illazioni ci portino ai mari di Occidente, forse ad Atlantide. Ma ricordiamo la descrizione di un'antichissima danza resa da Garcilaso de la Vega:
«Alcuni dei danzatori sono muniti delle belle e grandi ali di un uccello che essi chiamano Cuntur, dalla cui razza si vantano di discendere. Ed essi danzano mascherati con le spoglie del Cuntur proprio per ricordare e proclamare la loro favolosa origine».
È significativo notare che si potrebbe giungere addirittura ad una retrodatazione, poiché le leggende si riferiscono all'uccello solo come ad un simbolo legato alla discesa dei loro avi dal cielo.
«Un indio Cohaquira», riferisce ancora la ricercatrice, «mi ha assicurato di avere visto emergere più volte, nel corso della sua lunga esistenza, una intera città normalmente coperta dalle acque del lago. Essa torna alla luce solo durante certi eccezionali periodi ciclici di siccità». Va aggiunto che si parla di parecchie città sommerse nel Titicaca, alcune delle quali sono state viste senza ombra di dubbio da sommozzatori.
Così la studiosa ci descrive quella scoperta dalla spedizione guidata dall'argentino Ramon Avellaneda: «Ad otto metri di profondità gli esploratori rivedono gli enormi blocchi squadrati e sovrapposti che si allungano in file, angoli e incroci regolari, simili ad un mostruoso e misterioso cruciverba per giganti. Le muraglie appaiono disposte in modo organico e regolare, con la nota tecnica degli Incas. Ma, a bordo, gli archeologi sanno che a costruirle sono stati i Kollas, molti e molti secoli prima che esistesse l'Impero del Sole».
Una curiosità: tutti gli abitanti della zona sono straordinariamente longevi: Simone Waisbard avrebbe incontrato individui di 130-150 anni: quelli che non raggiungono il secolo costituirebbero addirittura un'eccezione!
Ma torniamo al condor, che vediamo legato a tradizioni ed a leggende le quali sembrano volerci trascinare lontano dal nostro logico scetticismo.
Nel corso di una danza rituale chiamata Mimùl, il volatile è un «grande rapace muto» che, ad un segno di omaggio, «indirizza un raggio magico ai suoi adoratori». Completa Simone Waisbard:
«Esperti osservatori dei misteri celesti, gli Aymaràs, indicano nella volta stellata delle notti andine, nelle immediate vicinanze della Croce del Sud, la costellazione del "Condor Ancestrale" che ha il suo nido - il "gran nido del Condor" - in una macchia oscura, priva di stelle, posta in un'adiacente nebulosa».
Ma l'incantesimo delle grandi civiltà perdute non ci fa guardare soltanto a sconcertanti enigmi stellari.
Tra l'altro, Simone Waisbard ci dice di aver trovato qualcosa di sensazionale: «Una grossa pietra pomice vulcanica, lunga un metro e mezzo, su cui è scolpito un serpente che reca sopra la testa, a guisa di corona, il cerchio astrale, simbolo dell'infinito nella mitologia egizia!».
A proposito di «parentele» con i figli del Nilo, la studiosa segnala due idoli di taglia umana (uno dei quali si trova ora ad Arequipa) di sesso maschile e femminile, sui corpi dei quali sono inchiodati piccoli sarcofaghi d'argento. «La forma delle due statue», ci fa osservare, «richiama immediatamente alla memoria dell'archeologo i sarcofaghi lignei dei Faraoni».
Sollevando la lamina argentea, l'archeologo Antunez de Mayolo rinvenne una piccola mummia di argilla che riproduceva esattamente una delle gigantesche statue di Tiahuanaco.
«Specialisti in materia di archeologia paleoamericana», aggiunge Simone Waisbard, «non esitano ad avanzare l'ipotesi che i misteriosi edificatori della città morta non abbiano affatto scolpito, ma si siano limitati a dissotterrare delle statue già esistenti prima del diluvio, utilizzandole quali ornamenti dei loro templi piramidali e dei loro palazzi. I colossi di pietra, quindi, sarebbero stati opera di ancor più remoti artefici, più precisamente del popolo di Winay-Marka, una città di cui si è perduta ogni traccia, perché in una certa epoca imprecisata, quando già esisteva Tiahuanaco, scomparve nel nulla, probabilmente sepolta dalle lave di qualche vulcano».
America ed Egitto: quanti elementi comuni a civiltà solo in parte conosciute, quanti propri a genti lontane nel tempo e nello spazio abbiamo trovato nel corso dei nostri studi!
E chissà quanti ancora ci attendono, a fornirci una dimostrazione sempre più convincente dell'ipotesi che andiamo sostenendo da anni: quella dell'origine unica di tante grandi culture.
Capitolo V - Viaggi nel passato: I segreti dei Mounds
Fu nel 1539 che una spedizione spagnola partì da Cuba approdando sulle coste della baia di Tampa, in Florida, allo scopo di scoprire nuove terre, di esplorarle, ma soprattutto di trovare oro, tanto oro, più di quello raccolto nei loro indiscriminati saccheggi nell'America meridionale.
I conquistadores, guidati da Hernando de Soto, vissero avventure terribili per quattro anni, attraversando i deserti, le praterie e le foreste dei paesi che oggi si chiamano Georgia, Carolina del Nord e del Sud, Tennessee, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Louisiana e Texas.
Uccisero, razziarono, ma il loro bottino fu ben poca cosa, benché essi siano stati i primi a scoprire una serie di tesori di valore archeologico sbalorditivo, un valore di cui, ovviamente, non si resero conto.
Ma veniamo all'inizio di questa folle impresa, che lo scienziato e scrittore Patrick Ferryn così riassume:
«L'1 giugno 1539, poco dopo lo sbarco a Tampa, la spedizione arriva in vista di un villaggio indiano. Il cronista di servizio, anonimo, ma citato dalla storia con il nome di "Gentiluomo di Elvas", ci ha lasciato la descrizione di questo insediamento che egli chiama Ucita: "La città era formata da sette o otto case, costruite con tronchi d'alberi e coperte con foglie di palma. La dimora del capo si trovava vicino alla spiaggia, sulla sommità di una collinetta innalzata da mano d'uomo a scopo difensivo..."
«Quest'allusione ad una "collinetta" è la prima menzione conosciuta di un tumulo degli indiani dell'America del Nord. E di tumuli gli spagnoli di Hernando de Soto ne incontreranno molti altri lungo il loro cammino: non decine o centinaia, ma migliaia e migliaia! Se la maggior parte di essi era di dimensioni relativamente modeste, altri erano davvero enormi. Benché parecchi siano stati distrutti, ne esiste ancora un gran numero. Sono rotondi, piramidali, conici, rettangolari, quadrati, di forma allungata, ed hanno talvolta gradini. Certi, generalmente di grandi proporzioni, rappresentano animali molto stilizzati.
«Questi tumuli, questi giganteschi lavori in terra, sono chiamati in America mounds, i loro costruttori Mound Builders, ed hanno fatto spargere fiumi d'inchiostro, dando luogo a numerose ipotesi. Chi furono gli edificatori? Quale fu la loro origine? A quale tempo risalgono ed a quale fine furono eretti?».
Scomparsi nel nulla
La cosiddetta «regione dei mounds» incomincia ad ovest dell'attuale stato di New York, estendendosi lungo le sponde del lago Erie fino al Michigan, al Wisconsin, allo Iowa ed al Nebraska. A sud costeggia il Golfo del Messico, dalla Florida al Texas, risalendo verso l'Oklahoma, la Carolina e la Virginia. La zona della maggior concentrazione è costituita dall'Illinois, dall'Indiana, dal Missouri e soprattutto dall'Ohio, che ne conta circa diecimila, su quasi centomila, il numero totale approssimativo calcolato oggi negli Stati Uniti.
Alcuni mounds sono isolati, altri sorgono a gruppi, alcuni sono bassi, quasi indistinguibili dai rilievi naturali, altri monumentali, raffiguranti esseri umani ed animali.
Il più famoso è certo il Great Serpent Mound, che sorge presso Cincinnati nell'Ohio: rappresenta un gigantesco rettile snodante il suo corpo per 405 metri lungo un piccolo corso d'acqua, il Bush Creek. Nel Wisconsin vi sono i tre enormi uccelli di Lower Dells (di cui uno ha un'apertura alare di 74 metri) ed un essere bicefalo lungo 45 metri. Non mancano altre suggestive raffigurazioni, anche se più modeste: orsi, tartarughe, rane.
Nel Midwest si trovano, poi, colline enormi in forma di piramidi tronche, alcune delle quali posseggono rampe o scalinate che conducono alla sommità.
Ferryn ci parla del grande mound a gradini di Cahokia, non lontano dall'attuale St. Louis, nel nord dell'Illinois: misura oltre 300 metri di lunghezza, 250 metri di larghezza, e sulla cima, a 30 metri, si leva ancora una grande costruzione di legno. Questo monumento ha un volume di circa 600 mila metri cubi e la sua superficie supera di 18 mila metri quadrati quella della Grande Piramide di Cheope! Ai suoi piedi e nei suoi dintorni si ergono ottanta mounds conici o piramidali ed altri quaranta sono stati distrutti dagli agricoltori dopo il secolo scorso».
Da chi furono costruite le colline artificiali nordamericane?
Dai conquistadores non abbiamo saputo nulla in proposito, poiché i loro interessi avevano ben poco a che fare con la scienza. Lo stesso Garcilaso de la Vega ci fornisce scarse ed inesatte notizie, scrivendo nel suo libro pubblicato nel 1608: «Gli indiani cercavano di sistemare i loro villaggi in luoghi elevati, ma, come in Florida, non esistono molti posti del genere e quindi li eressero essi stessi. [...] Una città di 400 case e una grande piazza, dove la casa del cacicco sorgeva su una collinetta artificiale [...]. Il governatore [Hernando de Soto] aprì un grande tempio di legno dove erano sepolti i capi del paese e ne trasse una gran quantità di perle».
I mounds furono una delusione per gli avventurieri iberici: nei sepolcri trovarono pochissimi oggetti d'oro e d'argento e gli indiani spiegarono loro di averli ottenuti per mezzo di scambi con altri popoli, indicando il Sud e parlando di regioni molto lontane, evidentemente per far sì che i poco graditi ospiti se ne andassero alla ricerca dell'ambito metallo alla larga dai loro villaggi, ma forse senza mentire: molti storici, infatti, sostengono l'esistenza di rapporti commerciali tra i pellerossa nordamericani ed i loro vicini meridionali.
Una delle interpretazioni più assurde è quella fornita da una spedizione «scientifica» del XVIII secolo (alla quale prese parte anche Benjamin Franklin), i cui componenti giunsero alla conclusione che ad erigere i mounds fossero stati gli stessi spagnoli.
L'affermazione è paradossale, ed a provarlo bastano le cronache di Garcilaso de la Vega: proprio i conquistadores avrebbero costruito collinette artificiali per seppellirvi gli antichi capi indiani con il loro corredo funerario, per poi demolire, o comunque danneggiare e saccheggiare le costruzioni?
Ugualmente priva di fondamento è, naturalmente, l'asserzione di Joseph Smith, creatore della «Chiesa di Gesù Cristo dei santi dell'ultimo giorno» (1805-1844), il quale asserì che ad edificare le colline artificiali erano stati i Nefiti, gli ebrei che Levi avrebbe condotto in America fuggendo da Gerusalemme.
Non c'è da meravigliarsi come i Mormoni considerino tale «rivelazione» indiscutibile, ma c'è da stupirsi come alcuni ricercatori cerchino di avvolgere i famosi monumenti in una nebbia esoterica di cui qui non desideriamo affatto discutere.
Se si interrogano i pellerossa di oggi di un certo livello culturale, si ottengono (come dagli studiosi occidentali) risposte diverse: c'è chi parla della costruzione da parte di antiche tribù scomparse, chi accenna al diluvio universale ed al tentativo di sfuggire alla furia delle acque in luoghi soprelevati, chi pensa all'opera di una grande civiltà sconosciuta.
Sono tutte ipotesi accettabili, ma purtroppo non disponiamo di alcuna prova. Esaminati i principali mounds, propenderemmo per quanto ci ricorda Patrick Ferryn:
«Nel 1887, Cyrus Thomas, della sezione di etnologia della Smithsonian Institution, pubblicando le sue conclusioni in seguito agli scavi intensivi della sua squadra di specialisti, affermò che non c'erano state una razza o una cultura unica di Mound Builders, ma che sotto questo termine generico si dovevano celare popoli differenti e che la tradizione della costruzione dei tumuli si estende su periodi largamente spaziati. Alla fine di un'opera monumentale di oltre settecento pagine apparsa nel 1894 (Report on the Mound Explorations of the Bureau of Anthropology) Thomas conclude che l'edificazione della maggior parte dei mounds risale a tempi preistorici, ma che altri monumenti furono ancora costruiti, dopo la scoperta del continente da parte degli europei».
Dobbiamo ammettere, in sostanza, che di questi monumenti (di cui molti in Europa, e non in Europa soltanto, non hanno mai sentito parlare!) si sa ben poco, e che gli strani reperti finora disponibili non fanno che rendere più appassionanti, ma anche più fitti, i loro enigmi.
Elefanti in America
Un'ascia di ferro, ad esempio, venne rinvenuta, secondo il periodico American Antiquarian (1889), tra il corredo funerario di una collinetta artificiale della contea di Wayne, nell'Ohio, ed è noto che gli indiani non usavano il ferro. Più sensazionale ancora è la scoperta, in un mound di Almota (Washington) dello scheletro di un capo indigeno vestito con una cotta di maglia metallica e con una spada al fianco.
Sull'origine di un braccialetto d'argento trovato nel Wisconsin con la scritta MONTREAL nessuno si può pronunciare, com'è il caso di sei tavolette di bronzo studiate nel 1843 da Squier, provenienti da Kinderhook (Illinois) e recanti simboli simili a quelli del cinese arcaico.
La più enigmatica sembra però la tavoletta rinvenuta nel 1838 nel Mammoth Mound a Moundsville (Grave Creek, Virginia) da Abelard Tomlison. L'insigne antropologo Henry Rowe Schoolcraft vi vide incisi «caratteri analoghi a quelli dell'alfabeto celtico delle isole britanniche», mentre specialisti europei vi scorsero lettere greche, libiche e fenicie e il professor Barry Feld dichiarò trattarsi di una scritta fenicia effettuata con tratti iberici in uso nel I millennio a. C.
Una pietra trovata nel 1880 da Cyrus Thomas nel mound di Bat Creek, nella contea di Loudon (Tennessee) reca, secondo il professor Cyrus H. Gordon, dell'università Brandéis, nel Massachusetts, caratteri indubbiamente semiti.
Siamo d'accordo, i popoli di mezzo mondo hanno scoperto l'America, casualmente o meno, e ne abbiamo parlato esaurientemente nei nostri precedenti lavori. Ma che qualcuno vi abbia importato elefanti, è piuttosto difficile. Eppure ne troviamo tracce evidentissime. La più eloquente è quella rinvenuta dal reverendo Jack Gass e dai suoi compagni nel 1847 in un mound di Davenport, nello Iowa: due pipe di pietra su cui è inciso in modo perfetto, con scritte indecifrabili e segni astrali, un pachiderma.
Il bello è che troviamo più a sud, nella «stele B» di Copán, nell'Honduras, due elefanti accostati dorsalmente, mentre un altro è visibile nel Panama.
È evidente che all'epoca delle riproduzioni non si trovavano elefanti in America. Ma, non dubitando dell'autenticità delle opere in discorso, gli interrogativi che si pongono sono due. Esistettero in tempi molto anteriori questi proboscidati nel «nuovo mondo»? Oppure la loro immagine venne portata da ignoti navigatori approdati a quelle sponde dopo aver varcato l'oceano?
In un caso o nell'altro, si tratta di ricordi trasmessi e resi con estrema precisione, ricordi che non possono essere accolti semplicemente con una alzata di spalle.
«Gli imponenti mounds piramidali», scrive Patrick Ferryn, «fanno naturalmente sognare le piramidi di pietra del Messico, i teocalli, la cui relativa vicinanza lascia intravedere un legame di parentela. Si cercò allora di scorgere nei mounds il risultato della diffusione di un concetto mesoamericano. La similitudine con i monumenti messicani è netta nel Sud degli Stati Uniti, mentre i mounds stessi diminuiscono per grandezza ed importanza man mano che gli invasori venuti dalla Mesoamerica avanzarono verso il Nord. Infine avrebbero costruito soltanto collinette simboliche in prossimità del Canada, avendo abbandonato le loro tradizioni ancestrali.
«Altri, di contro, sono di un parere totalmente opposto, dicendoci, cioè, che i mounds vennero dall'America settentrionale e che, scendendo al Sud, i loro ideatori avrebbero edificato monumenti d'imponenza sempre maggiore, come quelli dell'Ohio, ed i templi-mounds meridionali, per poi andare verso il Messico, dove avrebbero innalzato le piramidi che conosciamo».
La prima ipotesi ci sembra la più accettabile, non solo perché l'elefante di Davenport può essere accostato a quelli della stele maya di Copán, ma anche perché il dottor Reinholdt Engelmayer, nel corso degli scavi compiuti in due tumuli presso Georgetown, nella Carolina del Sud, ha scoperto circa 600 manufatti risalenti a circa 4.500 anni fa, i quali proverebbero la presenza dei Maya in quella regione. «Non è azzardato presumere», dichiara lo studioso, «che queste popolazioni fossero emigrate, lungo la riva del golfo, sino alla costa orientale».
La storia dei Maya, la cui civiltà si credeva fiorita nei primi secoli dell'era cristiana, va comunque retrodatata, e di molto, fino ad oltre 4 mila anni fa almeno, come hanno dimostrato gli scavi compiuti nel Belize (già Honduras Britannico) da una spedizione angloamericana guidata dal professor Norman Hammond.
Nelle vicinanze di Cuello (Belize settentrionale) sono state portate alla luce, sotto una piattaforma alta 4 metri e lunga 80, resti di edifici appartenenti a tre epoche diverse. Con il metodo di datazione del carbonio 14 è stato stabilito che le ultime costruzioni risalgono a circa 3.600 anni or sono, quelle medie a 4.100 anni e quelle più antiche ad almeno 4.400.
Tra queste rovine, circondanti piazze dominate da templi a piramide, sono stati rinvenuti frammenti di vasellame di ottima fattura, con disegni geometrici e floreali elaborati.
L'epoca di questa cultura è stata denominata «Fase Swasey», dal nome del fiume vicino. Curioso è il fatto che tra i doni funerari siano stati trovati gioielli di giada, una pietra che non esiste né esisteva nei pressi dei luoghi di scavo.
Come si può giudicare da questo esempio, il passato delle civiltà che hanno improntato il nostro globo non è affatto calcificato nelle date attribuitegli dalla scienza tradizionalista. Nella storia dei Maya abbiamo fatto un enorme passo avanti (o indietro, se ci vogliamo perdere in un gioco di parole) con la scoperta del professor Hammond, e non è affatto escluso che sia l'ultimo.
Altre ricerche sui Maya sono in corso e potrebbero condurci a risultati ancor più sorprendenti, anche e soprattutto riguardo alle culture da cui hanno tratto origine. Perché è impensabile - diciamo con il professor Hansen - che un bel giorno dal nulla esca un popolo e si metta a costruire meravigliose opere architettoniche che lasceranno sbalorditi i posteri, spesso incapaci non diciamo di eguagliarle, ma persino di imitarle.
Il signore della notte
A proposito di mounds, dobbiamo sottolineare come siano ancora vive, oggi, remote tradizioni che li vogliono edificati da giganti, come, del resto, è il caso di parecchie altre costruzioni titaniche.
Ovviamente si tratta di credenze senza fondamento, anche considerando i resti e gli strumenti che vi sono stati reperiti. Ciò non toglie, però, che incontriamo pure in Nordamerica numerosi graffiti e numerose leggende che si riferiscono ai mitici personaggi, crudeli antropofagi che spesso, come nell'Odissea, seminano sterminio.
Ma, come nel poema omerico, qualcuno riesce a cavarsela, sia pure con espedienti diversi da quelli adottati da Ulisse.
Per gli indiani Kiowa sono due gemelli a cadere nella trappola, una caverna dove i titani affumicano gli incauti che vi capitano, per poi cibarsene. Per fortuna i fratelli avevano una saggia nonna, dalla quale avevano appreso due parole magiche con cui cavarsela in caso di bisogno: thain-mom. Le pronunciarono parecchie volte e, mentre il ciclope preparava i fuochi per asfissiarli e quindi arrostirli, il fumo ristagnò sopra le loro teste, tanto che la moglie del Polifemo americano subodorò qualche magia e pregò il consorte di mettere in libertà i gemelli, il che avvenne.
La leggenda è narrata dalla scrittrice kiowa N. Scott Momaday, premio Pulitzer per la letteratura, mentre Edmund Nequatewa ci presenta un altro gigante, d'indole diversa. Racconti senza età ne parlano, ma lo scrittore l'ha, per così dire, «attualizzato», ponendolo in relazione con la strana avventura del dottor Fewkes, un archeologo della Smithsonian Institution che, trasferitosi a Walpi per studiare la vita e le tradizioni degli indiani Hopi, se ne andò, secondo la versione ufficiale, per sfuggire ad un'epidemia di vaiolo.
Ma la causa della sua improvvisa partenza è, secondo il racconto di cui sopra, ben diversa.
Tutto accadde in seguito ad un rito segreto a cui nessuno può assistere, poiché a presiedervi è Masauwu, signore della terra e del mondo sotterraneo, che celebra un mistero sacro.
«Masauwu è simile alla morte, si veste con la pelle di animali scorticati e gli uomini non possono sopportare di guardargli il viso. Gli Hopi dicono che egli è veramente un uomo forte e bello, di colore scuro, con magnifici occhi neri, e che è, in verità, un gigante possente».
I pellerossa avvertirono il loro ospite, dicendogli di chiudersi in casa «senza tentare di guardare fuori, qualunque cosa fosse accaduta».
Il dottore obbedì, più per cortesia che per timore, ed ecco, secondo la narrazione fatta a Nequatewa, quanto gli accadde.
Chiuse la porta, si sedette e cominciò a scrivere le sue note. Improvvisamente provò una strana sensazione: sentì che c'era qualcuno nella stanza, alzò gli occhi e vide un uomo imponente fermo davanti a lui. Non riusciva a vederne il viso, in quanto la luce era scarsa.
Rimase molto sorpreso, poiché sapeva di aver chiuso la porta a chiave.
Disse: «Che cosa volete e come siete entrato qui?».
L'uomo rispose: «Sono venuto per intrattenervi».
Il dottor Fewkes disse: «Andatevene. Sono occupato e non desidero essere intrattenuto».
Mentre guardava l'uomo, questo improvvisamente scomparve. Quindi la voce disse: «Girate la testa un istante», e quando il dottore guardò di nuovo, la figura stava ancora lì davanti a lui, ma questa volta la sua testa era strana e orribile a vedersi.
Il dottore disse: «Come siete entrato?».
E l'uomo rispose: «Vado dove mi piace, le porte sbarrate non possono tenermi fuori. Guardate, vi mostrerò come sono entrato».
E mentre il dottor Fewkes guardava, egli si rimpicciolì e divenne simile ad un filo di paglia di un copricapo hopi e svanì attraverso la serratura.
Il dottor Fewkes era terrorizzato, e, mentre pensava a cosa fare, l'uomo fu di nuovo lì. Ancora una volta gli chiese: «Cosa volete?».
La figura rispose come prima: «Sono venuto per intrattenervi».
Il dottore gli offrì una sigaretta, poi un fiammifero, ma l'uomo rise e disse:
«Tenete il vostro fiammifero, non ne ho bisogno».
Tenne la sigaretta davanti alla sua orribile faccia e soffiò un torrente di fuoco sopra di essa e l'accese.
Il dottor Fewkes rimase terrorizzato, perché ora chiaramente sapeva chi era quell'uomo. L'essere gli parlò a lungo, e il dottore alla fine si arrese e disse che sarebbe diventato un Hopi, sarebbe stato uno di loro, avrebbe creduto in Masauwu e Masauwu gettò il suo incantesimo su di lui ed entrambi divennero come bambini e per tutta la notte giocarono insieme e Masauwu non diede al dottore un attimo di tregua.
Non molto tempo dopo il dottor Fewkes se ne andò, ma ciò non dipese dal vaiolo, come voi ora sapete.
Quando e come sia nata la leggenda, che cosa abbia voluto riflettere nella sua versione originale ed in che modo vi sia entrato l'archeologo, Nequatewa non lo sa. E il dottor Fewkes non è più qui a dircelo.
Capitolo VI - Viaggi nel passato: Gli astri venuti dal nord
Come abbiamo avuto occasione di dire nel lavoro «Il pianeta sconosciuto», le indagini scientifiche condotte sulla misteriosa isola di Pasqua confermano principalmente due cose: che quel lembo di terra venne occupato, con ogni probabilità, da popolazioni sudamericane (sembra sia stato Tinca Tupak Yupanqui, con i suoi uomini, ad approdare all'isola nel 1450) e che gli attuali abitanti di Pasqua sono in gran parte di origine indonesiana, provenienti dall'isola di Raiatea (o Rangitea).
Ma c'è ancora qualcosa d'inquietante a Pasqua: dalle gallerie terminanti tutte in mare agli ossari giganteschi, dai disegni che ricordano quelli di terre lontane alle enormi statue per le quali, soprattutto, l'isola è arcinota.
Ora, è vero che si tratta delle raffigurazioni degli antenati degli abitanti, risalenti a non oltre 6 secoli (le più vecchie sono della metà del 1300), ma qualcuna apre la via al dubbio: e se gli ultimi pasquani avessero imitato monumenti più antichi, trovati al loro arrivo?
Fra le statue non erette che giacciono sul fianco del vulcano Rano Raraku ne esistono tre completamente atipiche rispetto alle altre: una porta una barba di tipo «faraonico», un'altra rivela dai seni (contrariamente al solito) il sesso femminile e la terza - dissepolta ed eretta da Thor Heyerdahl - è abbondantemente barbuta. Qualcuno la vuole di origine americana, qualcun altro obietta che le popolazioni andine non avevano barba prima dell'incontro con i conquistatori spagnoli. Ma non si potrebbe opporre a quest'ultima affermazione il dio Viracocha e tutta la coorte di favolosi personaggi barbuti che popolano le tradizioni incaiche e preincaiche?
Venere guerriera
Appare quindi sostenibile (anche per altri motivi) che ad approdare alla misteriosa «terra dei giganti», forse in seguito a lunghi viaggi di esplorazione, forse casualmente, forse favoriti in ciò dagli scali intermedi forniti da isole ora sommerse, siano stati, come, del resto, in America, genti provenienti da molte parti del globo.
Ma che un legame ben solido esista con la Polinesia è dimostrato da indiscutibili riferimenti astronomici.
«Sapendo che gli astri stavano alla base delle vecchie religioni o, almeno, rivestivano un notevole ruolo», scrive uno dei più autorevoli studiosi contemporanei di Pasqua, Jean Bianco, «e che nelle antiche scritture decifrate o in via di esserlo, le costellazioni, il Sole, la Luna e i pianeti sono rappresentati con glifi o altri segni, è evidente che se i polinesiani avevano credenze simili avremmo dovuto trovarne tracce nelle vecchie leggende e pensare che pure le tavolette dell'isola di Pasqua racchiudessero tali vecchi racconti».
Così, infatti, è stato. Riportiamo qui di seguito pochi elementi dei moltissimi raccolti da Bianco:
«Il segno 522 f (ariki = re) si trova nelle narrazioni tahitiane con Ari'i Fetu tea (Saturno) e Ari'i ta'ero (Mercurio). Dei pianeti, dunque, erano assimilati ai re. Mata (occhi), il segno n. 20 delle tavolette pasquane, è la denominazione delle Pleiadi nei vari dialetti polinesiani: Matariki, Matali'i, Matari'i, eccetera. A Pasqua Marte si chiama Matamea (occhio rossastro): quest'espressione è conosciuta anche alle Samoa, come il segno 22, Nga Waka, "le piroghe", che indica Alfa e Beta del Centauro».
Anche in Polinesia, come in altre parti del mondo, sono esistiti osservatori astronomici. Quelli delle isole Gambier (o Mangareva), le più vicine a Pasqua, erano diretti da saggi che la tradizione ci dice capaci di predire gli anni di abbondanza e quelli di carestia, di annunciare i venti e le variazioni meteorologiche.
Un altro osservatorio era posto sulle isole Tonga e si dice abbia avuto l'aspetto di un «frammento di Stonehenge» (Jacques Dieu). Ad un uso analogo sembrano essere serviti quelli che un tempo parvero semplici menhir eretti in Nuova Zelanda.
Ebbene, anche a Pasqua troviamo traccia di un osservatorio destinato ad indicare i solstizi e gli equinozi, scoperto dalla spedizione Heyerdahl nel 1955-56.
Uno dei misteri astronomici dell'«isola dei giganti» è costituito dalla conoscenza del pianeta Mercurio. Noi non lo possiamo vedere, in condizioni atmosferiche ottimali, che al mattino e alla sera, relativamente vicino all'orizzonte; ed a queste difficoltà si aggiunge la velocità del suo moto.
Eppure Mercurio è conosciuto dai Pasquani e dai polinesiani in genere. «Poi viene Ta'ero (Mercurio), vicino al Sole», dicono le loro antichissime descrizioni del firmamento.
E parlano chiaramente del moto dei pianeti attorno al Sole: «Tutti i corpi celesti sono là», leggiamo, «per abbellire la rozza dimora, per passare davanti alla stella che guida».
Mercurio è conosciuto alle Tonga come Ta'elo, alle Marchesi come Takeo, in Nuova Zelanda come Takero, alle Samoa come Takelo, alle Hawaii come Kaelo, ma anche come Uka Lialii, «colui che segue il capo» (o «il re»).
Stranamente Venere è, a Pasqua, la stella di una figura leggendaria rappresentante un gigante monocolo, non solo, ma anche una terribile divinità guerriera.
Scrive Jean Bianco: «Un glifo (e i suoi derivati) del repertorio di Barthel rappresenta un dio-ciclope, Atua Mata Tahi, e tale denominazione proviene dal canto del prete pasquano Metoro. Questo dio-ciclope sembra essere stato identificato con il grande dio Tu.
«Ritroviamo il qualificativo Atua Mata Tahi in un altro racconto tahitiano, il quale ci dice che questo dio aveva un solo occhio e che vedeva molto chiaramente. Alle Marchesi il dio Tu è pure citato come dio-ciclope, ed un dizionario, riprendendo una vecchia fonte marchesana, ci dice: Mata he riri = Uomo con un solo occhio.
«Il vecchio pasquano aveva dunque ragione e la vista di questo glifo gli ha fatto cantare delle frasi forse riferite ad altre tavolette. Io identifico il dio-ciclope con la stella del mattino e la prima frase della narrazione cantata da Ure vae iko è: "Il dio dalla terribile faccia, accoppiandosi con decisione, produsse il Poporo". Quest'ultima parola è stata tradotta con "fine", "termine". Il dio Tu è conosciuto come dio della guerra e il qualificativo Mata Riri ("occhio terribile", "occhio in collera", "occhio della guerra") gli si addice perfettamente quando leggiamo che i tahitiani di un tempo iniziavano i combattimenti all'alba nascente e che designavano la stella del mattino con il nome "Occhio di Tu". È probabilmente nella stessa ottica che chiamavano il gran dio Ro'o "il dio della pace, il messaggero degli dei". Al lettore scoprire quale stella lo personificasse...».
La scrittura pasquana cela ancora molti enigmi, ma tra questi i più affascinanti sono quelli che ci trasportano in un luogo molto lontano, la favolosa Valle dell'Indo.
Su 270 segni della scrittura propria a questa valle, infatti, ben 130 sono identici a caratteri usati nell'«isola dei giganti». Che vi siano stati importati per mare sembra assurdo: non soltanto la via è lunghissima e piena di incognite non certo piacevoli, ma mancano del tutto, su Pasqua, elementi che possano far pensare ad un'immigrazione dalla Valle dell'Indo. Se tanto fosse avvenuto, se ne sarebbe dovuta trovare almeno una minima traccia, ma non c'è nulla, proprio nulla che richiami sia pur lontanamente quella civiltà, tranne, appunto, i segni a cui abbiamo accennato.
E, poiché alcuni di tali segni si rinvengono, sia pur modificati, in altre parti del pianeta, non si può che tornare alla nostra teoria della matrice comune di tante grandi culture.
Tra queste è poi evidentemente sopravvenuta una diversificazione dovuta ad innumerevoli fattori. Non solo: sono stati elaborati testi relativamente recenti con motivi antichissimi fusi, deformati, irriconoscibili.
Cielo polare sull'Indo
Per cercare di rimettere le cose a posto, sentiamo che cosa ci dice, fra l'altro, la scienziata Lucienne Gérardin:
«All'inizio del ventesimo secolo gli orientalisti credevano ancora che i Veda dell'India costituissero i più vecchi scritti del mondo. Si attribuiva a questi testi sacri un'età di parecchi millenni. Lo stesso accadeva con i sinologi: tratti in inganno dagli eruditi cinesi, credevano che il leggendario imperatore Huang-ti avesse redatto il Yi-King migliaia di anni prima dell'era cristiana. In compenso, questi stessi eruditi (o, piuttosto, i loro colleghi specializzati) non vedevano negli Occidentali di quelle epoche lontane che dei barbari appena capaci d'innalzare le pietre dei megaliti sotto la sapiente direzione dei Celti (dunque di indoeuropei), eroi civilizzatori.
«Rare erano le voci discordanti, come quella di Salomon Reinach, che, durante tutta la sua vita di archeologo, denunciò con veemenza il "miraggio orientale". [...]
«I punti di vista sono ben cambiati negli ultimi decenni, e si deve riconoscere che il "miraggio orientale" era effettivamente un miraggio. Più si studiano le civiltà classiche dell'India antica e della Cina, più si scopre che la loro favolosa antichità è solo immaginaria: la redazione finale dei Veda risale, tutt'al più, al primo millennio prima della nostra era. Gli ultimi testi canonici del brahmanesimo si rivelano di epoca bassa: alcuni Upanishad sono posteriori allo sbocciare dei rami greci nelle pianure dell'Indo!».
Dopo aver citato numerosi altri fatti, la studiosa ricorda che la parte finale dei celebri «Aforismi di Patanjali» sullo yoga è dimostratamente posteriore all'occupazione greca, come altre opere in cui è evidentissimo l'influsso occidentale, ma nota, con encomiabile obiettività:
«Questo non vuol dire che non siano esistite antichissime culture in India. Le scoperte di Mohenjo Daro e di Harappa hanno fatto conoscere una civiltà che non deve nulla agli indoeuropei, essendo anteriore all'arrivo di questi ultimi».
Le traduzioni vediche, comunque, pur essendo di trascrizione relativamente recente, non hanno nulla a che fare né con l'Occidente né con le famose città morte della Valle dell'Indo. La loro origine è infatti, almeno in parte, ben più lontana, proveniente addirittura dall'estremo nord.
In «Fiori di Luna» abbiamo parlato della civiltà un tempo fiorente nell'Artide e ne abbiamo documentato la stretta parentela con espressioni che ritenevamo fino a ieri prettamente mediterranee.
Ebbene, c'è chi è andato oltre, collegando, con prove inconfutabili, l'antica India alle terre polari.
È addirittura un eroe nazionale indiano, Bâl Gangâdhar Tilak, combattente, prima di Gandhi, per l'indipendenza del suo paese, autore di un libro edito nel 1903 ma tradotto in francese solo ai nostri giorni da Jean e Claire Rémy. La tesi che egli sostiene è quella dell'origine artica degli indoeuropei o, almeno, delle loro tradizioni.
Le regioni polari - è noto - non erano un tempo fredde come oggi ed ospitavano popolazioni molto più evolute di quanto generalmente si creda.
Già verso la metà del 1700, Jean Sylvain Bailly, un astronomo francese che fu anche sindaco di Parigi e primo presidente dell'Assemblea Nazionale, morto ghigliottinato (1736-1793) studiò alcune tavole astronomiche portate dall'India da missionari francesi e ne ricavò un'opera considerevolissima, delineando, fra l'altro, la preistoria dell'Europa e dell'Asia, per lui profondamente segnata da un popolo venuto dal Nord ed identificato con quello degli Atlantidi.
I calcoli effettuati da Bailly dimostrarono che le tavole in questione erano completamente false per le latitudini indiane, ma esattissime per una latitudine assai più settentrionale.
L'astronomo parigino giunse quindi alla conclusione che gli antichi popoli nordici «conoscevano la rotondità della Terra, i fenomeni della sfera inclinata, l'obliquità dello zodiaco sull'equatore e la rivoluzione dei pianeti». Venendo al Sud, questi popoli avrebbero diffuso le loro nozioni: ecco perché i Caldei, gli Indiani e i Cinesi, «primi possessori di questi preziosi resti», sarebbero stati soltanto «depositari senza genio».
«Oltre un secolo ed ambienti culturali quasi senza punti comuni separano Jean Sylvain Bailly e Bâl Gangâdhar Tilak, e tuttavia le conclusioni alle quali giungono entrambi sono identiche», scrive Jean Rémy, «sebbene le tesi di Tilak siano sostenute ed esposte in modo più sistematico. Dopo aver passato in rassegna tutte le spiegazioni possibili - geologiche, climatiche ed astronomiche - delle glaciazioni, Tilak si richiama alle principali caratteristiche che si possono osservare all'interno del Circolo Artico: l'assenza del sorgere e del tramontare delle stelle, la notte continua, seguita da una lunga alba, poi giorni e notti consueti, con un lungo giorno risolventesi di nuovo in giorni e notti alterni, infine un lungo crepuscolo seguito nuovamente da una lunga notte; la rotazione completa degli astri da sinistra a destra, l'importanza della Stella Polare, che si trova esattamente sopra l'osservatore, il sorgere del Sole al Sud dopo la lunga notte, eccetera.
«Tilak dimostra, poi, tra l'analisi dei passaggi spesso non spiegati da altri specialisti di studi vedici, che tali caratteristiche si ritrovano in molte occasioni, sia sotto forma di allusioni dirette, sia sotto forma di allusioni mitiche, e termina l'opera con l'analisi delle conferme che possono esservi addotte partendo da altre tradizioni (avestiche, romane, germaniche e celtiche).
«I testi dei trattati rituali e segnatamente le relazioni molto precise relative ai sacrifici (che servivano anche ad indicare il tempo) brulicano di particolari inesplicati: è così che il Devayana e il Pitriyana rappresentavano all'origine una divisione dell'anno in due parti, l'una di luce e l'altra di oscurità, come al Polo Nord, dove abbiamo un giorno di sei mesi e una notte di sei mesi.
«Il Taittirya Brahmano, contiene un passaggio in cui è detto che "un anno degli uomini non è che un giorno degli dei". Anche nel Vendidad Tilak ha trovato un'espressione significativa: "Essi considerano un giorno e una notte quello che è un anno". Ora, al Polo, chiamato il Monte Meru, o dimora degli dei, abbiamo davvero solo un giorno e una notte all'anno».
Parliamo di Iperborei, di Atlantidi: certo è che queste ineccepibili constatazioni sono basilari per la conoscenza del nostro remoto, enigmatico passato.
Chiglie vagabonde
Di Colombo e delle scoperte a lui direttamente o indirettamente legate abbiamo già parlato nella nostra serie di libri dedicati ai misteri della Terra, ma ci sembra ora opportuno aggiungere alle osservazioni precedenti quelle fatte dal geografo sovietico Nikolai Nepomnjascij, che confermano quanto già ci era dato intravedere: che il navigatore genovese, cioè, non scoprì affatto l'America per caso.
Ecco come possiamo riassumere i fatti dall'articolo apparso sulla rivista Molodaja Gvardia.
Già i contemporanei di Colombo avevano rilevato che, facendo partire la spedizione, egli pareva sapere in anticipo che cosa sarebbe stato trovato. Senza questa ipotesi è difficile spiegare l'inaspettata prodigalità della regina Isabella e del suo avaro marito, che diedero due milioni di maravedi, tre navi e 120 uomini di equipaggio all'avventuroso uomo di mare, al quale venne inoltre promesso il titolo di «ammiraglio dell'oceano», con quello di viceré delle nuove terre scoperte.
La corte spagnola, che si trovava in guerra con Granada, non avrebbe finanziato una così rischiosa spedizione, se Colombo non avesse dato convincenti garanzie di trovare oro, perle, spezie e schiavi.
Volgiamoci alle testimonianze di chi partecipò alla storica missione. I venti forti e le correnti marine spaventavano i marinai, che temevano di non poter tornare indietro. Un solo uomo conservò la calma durante tutta la navigazione: Cristoforo Colombo. Egli tranquillizzava l'equipaggio, assicurando che di lì a poco le caravelle avrebbero navigato con il vento in poppa. Come lo sapeva?
All'altezza delle Canarie, Colombo consegnò ai capitani delle navi delle buste che portavano scritto: «Da aprire dopo la tempesta». Nelle lettere contenutevi veniva dato l'ordine di non navigare di notte quando si fosse giunti a settecento leghe (4150 chilometri) dalle Canarie stesse. Ebbene, a tale distanza si trovano le isole del Mare dei Caraibi. Come sapeva Colombo che là ci sarebbe stata la terraferma?
È sorprendente anche il fatto che durante il viaggio il navigatore scrisse due giornali di bordo, uno per sé, l'altro pieno di dati fittizi, per i marinai, in modo che non fossero atterriti dall'enorme distanza che separava la meta dalla Spagna. Infine l'11 ottobre 1492 Colombo annunciò che sarebbe stata avvistata la terra, e il 12 ottobre le sue navi gettarono l'ancora presso le coste americane.
Il genovese aveva dunque avuto dei precursori? Da dove gli venivano le notizie precise sulle rotte oceaniche e sulle terre occidentali?
Negli anni Ottanta del XV secolo egli aveva navigato lungo le coste occidentali dell'Africa, tentando di risolvere un problema che lo tormentava da tempo: avevano ragione i Normanni quando dicevano che le terre da loro scoperte nel settentrione continuavano verso sud fino a congiungersi con l'Africa?
Colombo ebbe fortuna: si trovava a Madera quando vi giunse una nave con l'equipaggio stremato dall'inedia. Prima di morire, il capitano narrò al genovese che la sua imbarcazione era stata portata dalle onde attraverso l'Atlantico e gettata sulla costa di un'isola grandissima. Da lui Colombo ricevette il giornale di viaggio ed una carta delle terre ignote.
L'avvenimento è noto attraverso gli scritti di Las Casas, che accompagnò l'audace genovese in quel suo viaggio.
Altre notizie sulle terre occidentali potevano provenire dalla Chiesa romana, poiché gli ecclesiastici erano al corrente delle scoperte normanne. Basti ricordare che nel 999, quasi mezzo millennio prima di Colombo, Leif Eriksson si era recato nel Vinland con un sacerdote cattolico. Infine, Colombo aveva potuto ascoltare ogni sorta di storie, vere e false, nel porto della sua città natale, che era la miglior fonte di notizie sulle isole, sui venti e sulla vita marinara del tempo.
Raccolti a poco a poco i dati, il genovese seppe esporli ai sovrani spagnoli in modo tanto convincente da riceverne il pieno appoggio.
L'analisi del giornale del grande navigatore dimostra che Colombo non aveva incertezze nella scelta della rotta attraverso le enormi distese oceaniche. Aggirate le Canarie, le sue caravelle si mantennero ostinatamente sul 28 ° parallelo, cioè su quello della Florida, benché tale rotta non potesse condurre né in India né in Indonesia. Grazie a questa scelta, le navi viaggiarono nella fascia dei venti costanti, che soffiano verso ovest sino alle isole del Mare dei Caraibi. Da allora non è stata trovata rotta migliore per la navigazione dal «vecchio» al «nuovo mondo»!
Inoltrandosi nell'ignoto, le navi avrebbero dovuto viaggiare soprattutto di giorno, rallentando o fermandosi di notte. Viceversa, per tutta la durata dell'impresa le caravelle navigarono giorno e notte alla massima velocità, come se l'ammiraglio (pur avendo preso, con le famose lettere, le sue precauzioni) sapesse per certo che non c'era da aspettarsi alcuna sorpresa.
Colombo era tanto sicuro della sua scelta, che si rifiutò recisamente di cambiarla, quando i suoi ufficiali gli dissero di avere avvistato la terraferma verso Sud. Egli sapeva che soltanto la sua rotta era giusta ed avrebbe condotto la spedizione alla meta.
Miguel de Cunas, l'amico d'infanzia di Cristoforo Colombo, che partecipò al suo secondo viaggio, scrisse che quando il genovese dichiarò che Cuba era una parte del Catai (Cina), ciò fu messo in dubbio dapprima da uno, poi da tutti i membri della spedizione.
Allora l'ammiraglio fece ricorso alle minacce e impose all'equipaggio di giurare, secondo una formula evidentemente prestabilita, di «essere sempre d'accordo con il comandante e di non esprimere le proprie opinioni». In tal modo egli fece credere che le terre da lui scoperte fossero solo una parte dell'Asia.
Forse Colombo e i suoi padroni volevano tener nascosta la scoperta dell'America al resto del mondo?
La scienza sta appena cominciando a svelare quest'enigma della storia.
Sembra che Colombo, quindi, fosse decisamente un bugiardo, al contrario di tanti altri suoi predecessori che giunsero, più o meno fortunosamente, al «nuovo mondo».
Non ci dilungheremo sull'argomento, già trattato, ma ci limiteremo a riportare alcune novità e curiosità relative al «celeste impero».
In «Terra senza tempo» avevamo citato il monaco cinese Fa-hien, che, nel 400 d. C., si sarebbe spinto fino allo Sri Lanka (Ceylon) ed alla Malaysia, facendo poi ritorno in patria. Ora Pechino rivendica anche la scoperta dell'America mille anni prima di Colombo. Un altro monaco, Hui-scen, sarebbe giunto nel «nuovo mondo» (da lui chiamato Fusang) nel 458 d. C., rientrando in Asia nel 499.
Lo afferma uno studio di Fang Zong-pu apparso sulla rivista China Reconstructs e lo riferisce il giornalista Auro Rosselli, dicendoci come dalla descrizione della flora il Fusang parrebbe il Messico.
«Fang», aggiunge, «dà credito all'archeologo americano James R. Moriarity di San Diego per il rinvenimento di due ancore di pietra presso la costa della California. Queste ancore risalirebbero addirittura a tremila anni fa. Una scoperta al largo della penisola di Palos Verdes comprende due cilindri di pietra cavi connessi ad un triangolo equilatero. Un altro cilindro di pietra cavo è stato trovato al largo della Punta Medicin. Secondo Fang, ancore di questo tipo erano usate dagli antichi marinai cinesi, perché erano frequenti e poco costose in Cina. Erano rulli usati per la costruzione di strade, scartati e venduti ai marinai.
«Stando a Fang, i Cinesi del primo secolo conoscevano già il timone a poppa (mentre gli antichi Occidentali usavano remi a poppa per dirigersi) e nel terzo secolo avevano imparato a calcolare la velocità delle loro navi, la durata dei loro viaggi e lo sfruttamento dei monsoni. Nel quinto secolo c'erano frequenti scambi di ambasciatori fra i Cinesi ed altri popoli dell'Oriente».
Una datazione ancor più remota è assegnata ai rapporti fra l'Asia e l'America da altri archeologi, a cominciare dal tedesco Robert Heine-Geldern e dallo statunitense Gordon F. Ekholm, i quali ci segnalano, fra l'altro, la somiglianza quasi assoluta di alcuni soggetti ed ornamenti:
- L'aspetto cinese delle volute visibili su vasi di marmo della valle di Ulua e quelle delle tavolette di pietra di Lo-yang (appunto in Cina), come su oggetti di giada.
- La rappresentazione del felino di Chavin, nel Perù (giaguaro?) e quella della tigre asiatica, che portano entrambi un recipiente sul dorso (un mortaio?) e motivi molto simili.
- Specchi rotondi messicani e cinesi, con perforazioni triangolari sui bordi.
- Maschere rituali del Messico, in pietra, della Nuova Zelanda, in legno, e della Cina, in bronzo, tutte decorate con spirali.
Miguel Covarrubias va oltre, accostando il tema delle figure accosciate nei tamburi di bronzo cinesi Sciang o Ciù, nei vasi Sciang, nelle incisioni su legno dei Dayaki del Borneo, nei disegni su fusi nel nordovest statunitense, nel vasellame di Nicoya, in Costa Rica e nelle urne di Marajo, in Brasile.
Alfine c'è chi vede nel disegno del generale cinese Ciang Sun-sung la copia esatta, o quasi, della «stele C» di Copán.
Tutte queste affinità esistono realmente. Ma si tratta di «esportazioni» asiatiche in America o di caratteristiche attinte da entrambi i continenti da una terra scomparsa?
In questo caso si dovrebbe riparlare della mitica Mu.
Capitolo VII - Viaggi nel passato: Alchimia cinese
Nel maggio 1978 gli archeologi cinesi portarono alla luce, nel distretto di Suixian, della provincia di Hebei, una tomba con un corredo funerario composto da oltre 7 mila oggetti, di molti dei quali non si supponeva neppure l'esistenza in quell'epoca, nel 433 a. C., quando venne sepolto il principe Yi, dello stato di Zeng.
La tomba misura 200 metri quadrati e comprende una sala centrale affiancata da tre altre. I sacrifici umani dovevano essere d'uso, in quanto a far compagnia a quello del principe si sono trovati otto scheletri, che si suppongono essere quelli delle favorite, delle danzatrici e dei musicanti.
Yi doveva essere particolarmente amante della musica, in quanto nel suo luogo di eterno riposo si sono trovati strumenti di un'orchestra intera, alcuni dei quali già noti, altri finora sconosciuti in Cina: tamburi, flauti di forme diverse, una siringa identica a quella che in Grecia si attribuiva al dio Pan, 32 pietre sonore ed un gigantesco carillon di bronzo: si compone di 65 campane, e la più grande, che misura 1,53 metri e pesa 203 chilogrammi, non ha pari al mondo neppure oggi. Il supporto di bronzo è tale da reggere ancora egregiamente, da oltre duemila anni, il peso delle tre file di campane (2.500 chilogrammi), le quali rendono lo stesso suono armoniosissimo di un tempo.
Altri tesori archeologici sono stati scoperti nella tomba del re Xi, dei cosiddetti «reami combattenti» (475-221 a. C.). Questo sovrano doveva essere, in vita, più attratto dal corrispondente cinese di Bacco che da quello di Pan. Nel suo sepolcro erano infatti conservati due barattoli ed un vaso di bronzo pesante 6 chilogrammi, ancora pieni di un liquore verde, trasparente, che emana un gradevole odore ed è risultato un insieme di alcol, zucchero e sostanze grasse.
Si sa che il vino era conosciuto in Cina almeno dal XVI secolo a. C. e che funzionari di alto rango presiedevano alla fabbricazione dei liquori.
Il filtro dell'immortalità
Tempo fa, in una nostra pubblicazione, avevamo riferito del rinvenimento, a Mawangtui, in Cina, della mummia di una donna deceduta circa 2.100 anni fa, in stato di ottima conservazione, accompagnata all'aldilà da un ricco corredo funerario e da vesti preziosissime anche dal punto di vista archeologico, fra cui uno splendido abito di seta presentante scene riferite all'oltretomba, alla Terra e al cielo.
Il reperto più straordinario era però costituito dal sudario in cui era avvolta la salma, leggerissimo (pesava soltanto 49 grammi, con una lunghezza di 128 centimetri), fatto di una sostanza simile al nostro chiffon di nailon.
Nailon 21 secoli fa? La cosa pare incredibile, dato che le fibre sintetiche furono realizzate per la prima volta nel 1938, eppure è così.
Oggi sul conto della donna, del suo trapasso e della conservazione del corpo conosciamo molto di più, dopo le ricerche che, nel frattempo, si sono condotte e approfondite.
Si trattava della moglie del primo marchese di Tai, Li Tsang, fatto nobile nel 193 a. C. dopo essere stato cancelliere del principe Tsciang-cia, deceduta all'età di 50 anni, nella stagione dei meloni, come dimostra la presenza dei semi di questo frutto nell'intestino, nell'esofago e nello stomaco. Era alta 1,54, apparteneva al gruppo sanguigno A ed aveva sofferto di parecchie malattie, tra cui una arteriosclerosi generalizzata, tubercolosi, calcoli biliari, ed aveva riportato una frattura all'avambraccio sinistro ed una vertebrale, il che la costringeva a camminare appoggiata ad un bastone.
Tutto ciò è stato dimostrato dall'autopsia e dalle radiografie eseguite a Pechino, che hanno anche accertato la causa della morte, avvenuta subitaneamente in seguito ad un infarto miocardico o ad una grave aritmia provocata da una crisi di arteriosclerosi coronarica suscitata da una colica epatica.
All'epoca della scoperta ci si sorprese non poco dell'ottima conservazione del cadavere, che è stata ora spiegata dai seguenti fatti:
- La profondità della sepoltura. La camera funeraria era posta a 20 metri sotto terra, protetta da un tumulo, e la bara era composta da quattro casse, messe l'una dentro l'altra. Posato su traverse di legno, il sarcofago era coperto da uno strato di carbone di legno spesso da 30 a 40 centimetri e pesante oltre 5 tonnellate, strato che lo proteggeva dall'umidità. Un involucro di argilla bianca, spesso più di un metro, non lasciava passare né l'aria né l'acqua, assicurando una buona tenuta stagna.
- Il liquido in cui era immerso il corpo: gli effetti del mercurio, che lo componevano, sono noti come antisettici e battericidi.
- La rarefazione dell'ossigeno, assorbito dalle offerte funerarie di cibo.
Accanto alla sepoltura della donna ne sono state scoperte altre due, denominate «tomba 2» e «tomba 3». La prima è quella di Li Tsang, la seconda quella di suo figlio. Gli esami hanno dimostrato che i due sono deceduti anteriormente alla loro rispettiva sposa e madre.
Interessantissimi sono anche qui gli oggetti che compongono il corredo funerario: oltre venti volumi di seta nella «tomba 3», con preziosissimi dati concernenti la storia e la filosofia degli antichi Cinesi, libri di prescrizioni mediche, di astronomia, di effemeridi, una carta geografica ed una militare, con altri 316 oggetti archeologicamente notevolissimi.
A proposito di riti funerari e di «parentele» fra popoli geograficamente molto lontani tra loro, va notata l'usanza di porre nella bocca del defunto una piccola cicala di giada o di un'altra pietra: la troviamo sia presso i Cinesi del periodo Han, sia presso gli antichi popoli della Mesoamerica, ovviamente collegate al frinire dell'insetto, che avrebbe dovuto simbolicamente ridare il dono della voce al trapassato.
Nella tomba della marchesa di Tai sono stati rinvenuti, tra gli oggetti che la dovevano accompagnare all'aldilà, farmaci per il trattamento delle malattie cardiache delle quali soffriva, tra cui boccioli di magnolia, scorza di cannella ed altri prodotti vegetali.
A proposito di farmaci, ci sembra interessante sottolineare la scoperta, nel distretto cinese di Wuwei (Kansu) di 92 tavolette di legno di pino e di pioppo contenenti le formule terapeutiche impiegate all'epoca degli Han dell'Est (23-220 d. C.): vi sono incise istruzioni concernenti la chirurgia, la medicina interna, la ginecologia, con il nome delle affezioni, le cause, i sintomi, le manifestazioni, i rimedi e persino le controindicazioni.
I medicinali sono di origine animale, minerale, ma soprattutto vegetali, somministrabili sotto forma di decotti, pillole, polverine, cataplasmi, gocce e supposte.
Alcune tra le malattie così curabili si riferiscono al sistema respiratorio, digestivo, circolatorio, genitale, urinario e ad affezioni febbrili in genere. In chirurgia abbiamo tumori, ascessi, calcoli. Sono, poi, presi in considerazione i malanni che riguardano gli occhi, le orecchie, la cavità orale, la gola. Qualcosa di «nuovo», infine, concerne l'agopuntura, i punti da toccare e le precauzioni da prendere.
È nota l'attenzione che la Cina moderna presta all'antica medicina: migliorate ed arricchite - osserva uno specialista - queste formule sono, per la maggior parte, applicabili anche ai nostri giorni.
Stranamente, nell'antica medicina cinese erano usate sostanze pericolosissime, come composti metallici derivati dall'arsenico, dal mercurio, dal rame, dallo stagno, dal piombo, dal nichel e persino dall'antimonio.
Parecchie conoscenze sconfinano nell'alchimia, ed è curioso notare come gli ingredienti basilari di numerose operazioni alchemiche, primi tra i quali lo zolfo e il mercurio, siano stati comuni alla Cina, all'India, all'Egitto e all'Occidente, proprio come i due scopi principali a cui avrebbero mirato i «maestri occulti»: l'elisir di lunga vita e la tramutazione di metalli vili in oro. In Cina, fra l'altro, venne promulgata, nel 175 a. C., una legge contro la produzione d'oro con metodi alchemici.
Quanto all'elisir di lunga vita, è noto che molte salme di nobili furono ricoperte di piastrelle di giada, il che pareva ritardarne la decomposizione, ma non è altrettanto conosciuto il fatto che l'ingestione di giada poteva - secondo alcuni studiosi dell'«arte somma» - prolungare moltissimo la vita.
Ma come assorbire la giada?
Ecco, alla lettera, la ricetta di Koh Hung, un alchimista cinese del IV secolo d. C.: «La pasta di giada si forma nel seno di montagne che celano giada. La si trova solo in luoghi tagliati a picco e pericolosi. Il succo di giada che cola da queste montagne si coagula in una specie di pasta dopo un periodo di qualche decina di migliaia d'anni. Questa pasta è fresca e limpida come il cristallo. Se ne trovate, schiacciatela e mescolatela con succo di erbe privato delle essenze. Si liquefarà immediatamente. Bevetene allora una pinta e vivrete mille anni... Colui che assorbe giada vivrà tanto quanto durerà la giada; colui che assorbe oro vivrà tanto quanto durerà l'oro. Colui che assorbe la Vera Essenza della Sfera Oscura [la giada] godrà di un'esistenza eterna...».
Fiumi di mercurio
Si è sempre parlato poco di monumenti funerari cinesi, eppure meriterebbero una lunga trattazione per vari motivi: le piramidi, in primo luogo, che anche nell'ex celeste impero accompagnano, come in quasi tutto il resto del mondo, la storia delle grandi civiltà, una storia di cui - come abbiamo visto - solo a poco a poco si schiude qualche spiraglio ignoto.
Se ne occupa l'archeologo e scrittore Patrick Ferryn, il quale inizia il suo studio parlandoci della piramide di Sce Huang-ti (o Ts'in Sce Huang-ti), l'«imperatore giallo», così soprannominato perché fu il primo ad ottenere questo titolo, famoso per avere condotto grandi campagne militari tese a dare alla Cina i suoi confini naturali ed avere fatto iniziare la costruzione della Grande Muraglia.
Il suo tumulo funerario, alto 48 metri all'epoca della scoperta da parte della spedizione Segalen, è a cinque piani e misura 350 metri di lato, con un volume di 1.960.000 metri cubi, il che lo rende, per imponenza, il quarto monumento del mondo, dopo la piramide messicana di Cholula e quelle egizie di Cheope e di Chefren.
«Le serissime cronache dello storico Sseu-ma Ts'ien (135-85 a. C.), citato abbondantemente e molto apprezzato dai sinologi», scrive Ferryn, «ci hanno lasciato informazioni più che curiose a proposito di questo monumento».
Eccone un estratto.
«Sce Huang-ti riuniva nelle sue mani tutto l'impero. I lavoratori che furono mandati alla costruzione del sepolcro erano in numero di oltre 700 mila. Si scavò il suolo fino all'acqua, vi si colò del bronzo e vi si portò il sarcofago. Palazzi, edifici per tutte le amministrazioni, utensili meravigliosi, gioielli ed oggetti rari furono trasportati e sepolti. Degli artigiani ricevettero l'ordine di fabbricare balestre e frecce automatiche: se qualcuno avesse voluto fare un buco ed introdursi nella tomba, gli avrebbero tirato subito addosso.
«Un vero palazzo sotterraneo si ergeva là dove ruscelli di mercurio disegnavano fiumi eterni: delle macchine li facevano colare e li trasmettevano gli uni agli altri. In alto c'erano tutti i segni del cielo, in basso tutte le disposizioni geografiche. Si fabbricarono con grasso di foca torce che si calcolava dovessero durare parecchio tempo.
«Il figlio del sovrano, Eul Sce, disse: "Non bisogna che le donne dell'imperatore deceduto le quali non hanno avuto figli siano messe in libertà" ed ordinò che tutte lo seguissero nella morte; quelle che furono messe a morte erano molte numerose. Quando la bara fu calata, qualcuno dice che gli operai e gli artigiani che avevano fabbricato le macchine e nascosto i tesori sapevano tutto quanto era stato celato nella tomba, ne conoscevano il valore e ne avrebbero divulgato il segreto. Quando i funerali furono terminati e fu chiusa e dissimulata la via centrale che portava al sepolcro, si fece cadere la porta dell'entrata esterna e vi si chiusero dentro tutti coloro i quali erano stati impiegati come operai o come artigiani a nascondere i tesori. Venne poi posta sul tumulo della vegetazione, in modo da farlo assomigliare ad una montagna».
Le analogie con le sepolture egizie sono evidentissime. Quanto alle precauzioni prese, non servirono a nulla: tre anni dopo la morte del sovrano, cioè nel 207 a. C., la tomba (posta a Lin-t'ong, tra Honan e Si-ngan) venne aperta e saccheggiata dal generale Hiang Yu.
In questa regione furono scoperte, specialmente dalla spedizione Segalen, molte altre tombe, senza dubbio assai più modeste, ma non per questo prive d'interesse archeologico: piramidi a gradini, tronche, fra il resto, che richiamano alla mente quelle dell'America precolombiana.
Altre piramidi dovrebbero trovarsi nel deserto di Gobi. Diciamo «dovrebbero» perché è difficilissimo condurre ricerche in questa zona, che si stende per 1.036.000 chilometri quadrati nella Repubblica di Mongolia e nella Mongolia cinese.
Il professore sovietico G. Rudenko ha scoperto comunque, nelle vicinanze della Mongolia Esterna, parecchie tombe (kurgan), resti delle quali sono visibili al Museo dell'Ermitage di Leningrado.
La più strana di tali sepolture è quella denominata «kurgan V», trovata a Pazyryk: oltre ad indumenti, gioielli, strumenti musicali, la bara contiene cibarie, con le mummie di una donna e di un uomo di tipo europeo (scita?) perfettamente conservate, essendo stata la cassa riempita di terra gelata, a cui il legno fungeva da isolante.
Tombe a parte, sono stati rinvenuti nel deserto di Gobi alcuni oggetti che testimoniano l'esistenza di un'antica civiltà. Ci limiteremo a citare, tra questi, perfette carte celesti di 20 mila anni fa e dipinti rappresentanti in modo inequivocabile indiani dell'America meridionale, portati alla luce dall'archeologo britannico Aurel Stein con alcuni vasi di argilla contenenti mercurio.
Al mercurio abbiamo accennato varie volte nel corso di questo capitolo. Ma a che cosa potrebbe essere servito quello di Gobi? Lo scrittore Jacques Bergier non esclude che da tale metallo qualcuno sia potuto partire per produrre energia nucleare ed affaccia l'ipotesi che l'antichissima cultura di Gobi sia stata distrutta da una di quelle tremende guerre combattute con veicoli aerei ed esplosivi d'inaudita potenza di cui parlano i testi sacri indù. Non vogliamo correre con la fantasia, ma dobbiamo notare che nel deserto s'incontrano, come osservano anche gli studiosi sovietici, vaste regioni di terra vetrificata alla lettera.
Il pittore Nicolas Roerich, che esplorò queste regioni dal 1920 al 1925, narra di aver visto un'aeronave metallica levarsi da una valle. E questo ben prima che si cominciasse a parlare di UFO.
«Partita da Darjeeling, in India», scrivono Jacques Bergier e Paul Chwat, «la sua spedizione attraversò l'Himalaya, l'altipiano tibetano e la catena montana di Kun-Lu, per poi inoltrarsi nel Gobi. Nella carovana un pony portava un cofano contenente una misteriosa pietra "la cui radiazione è più forte di quella del radium, ma di un'altra frequenza" (?). Si sarebbe trattato di un frammento caduto dal cielo, conservato, secondo Andrew Tomas, in un tempio di Shambhala».
Il regno del silenzio
Molti ricercatori di enigmi asiatici parlano dei misteriosi regni sotterranei di Shambhala e dell'Agarthi (o Agharti, Agharta), depositari di una miniera di scienze terrestri ed extraterrestri, ma nessuno è mai riuscito a portare la minima prova circa la loro esistenza, sempre che come «prove» non si adducano stranissimi racconti.
Le prove - ci dice qualcuno - si trovano in Tibet, assieme ad altri documenti che, se rivelati, cambierebbero radicalmente la visione che abbiamo del passato remoto della Terra e darebbero agli eventi futuri una svolta imprevedibile.
Ma se i segreti tibetani sono tali - obiettano gli scettici - perché i loro depositari non se ne sono serviti per fermare i Cinesi, perché il Dalai Lama è scappato in India, mentre il Pan'cen Lama ha fatto causa comune con Pechino? E perché i Cinesi stessi non ne hanno fatto uso per rafforzare certe loro posizioni?
In effetti l'interesse suscitato attorno al «regno del silenzio» in Occidente risale alla fine del secolo scorso ed è da attribuire sia a Madame Blavatski, sia ad una schiera di altri «teosofi» ed «antroposofi», benché sin dal 1624 i missionari gesuiti vi fossero giunti e vi avessero stabilito un paio di centri.
Come si sa, la religione attuale dei tibetani è il lamaismo, una particolare forma del buddismo, che sembra essere stato introdotto durante il regno di Sron bstam'sgam po, nella prima metà del 600 d. C. Anteriormente il paese era dominato dalla religione Bön, i cui sacerdoti - i Bön'po - avevano molto degli sciamani.
Tutti hanno sentito parlare degli straordinari poteri di certi monaci di oggi e molti studiosi confermano di aver assistito ad esperimenti in cui l'ipnosi, la telepatia e la concentrazione in generale hanno buona parte.
I sacerdoti in grado di riscaldare o raffreddare il proprio corpo a volontà, di sostenere marce massacranti, di camminare nudi sui ghiacciai non si contano, ma anche su loro le testimonianze dirette non mancano.
A fenomeni più impressionanti, però (come la levitazione, la telecinesi, lo sdoppiamento e così via), nessuno ha assistito di persona. E nessuno ha mai visto scritti stupefacenti o tavolette magiche.
Siamo convinti che il Tibet conservi ancora parecchi segreti, ma ci conviene andare molto cauti in certe asserzioni.
Come giungere a conoscenza di qualcosa di più?
Le autorità culturali di Pechino tacciono. E gli esuli o non vogliono svelare quanto sanno, o non sanno niente.
Capitolo VIII - Viaggi nel passato: Città d'argento, colline d'oro
Nei migliori dizionari enciclopedici, la voce «preistoria» è molto ben definita: «Termine che indica l'insieme delle forme di vita e delle vicende di un determinato popolo anteriormente alle più antiche testimonianze scritte da esso lasciateci e da noi interpretabili».
«Di un determinato popolo», intendiamoci. E la stessa precisazione vale per le diverse età: la paleolitica (età della pietra scheggiata), la neolitica (età della pietra levigata), quella del bronzo e quella del ferro.
Noi viviamo, ormai, nell'«era atomica», come si usa definire il periodo attuale. Ma noi chi?
Noi terrestri, naturalmente, vi risponderà con sufficienza il professore a cui vi rivolgerete, com'è accaduto ad un nostro amico studioso e scrittore nel corso dell'incontro con un docente universitario che, in fatto di archeologia, pontifica, fregiato di diversi titoli.
Ma allora i Romani, gli Incas ed i popoli asiatici che usavano il petrolio vivevano nell'«era degli idrocarburi»? E perché «noi terrestri» non dovremmo classificarci almeno in parte paleolitici, dato che in tutti i continenti, Europa esclusa, vivono ancora genti per cui una pietra scheggiata è già un prezioso mezzo di difesa, di offesa e di lavoro?
Una spedizione extraterrestre sbarcata Filippine, dove si trova il popolo che «teme la Luna, non sapendo che cosa sia», oppure in Amazzonia, oppure presso genti primitive stanziate in Africa, in Asia o in Oceania, ci definirebbe senz'altro così, se non si prendesse la briga di cercare oltre, per poi trarre le debite conclusioni.
«Si tratta di eccezioni», sbufferebbe il sacro archeologo di cui sopra. E noi potremmo anche essere parzialmente d'accordo se queste «eccezioni» non venissero ignorate. Non siamo affatto d'accordo, invece, perché il comodo livellamento che esclude o elimina con un borbottio tutto quanto non rientra negli schemi «ufficiali» travisa la storia dell'umanità, condizionando i futuri ricercatori, i futuri scopritori, i futuri appassionati studiosi (non tutti, per fortuna!) a dogmi inesistenti, frenando il progresso della scienza volta all'esplorazione del nostro passato.
Cosmonauti in Siberia?
Le pitture rupestri abbondano nell'Unione Sovietica, come in quasi tutti gli altri paesi del globo. Ma qui rappresentano, ancor più che altrove, le testimonianze di una preistoria che ben difficilmente potrà essere ricostruita.
L'URSS è immensa, e l'inaccessibilità di molte regioni rende l'opera di ricerca e di studio assai ardua: si pensi che fino al 1971 erano stati registrati soltanto 563 luoghi ospitanti graffiti e disegni preistorici notevoli per estensione ed espressioni artistiche.
Nessuno può sapere, neppure per approssimazione, dove altri posti del genere si possano reperire. Si pensi che soltanto in seguito ai lavori di sviluppo ed elettrificazione in Siberia sono stati scoperti insediamenti preistorici ricchissimi di graffiti, molti dei quali ci prospettano affascinanti misteri.
Nell'Alta Lena, ad esempio, risalta l'incisione di un grosso animale a scaglie dorsali, quasi privo di collo, con fauci enormi, zampe corte, denti anteriori poderosi. Da quanto si riesce ad indovinare, sembra avere un corno sulla fronte e tre scaglie più grandi delle altre sul capo. Non si può paragonare nemmeno lontanamente alle riproduzioni di sauri o di animali comunque estinti reperibili in altre zone. La rappresentazione dell'Alta Lena è tuttavia così realistica da non fare assolutamente pensare ad un frutto della fantasia, la quale, del resto, non era molto in uso presso gli antichissimi disegnatori, alcuni dei quali, però, avevano il dono di stilizzare le loro creazioni in maniera tale da renderle così pregevoli artisticamente quanto incomprensibili scientificamente: è, ad esempio, il caso dell'animale graffito presso il lago di Biljo, nella Siberia meridionale, sulla cui specie gli studiosi si scervellano da tempo: ce chi pensa ad un mammut, chi ad un elefante a proboscide corta (anch'esso da gran tempo estinto), chi a molti altri quadrupedi.
In ambedue i graffiti a cui abbiamo accennato notiamo il segno solare: il mostro a scaglie pare volerlo divorare, mentre l'animale «astratto» se lo lascia tranquillamente tramontare alle spalle.
Questi due graffiti implicano motivi cultuali? Sembra di sì, ma quali? Ce lo avrebbe forse potuto spiegare il signore con il volto attraversato da tre sbarre, senza naso, con occhi e bocca a fessura che troviamo inciso ancora nell'Alta Lena, presso il villaggio di Worobjeva: alcuni lo vogliono, infatti, un potentissimo stregone immortalato nella pietra, altri addirittura un dio. Senza contare, ovviamente, i partigiani della «preistoria cosmonautica», a cui appare l'immancabile esploratore galattico.
Rilievi
 | Fig. 35. Tamgaly e le sue vicinanze. Le stelle indicano i deserti del Kizil Kum e del Kara Kum. |
Leggiamo, infatti, su un settimanale siciliano: «Lo scienziato sovietico Vladimir Avinsky ha una sua precisa teoria sugli extraterrestri: è convinto che gli strani "esseri alati" incisi su oggetti trovati in Siberia e che appartengono all'epoca preistorica altri non siano che esseri di altri pianeti venuti a visitarci nella notte dei tempi».
La stessa impressione è stata suscitata da rappresentazioni che si trovano in gran numero a Tamgaly, a nord-ovest di Alma Ata, nel Kazakistan, dove sorgono i famosi osservatori e laboratori volti principalmente all'applicazione pratica delle nostre conoscenze cosmiche.
Le incisioni sono state scoperte nel 1957 da A. Popov, dell'Accademia delle scienze del Kazakistan. «Non è questo il solo luogo dell'Asia centrale dove si trovano disegni», scrive l'archeologo Miroslav Ksica, dell'Istituto antropologico di Brno, in Cecoslovacchia, «ma esso supera, per la sua abbondanza, i centri più ricchi del Sahara».
Oltre che di incisioni, si tratta anche di sculture, raffiguranti scene familiari, sessuali, agresti e di caccia. «Ma le opere più interessanti sono quelle testimonianti l'esistenza di un culto solare, del quale Tamgaly era senza dubbio il centro, dove i cacciatori ed i pastori dei dintorni accorrevano a venerare i loro totem», ci dice Ksica. «Il culto del Sole doveva derivare dal culto astrale (adorazione dei vari corpi celesti), diffuso soprattutto nei deserti del Kizyl Kum e del Kara Kum, parte dell'antico territorio di Khorezm, dove si sono trovati, specie negli ultimi anni, notevoli tracce di quest'ultimo. Molto interessante è, a tale proposito, la scoperta, effettuata dalle spedizioni sovietiche, dell'enorme tempio di Koj Krylan Kala, con due piattaforme circolari.
«I totem solari hanno la forma di personaggi umani con una testa rotonda rappresentante il Sole e dei punti all'interno del circolo. Il numero di questi punti è sovente dodici, il che porterebbe a credere che riproducessero i mesi dell'anno. Vi sono anche totem più complicati e riccamente decorati. Ad esempio, tra due cerchi concentrici sono inscritti i dodici punti dei mesi. Altri sono più semplici, comprendono, cioè, un cerchio con raggi e punti mancanti. Dipende dalla fantasia dell'artista o si tratta di elementi collegati all'importanza dei vari dei? Il problema resta insoluto.
«Alcune incisioni rappresentano scene complete dei culti. Si può vedere un totem con la testa solare su un albero di forma circolare. Cinque animali difficili da riconoscere sono adunati tutt'intorno. Dodici figure (come quelle dei mesi), alcune delle quali mascherate, stanno in primo piano. Dovrebbero danzare in cerchio attorno agli animali, all'albero e al totem: ma questo tema è arduo da trattare per l'artista primitivo, che ha semplificato il suo disegno.
«Un'altra scena rappresenta tre figure danzanti vestite con pellicce d'orso, con una lunga coda, le quali tengono in mano uno strumento. Si tratta di un tamburino? I motivi solari sono completati da dischi con lunghi raggi e carri solari richiamanti i carri cretesi e sahariani a due ruote».
Vi sono, ovviamente, anche altre interpretazioni: i due personaggi accostati potrebbero simboleggiare il Sole (quello a sinistra, con un diadema più ricco) e la Luna, mentre i punti interni - diversi per numero, tanto nella coppia che nel «totem solare» - potrebbero essere i corpi celesti fatti segno ad una particolare attenzione.
Per i sostenitori delle «ipotesi cosmiche», invece, il significato dei graffiti è tutt'altro: anche qui i civilizzatori venuti da mondi lontani sarebbero ricordati con qualcosa preso a raffigurare sia un casco spaziale, sia la loro patria stellare: ai loro piedi starebbero gli uomini, grati degli insegnamenti ricevuti, tra cui l'utilizzazione degli animali, con i maestri iniziati e fattisi a loro volta iniziatori, stilizzati nelle sagome più grandi.
Nei pressi di Sungir, 200 chilometri circa a nordest di Mosca, sono state scoperte sepolture risalenti a 33-40 mila anni fa, a quanto ci dice la stratificazione del terreno.
I corpi riportati alla luce erano ancora abbastanza ben conservati: non peggio, comunque, di quelli sepolti pochi anni fa in zone fredde senza particolari accorgimenti. A sorprendere, però, non è tanto questo, né sono gli ornamenti d'osso e di pietre accuratamente tagliate, cuciti sui vestiti o posti accanto ai defunti, quanto l'abbigliamento di questi ultimi, consistente in camicie-giubbetti senza allacciatura, pantaloni e calzature di cuoio.
Spostiamoci in Asia, a nord dei confini con la Mongolia, sul lago Baikal, nella Siberia sudorientale. Esso costituisce, con la sua profondità massima di 1423 metri, la maggior depressione della Terra (1741 metri sotto il livello del mare), che da qualche tempo viene fatta oggetto di particolare attenzione dai limnologi sovietici.1
Le imprese di questi ricercatori sono senza dubbio eccezionali, anche se non molto conosciute: con i sommergibili Piscis 1 e Piscis 2, ognuno dei quali porta a bordo due uomini, hanno raggiunto la profondità di 1410 metri, restando sott'acqua per tre giorni consecutivi e raccogliendo una grande quantità di dati utili a varie branche della scienza.
Agli esploratori del passato si sono aperti, però, nuovi interrogativi, poiché alcuni reperti non si conciliano con quelli rinvenuti in superficie.
Va notato che sul Baikal sono state scoperte finora 45 grotte, scavate in parte dalla natura, ma sfruttate dall'uomo sin dalle più remote età. In queste caverne troviamo tracce di fuochi, di giacigli, armi di pietra e di osso, con graffiti rappresentanti uomini e animali. Ma quali idee ci possono suggerire queste raffigurazioni, se alcune di esse ci riportano non solo alla vicina Mongolia, ma addirittura alle lontanissime terre artiche e all'America?
Pellerossa e unicorni
Alexei Pavlovic Okladnikov, archeologo, storico ed etnografo dell'Accademia delle scienze dell'URSS, con la sua opera ed il contributo di molti altri studiosi, ci fornisce ulteriori elementi circa la migrazione di numerosi gruppi asiatici dalla Siberia orientale in America, attraverso la «strada di Bering» e la loro diffusione in gran parte del «nuovo mondo».
Queste tesi, esposte con una ricchissima documentazione, non possono assolutamente essere respinte, ma resta il fatto che esse rappresentano soltanto una parte della soluzione del grande enigma concernente le popolazioni americane.
Certo, vi sono state visite dall'Est, ed abbondanti, ma sembra siano state contraccambiate fin da tempi remotissimi.
Robert Charroux riferisce che nel 1964 i Sovietici hanno scoperto nei pressi del lago Uchkov, nel nordest siberiano, scheletri di indiani americani risalenti ad oltre 15 mila anni fa, con corredi di perle, orecchini e collane, mentre nella penisola di Taimir, sempre in Siberia, tra lo Jenissei e il Chatanga, sono stati riportati alla luce resti di abitazioni preistoriche dei pellerossa Tlinkits.
Le «parentele», comunque, non sembrano limitarsi alla Siberia ed all'America del Nord, e ne troviamo una delle tante prove nel Kara Kum, il grande deserto dell'Asia centrale sovietica posto a sud del lago salato di Aral, al centro del Turkmenistan. Là sorgono le cime del Poket Dag, su cui corrono strane leggende, accolte oggi con un sorriso dai giovani a cui le ricordate, perdendovi con la fantasia più di loro nel mondo delle «strade che conducono al di là del cielo», dei cavalli alati, dei cavalieri sfidanti mostri e giganti.
Sono favole, certo, bellissime favole, ma sono nate da qualcosa che non appartiene al mondo dell'irreale: da chissà quali ricordi persi nel tempo, poeticamente deformati, tanto, forse, da indurci ad immaginare superbi eroi percorrere, in trionfo, cavalcanti l'irriducibile unicorno, le strade di città meravigliose.
L'unicorno non è forse mai esistito (non, comunque, come ce lo presentano le fiabe), dei superbi eroi si sono persi i nomi e le gesta, ma le antiche città ci sono, purtroppo ridotte a rovine flagellate dai venti e dalla sabbia. Ne hanno portato alla luce qualcuna, con un lavoro ammirevole, gli archeologi sovietici. Le più antiche sinora scoperte - come ci dice il professor Viktor Sarainidi, dell'Accademia delle scienze dell'URSS - hanno ospitato culture sconosciute almeno ottomila anni prima della nostra era. E queste culture hanno avuto a lungo vita, contro l'ostilità spietata del deserto. Nel III millennio a. C. i loro centri possedevano ancora vaste piazze, larghe strade lastricate, quartieri residenziali, rioni di botteghe artigiane come li possiamo vedere ancora oggi nell'Asia centrale sovietica, edifici probabilmente destinati all'amministrazione ed al culto.
Ed anche qui, a simboleggiare la comunanza di civiltà tanto lontane, si levano sulle tante pietre, quelle, imponenti, delle piramidi a gradini.
L'eroe di acciaio
«Il paesaggio è maestoso: immensi laghi misteriosi sorvolati da gabbiani che si tuffano nelle nuvole, un firmamento costellato di stelle di una grandezza e di una lucentezza eccezionali. E nel sottosuolo roccioso, grandi depositi di corallo, denti di giganteschi pescecani, conchiglie di ogni specie di molluschi. Fossili marini a migliaia di chilometri di distanza dal mare e dagli oceani...».
Così Viktor Surkov incomincia a descriverci la zona dove sono state compiute scoperte che a ragione pensiamo di poter definire sensazionali, poiché fino al 1975 la credevamo percorsa soltanto da nomadi, e dove le ricerche proseguono tuttora con risultati sempre più sorprendenti.
Siamo nel distretto di Murgab, nel Tagikistan, la repubblica sovietica posta a sud-est dell'Uzbekistan, confinante con l'Afghanistan e con il Sinkiang cinese, là dove sorge l'altipiano del Pamir, il «tetto del mondo».
Qui, a 4 mila metri di altitudine, dove nessuno - come abbiamo appena detto - pensava di trovare niente, se non tracce di ardimentose carovane, sono state portate alla luce le rovine di una città progreditissima, circondata da miniere da cui traeva il metallo per i suoi tesori e per quelli che, evidentemente, esportava proprio con la collaborazione dei nomadi: Bazar-dary.
Sono ruderi di edifici in pietra perfetti: alla periferia i quartieri residenziali, nel centro gli edifici destinati al governo, al commercio, alle attività artigiane, che avevano del prodigioso.
«Mi hanno mostrato alcuni documenti scoperti a Bazar-dary», riferisce Surkov. «Sono scritti con inchiostro di china su carte fini, ingiallite dal tempo. I caratteri sono arabi, la lingua è il parsi, cioè il tagico. Questi fogli vennero dunque scritti dai Tagiki, antenati degli attuali abitanti del Pamir».
I frammenti leggibili, rinvenuti dalla spedizione archeologica diretta dalla professoressa Mira Bubnova, si riferiscono ad epoche piuttosto recenti (XII-X secolo d. C.), ma fanno pensare ad una civiltà ben più antica, che già nei tempi protostorici (se non preistorici) doveva avere rapporti con le attuali repubbliche sovietiche dell'Asia centro occidentale e centro orientale, con l'Afghanistan, l'Iran e l'India.
Gli oggetti lasciatici dagli abitanti di quella che Surkov chiama «la città sopra le nuvole» sono tali da renderci l'idea di una vita più che agiata: accanto a ricchissimi monili e suppellettili d'argento, troviamo i resti degli strumenti di lavoro dei minatori, accanto a calamai, tavolette, documenti redatti in modo ineccepibile, giochi degli scacchi ed altri sconosciuti rompicapi con pedine d'argento e di avorio, tessuti finissimi importati da altri paesi e comode pantofole di feltro.
Dal Tagikistan, attraversando il favoloso Uzbekistan, spostiamoci a nord-ovest. Arriveremo nel Turkmenistan, la repubblica sovietica dove sorge il cosmodromo di Baikonur, in un territorio occupato in massima parte dal deserto del Kara Kum, ancor oggi attraversato da carovane di cammelli, un deserto che lascia però posto a grandi frutteti, ad estensioni di floridi vigneti, a campi di cereali, a piantagioni di cotone, a giacimenti di petrolio e salgemma.
Là, con le rampe di lancio, si apre la porta sul futuro. Ma gli archeologi, a partire dal 1966, ne hanno aperta anche una sul passato, con la scoperta di una città che, alla fine del terzo millennio a. C., sorgeva al Sud, vicino al villaggio di Miana, in quella che è stata battezzata Attin-depé, «la collina d'oro» (e si pensa ne esistano altre nei dintorni).
Le case sono belle, razionali, ordinate, ma molti sono gli elementi contrastanti e quelli enigmatici di cui si occupano ancora oggi gli investigatori del passato. Gli abitanti di Attin-depé sembravano praticare essenzialmente l'agricoltura e l'allevamento di bestiame. Ma perché, allora, l'enorme muro difensivo dallo spessore di almeno sei metri? Perché la torre (scoperta nel 1972) che ricorda tanto da vicino gli ziggurat mesopotamici? E come conciliare le stoviglie di argilla, semplicissime, con gli ornamenti d'oro, lapislazzuli e turchese, corniola, agata ed onice, alcuni dei quali fabbricati dai gioiellieri locali, altri importati da terre lontane?
I segni astrali, ed in particolare lunari, posti sulle teste di animali conosciuti (tori, lupi, montoni), quasi tutti di turchese, fanno pensare ad un culto celeste, i sigilli a croce, di bronzo e d'argento, a credenze di cui non abbiamo la più pallida idea.
Al centro dell'enigma turkmeno sta però una statuetta femminile di terracotta, dai tratti molto strani. Gli studiosi pensano sia la raffigurazione della dea della fertilità, poiché la testa è cinta da una ghirlanda e sul suo corpo spiccano i rami di una pianta.
Ma sulle sue spalle spiccano segni che nessuno è riuscito sinora a decifrare, i quali si ripetono in un sigillo di alabastro ed in altre statuette. Il che fa supporre che le radici di Attin-depé affondino in un passato più remoto di quanto sia dato ora credere e che ci troviamo di fronte, con quei segni, ad uno dei più antichi alfabeti del mondo.
Trasferiamoci ora nella Colchide, in quella che era una regione asiatica posta ai piedi del Caucaso, sul Mar Nero. Lo è ancora, anzi, solo che adesso viene chiamata Imerezia e si stende nella Transcaucasia (URSS), all'incirca da nord-ovest di Tbilisi fino al mare.
Gli argonauti vi si avventurarono per conquistare il vello d'oro, ma quel posticino era un tempo popolato da esseri che ispirarono ad Apollonio Rodio il suo poema (appunto le «Argonautiche», in quattro libri), che era prima già noto ad Omero e ad Esiodo, e che farebbe la gioia di moltissimi scrittori di fantascienza se osassero sfruttare i miti più di quanto già fanno. Esso s'incunea in una zona - proprio quella caucasica - che ben a ragione ha dato luogo ad innumerevoli leggende meno conosciute delle avventure di Giasone e Medea, ma ugualmente suffragate da splendidi reperti.
Interpretando un notissimo motivo, l'archeologa Véronique Schiltz scrive: «Se Prometeo è stato legato con catene di bronzo al Caucaso, è per avere rubato agli dei il fuoco che consente la metallurgia ed aver rivelato agli esseri umani "i tesori che la terra nasconde, bronzo, ferro, oro e argento".
«Non solo: il Caucaso è ricco di altri metalli, tra cui il piombo, lo zinco, l'antimonio, l'arsenico, che già i suoi antichi abitanti usavano per farne leghe. Il metallo essenziale alla fabbricazione di un bronzo di buona qualità, lo stagno, mancava però quasi del tutto, se si esclude un giacimento poco importante a Kabardino-Balkarie, nel bacino della Baksan, dove è stato dissepolto un laboratorio metallurgico. Come spiegare, allora, la presenza, nel bronzo di Koban, dal 3 al 12 per cento di stagno? L'interrogativo non è ancora stato risolto. Lo stagno veniva sicuramente importato, forse dall'Asia, forse da ancor più lontano».
Si parla, poi, addirittura di acciaio, e la cosa non sorprende affatto, dati i rinvenimenti a cui abbiamo accennato nei nostri precedenti lavori.
«Batraz, l'eroe di acciaio», ci dice Véronique Schiltz, riferendosi ad una notissima tradizione locale, «"ritemprato" parecchie volte dal giorno della sua nascita, quando ingiallì, piccolo omuncolo di ferro arrugginito, per andare ad immergersi nel mare, è nutrito con ferro fuso e può servirsi del proprio corpo come di un proiettile».
C'è proprio di che trarre uno spunto per uno di quei film utopici tanto di moda al cinema e alla televisione: un robot-proiettile, una specie d'incrocio tra un superman ed un automa invulnerabile. Forse il tema sarebbe più adatto per un cartone animato giapponese. Comunque i diritti sono liberi, essendo i fantautori vissuti migliaia di anni fa.
A proposito di fantascienza, potremmo compiere un viaggio lunghissimo dal passato più remoto al futuro. Il mezzo è semplice: una cintura che trasporta il suo possessore nel tempo e nello spazio, che lo difende da ogni pericolo, che lo rende un eroe ineguagliabile. La troviamo tanto in fiabe antichissime quanto in racconti «avveniristici» e ne abbiamo un prototipo anche nel Caucaso.
Ascoltiamo ancora la nostra studiosa: «Cingersi con una larga cintura non vuol significare solo tenere a posto le proprie vesti, ma anche proteggere gli organi vitali e circondarsi di un cerchio magico avente risonanze cosmiche.
«In georgiano, la stessa parola, qved-i, designa la cintura, l'arcobaleno e la volta celeste. Il folklore e le credenze caucasiche abbondano di questi cerchi magici, che costituiscono per le forze del male limiti invalicabili. Non è certo fortuito il fatto che le immagini animali riprodotte più volentieri sulle fibbie siano quelle del cervo e del cavallo, il cui simbolismo solare è ampiamente attestato».
Proprio come, in altri oggetti artistici, troviamo l'eterna spirale a simboleggiare il cosmo, l'infinito, con un motivo proprio a tanti popoli le cui origini e le cui tradizioni si perdono nella leggenda.
Capitolo IX - Viaggi nel passato: Dal Loch Ness al Sahara
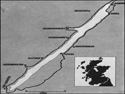 | Fig. 47. Il Loch Ness. |
Nel Loch Ness si cerca ancor sempre il mostro. Le spedizioni si susseguono, i mezzi tecnologici si fanno sempre più sofisticati, ma sinora il gigantesco animale sconosciuto non si è fatto «pescare». È stato visto e rivisto, ha lasciato il suo profilo su apparecchi di rilevamento subacquei, ma ha mantenuto l'anonimato, dando però ai suoi ammiratori quello che sembrerebbe un premio di consolazione.
Il Loch Ness è un lago d'acqua dolce lungo 40 chilometri e largo appena 2, con una profondità media di 150 metri, ma con abissi che superano i 300. Si tratta di un'enorme massa d'acqua (66 milioni di metri cubi circa) che comunica con l'oceano attraverso il canale di Caledonia da una parte e con il Mare del Nord per mezzo del fiume Ness dall'altra. La sua temperatura è bassa (dai 6 ai 7 ° nelle maggiori profondità), ma talmente costante da non farlo mai ghiacciare. Già a 10 metri dalla superficie l'oscurità è quasi totale, il che ostacola considerevolmente le ricerche.
Nel 1960-62 ebbero luogo i primi sondaggi con strumenti idrofonici, condotti in gran parte dai Britannici. Poi vennero gli Americani con il biologo Mac Kal (1965) ed i professori Robert Rines e Martin Klein, dell'Accademia di scienze applicate di Boston, che cominciarono ad operare nel 1970, proseguendo poi con ammirevole perseveranza.
Rines e Klein cercavano, ovviamente, il misterioso animale, ma tendevano anche a raccogliere eventuali ossa appartenute ai suoi antenati. Portarono a galla i rilievi di una vecchia locomotiva e delle carcasse di battelli affondati, con sagome di allineamenti di pietre e di strutture circolari.
All'inizio gli studiosi non prestarono a queste ultime una grande attenzione, non rientrando, ciò, negli scopi dell'impresa, ma il ripetersi di tali scoperte fece sì che l'interesse aumentasse, coinvolgendo anche altri appassionati, tra cui quelli del National Geographical Magazine e del British Subaquatic Club.
I cerchi magici
Le prime ricerche portarono alla scoperta, a circa 10 metri di profondità, di un ammasso di pietre circolare, alto circa 3 metri, avente un diametro di 10 metri, con un altro interno dal diametro di 5 metri.
Il luogo venne battezzato Kleinhenge I, ed alla sua scoperta seguì quella di Kleinhenge II, a maggior profondità, con vari cerchi, di cui uno ha un diametro di 30 metri, un altro di 16.
La caccia a «Nessie» continua, ma si è aperto intanto, sul fondo del lago, un ulteriore enigma, di cui si occupano ora, con Rines, il professor Peter Milne, dell'università di Strathclyde (Glasgow) ed altri scienziati britannici e statunitensi.
Il professor Rines ha formulato l'ipotesi che si tratti delle costruzioni di una lontana civiltà affermatasi prima delle glaciazioni più recenti «durate dal 25.000 al 15.000-10.000 a. C.», mentre altri studiosi propendono per un tempo più vicino al nostro (4.000 a. C. circa).
Quando, da chi furono eretti quei cerchi e perché? Sono tutte domande che restano, per ora, senza risposta, benché le ipotesi si moltiplichino e facciano scrivere articoli su articoli, libri su libri, come avviene con i «cerchi magici» di Stonehenge e di Avebury, al sud dell'Inghilterra.
Quest'ultimo è senza dubbio il più discusso. Venne visitato per la prima volta nel 1646 dall'archeologo John Audrey, ma solo nel 1743 William Stukeley pubblicò il suo libro Abury, che lo fece conoscere al grande pubblico. Ma dovettero trascorrere quasi due secoli prima che - dal 1934 al 1939 - il professor Alexander Keiler desse inizio ai lavori di restauro, facendo rimettere in piedi le grandi pietre cadute e sostituendo quelle mancanti con blocchi di calcestruzzo.
Il complesso comprende un fossato interrotto da quattro strade che s'incrociano, con una cinta che doveva essere formata da cento massi. All'interno si trovano due cerchi ovviamente assai più piccoli, detti «Cerchio Sud» e «Cerchio Centrale». Forse ne esisteva anche un terzo, il «Cerchio Nord», al limite settentrionale del fossato, sulla strada verso Swindon.
Quanto alla datazione ed allo scopo di quest'opera imponente, navighiamo ancora nel mistero. I 4 mila anni circa che le assegnano gli archeologi tradizionalisti sembrano davvero pochi agli esperti che hanno studiato a fondo (finché possibile) la zona e i suoi dintorni. Certo è che la costruzione del monumento è anteriore a quella della via romana che conduceva a Marlborough e gli scheletri rinvenuti nei dintorni ci dicono soltanto come popolazioni molto più vicine a noi nel tempo si siano servite dei «cerchi magici» senza avere affatto partecipato alla loro edificazione.
Ora, noi troviamo riprodotti su scala minore, nel Loch Ness, le stesse strutture di Avebury. A voler essere molto prudenti si può parlare, con i professori Klein e Milne, «della rassomiglianza e di una certa analogia» dei rinvenimenti fatti nel lago con «allineamenti e diversi cerchi di pietra che si trovano nelle isole britanniche, tanto in Inghilterra quanto in Scozia».
Il professor Serge Liégard, che riporta tali pareri, aggiunge: «È a quest'epoca (verso il 2.300 a. C.) che compare nelle isole britanniche una nuova razza dalla testa rotonda, la quale porta i primi strumenti di bronzo e sotterra i suoi morti raggomitolati in piccole tombe individuali poste sovente sotto grandi tumuli. È dimostrato che questi cerchi sono stati realizzati con una grande precisione geometrica, usando unità di misura standard, il che presuppone l'esistenza di una casta di studiosi, preti o scienziati».
Anche a tale proposito c'è chi retrodata di molto la costruzione dei «cerchi magici» del Loch Ness. Quella che non può essere messa in discussione è la questione concernente le misure, calcolate in modo accuratissimo.
Dalla Scozia all'Inghilterra, a molti luoghi dell'Europa continentale, il mistero dei «cerchi magici» continua oltre il Mediterraneo, fin nel cuore dell'Africa.
Riportiamo qui un passo dell'affascinante relazione di Cino Boccazzi, medico, esploratore, archeologo e scrittore:
«La cosa mi è venuta in mente vedendo le grandi tombe disseminate nelle più sperdute località desertiche e, in particolare, quelle del gruppo del Termit, all'estremo sud del Gran Téneré. Sono costruzioni davvero singolari: viste dall'alto sembrano quasi enormi segnali preparati per navigatori extraterrestri. Rotonde, hanno un diametro che va dai 50 agli 80 metri e sono delimitate esternamente da un cerchio di pietre: altri massi, disposti all'interno, paiono formare figure antropomorfe con le braccia alzate».
Ora, il Gran Téneré si trova nel Niger, a sud-est del Tassili-n-Ajjer, dove il ricercatore italiano ha rinvenuto altre eccezionali testimonianze archeologiche.
E il Tassili-n-Ajjer è la patria, per antonomasia, dei «marziani», della «nuova razza dalla testa rotonda»!
Marziani nel deserto
Che cos'è il Sahara? Un deserto confinante ad ovest con l'Oceano Atlantico, ad est con il Mar Rosso, a nord con la catena dell'Atlante ed a sud con le steppe del Sudan. Un'enorme distesa di sabbia e di pietra, il cui clima è determinato dalla mancanza d'equilibrio tra l'acqua ricevuta sotto forma di pioggia e l'importantissima azione dell'evaporazione.
Questa è la famosa estensione che conosciamo, dal punto di vista geografico, ma non è sempre stata così: è ormai stabilito che tale parte dell'Africa ha conosciuto giorni migliori, che ha avuto periodi umidi, la cui esistenza è confermata dalla scoperta, in numerosi luoghi, di una fauna importante e diversificata e di una flora di tipo mediterraneo. Pur considerando già il Sahara una regione desertica, gli autori antichi parlavano dell'esistenza dell'elefante, del leone e del cavallo, animali oggi scomparsi.
Sia dal Nord che dal Sud, insomma, il Sahara venne reso diverso da quello che oggi ci appare da copiose correnti umide, poi cessate per la diminuzione delle fonti d'umidità, l'azione dei venti ed altri fenomeni, in parte dovuti all'uomo, divenuto pastore dopo essere stato cacciatore ed avendo contribuito così all'impoverimento della vegetazione.
Quando la regione era verde ospitò, comunque, civiltà notevolissime, purtroppo assai poco conosciute, ma circa le quali si sono formulate ipotesi che, con il procedere degli studi, divengono sempre più affascinanti.
Il periodo paleolitico arcaico, contraddistinto da pietre scheggiate utilizzate praticamente per ogni scopo, non fu molto lungo: si estese soprattutto ad ovest, circa 500 mila anni fa, seguito da un'era bruscamente inaugurata da invasori venuti dalla Palestina, i quali diedero luogo ad una cultura assai più sviluppata rispetto alla precedente. I suoi rappresentanti si dedicavano alla caccia, come i loro predecessori, ma con tecniche ben più perfezionate. Essi ci hanno lasciato, ad esempio, proiettili di pietra perfettamente sferici che fanno pensare alle bolas, gli strumenti usati ancora dagli Argentini: palle riunite da lacci, che, lanciate, si avviluppano intorno alle gambe degli animali, arrestandone la corsa.
I grandi laghi, e soprattutto il Ciad, erano allora in espansione. Vaste foreste di cedri occupavano quello che è ora il Tassili desertico. La fauna era di tipo etiopico, composta, cioè, di elefanti, giraffe, rinoceronti, coccodrilli. Gli abitanti della vasta regione non godettero, tuttavia, l'ultimo periodo del Sahara fiorente: verso il 7.000 a. C. circa vennero soppiantati da altre genti di cui sappiamo ben poco, ma che diedero comunque origine alla civiltà che ancor oggi affascina scienziati ed appassionati.
Famosi sono i disegni scoperti nel Tassili-n-Ajjer nel 1933 dal tenente Brenans, un ufficiale francese, e resi popolari da Henri Lhote e dai suoi collaboratori, disegni che hanno dato adito alle più diverse ed ardite interpretazioni.
Il Tassili-n-Ajjer è un altopiano di arenaria friabile lungo 800 chilometri e largo una sessantina, esteso nel mezzo del Sahara, a nord del penepiano dell'Hoggar.
Lo studioso Jean Gossart, trattando dei notissimi affreschi, distingue vari periodi. Il primo (datato dal 6 al 4 mila a. C.) è certo il più enigmatico e viene denominato da Gossart stesso «periodo del bubalo [un bovino africano] e delle Teste Rotonde».
Esso è tra quelli che pongono i maggiori problemi ai ricercatori e che hanno fatto scorrere fiumi d'inchiostro, perché a quest'epoca vengono datati i celebri disegni ormai chiamati anche dagli archeologi tradizionalisti «marziani». Qui dominavano molto spesso personaggi cornuti. La testa è tonda e grossa rispetto al corpo. Si tratta senza dubbio di scene di caccia o di guerra (sebbene manchino di elementi per un'interpretazione corretta), poiché i personaggi sono armati di archi e di pali. Salvo qualche caso, i dipinti sono monocromi, in ocra rossa o viola.
Più evoluti, ancor più misteriosi, gli stadi seguenti: la pittura diviene policroma, ma le caratteristiche principali restano le stesse: la testa è tonda, sovente senza indicazione dei tratti del viso, ornata con motivi geometrici diversi. I personaggi sono più alti, raggiungono a volte proporzioni gigantesche. Gli animali sono abbondantemente rappresentati. Si tratta sempre di una fauna propria al clima umido: antilopi, elefanti, rinoceronti.
«L'interpretazione degli affreschi è praticamente impossibile ai tempi attuali», scrive Gossart, che non è certo un «fantarcheologo». «Vi vediamo un grande personaggio centrale, alto 3,25 metri. Le braccia sono levate, le gambe divaricate. Tra le cosce pende, dietro il sesso, perfettamente riconoscibile, una sorta di grosso sacco. La testa ha una forma inconsueta, incomprensibile. Dev'essere, in ogni caso, un personaggio importante, poiché tutti gli altri attori della scena levano verso lui le braccia in gesto di preghiera.
«Non posso passare sotto silenzio quello che Lhote ha chiamato ben incautamente "il grande dio marziano". Questo disegno gigantesco doveva misurare all'origine più o meno sei metri di altezza, tenuto conto del fatto che la parte inferiore è andata distrutta.
«Malgrado la nostra prudenza ormai leggendaria, dobbiamo ammettere che queste Teste Rotonde hanno davvero un'aria extraterrestre. Le linee orizzontali all'altezza del collo fanno pensare alle pieghe di un elemento di raccordo tra il casco e lo scafandro propriamente detto».
Il bello è che in tale periodo compare anche, nella medesima zona, un altro stile, più vicino alla realtà, ma del tutto diverso da quelli conosciuti. Gossart lo chiama «stile bovidico», e di esso ci è notissima la «dama bianca di Aouanrhet», una snella figura in corsa affrescata da lunghe corna e da una nuvola di puntini che sembrano gocce.
Il nome dato dallo studioso a questo tipo di scene è dovuto al fatto che abbondano le figure bovine. Ma quelle umane non mancano, e neppure i «suggerimenti spaziali».
Abbiamo, tra l'altro, la raffigurazione di una donna snella, elegante nei movimenti, con un'acconciatura complicatissima. La nostra «diva rupestre» è stata battezzata Antinea, e il nome della romanzesca sovrana dell'Atlantide di Pierre Benoit non è certo applicato a sproposito: moltissimi archeologi sono d'accordo nel vedervi il ritratto di una regina o di una donna di altissimo rango. Gli «amici degli uranidi» vi scorgono, invece (soprattutto per la forma del seno e la capigliatura, che a loro pare un copricapo), una bella «aliena» dal ruolo non indifferente nell'ignota civiltà della quale ci stiamo occupando.
Il tipo con il capo cornuto e il «grande dio marziano» sono certo i disegni più noti agli appassionati dell'insolito, ma ne esistono ben altri. E se alcuni possono trovare una spiegazione con l'influsso egizio, ve ne sono di quelli del tutto inclassificabili.
Passeggiavano nello spazio
Addirittura tratti da un documentario astronautico sembrano i personaggi di Aouanrhet che vengono comunemente definiti «i nuotatori». A parte il fatto che l'immaginazione ci porta a vederli nuotare non nell'acqua, ma nello spazio, vi sono particolari ben strani: una «donna», in alto, con le braccia lunghe e sottili, pare avere (come si esprime qualcuno) «i seni sulla schiena». Ma si tratta, poi, di una donna? E quelle prominenze alle scapole si possono definire «seni»? Il concetto è ovviamente assurdo. Si tratterà forse della stilizzazione di un apparecchio propulsore?
Propendiamo per la «spiegazione cosmica»?
Eccola: si tratta di un uomo vestito con uno scafandro uscito da un'astronave per «passeggiare» con i suoi compagni nello spazio. Porta ovviamente un casco, la cui parte superiore è ben delineata.
Concludiamo, a proposito di questo e d'altro, con una considerazione di Jacques Gossart che condividiamo in pieno:
«Non ho respinto a priori l'idea che si possa trattare di extraterrestri, partendo dal principio che una ipotesi non può essere scartata per la sola ragione che sembrerebbe cervellotica o semplicemente troppo ardita».
Qui sfociamo in un problema più generale, «quello del ragionamento dello studioso di preistoria di fronte al materiale messo a sua disposizione e, in modo particolare, dell'interpretazione dei dipinti preistorici».
«Parliamo, prima di tutto, dell'archeologia "classica"», sottolinea Gossart, «ed apriamo una parentesi per sottolineare la nostra avversione per questo qualificativo "classico", che non significa, in fin dei conti, assolutamente nulla.
«Sarebbe più giusto parlare di archeologi professionisti, nel senso che questi ricercatori vivono del loro lavoro. Per loro è vitale conformarsi alle teorie formulate in precedenza da qualche maestro, cosa dalla quale dipendono sovente le loro promozioni e persino il loro pane quotidiano. È ben noto che certi archeologi di grande levatura hanno fatto scoperte troppo compromettenti. Perciò, prigioniero di un sistema rigido all'estremo, l'archeologo professionista è costretto a basare tutte le sue teorie, tutte le sue interpretazioni, su veri e propri postulati che sarebbe disastroso contestare. Aggiungerò che esistono fortunatamente eccezioni, ma troppo rare.
«Lo studioso professionista di preistoria incaricato di esaminare un affresco, partirà dall'ipotesi dell'uomo preistorico primitivo, e le sue interpretazioni non potranno uscire dal quadro delle preoccupazioni magiche e sessuali. E questo è riportare le civiltà preistoriche all'elementare.
«Abbastanza paradossalmente, il processo di riflessione degli "archeomani" è uguale a quello degli archeologi professionisti. Differisce soltanto la teoria di partenza, che postula la visita, nei tempi preistorici, di essere venuti dal cosmo. Di conseguenza, ogni disegno che sfugge alla nostra comprensione diretta dev'essere posto in relazione con gli extraterrestri. Simboli di magia elementare o rappresentazione di venusiani: vi si lascia una scelta ben limitata!»
Capitolo X - Viaggi dal passato: I custodi della luce
Se il giovane Jean Goldberg fosse stato meno galante, meno curioso e meno chiacchierone, la storia più bizzarra della sua vita non sarebbe giunta fino a noi dalla prima metà del 1700. Come vi sia giunta con tanti particolari, non si sa: sta di fatto che l'amico dal quale l'abbiamo appresa non è il solo a conoscerla, e che in certi ambienti alsaziani in cui gli studi sull'alchimia e su altre arti affini sono di casa, è nota senza alcune varianti.
Il giovane Jean Goldberg non aveva problemi finanziari e tanto meno voglia di lavorare: le sue occupazioni consistevano nel corteggiamento di tutte le belle donne che gli capitavano a tiro, nel gioco e nelle serate trascorse con gli amici all'Auberge du Cheval Noir.
La troverete ancora a Strasburgo, questa simpatica trattoria, benché sia molto meno tenebrosa di quanto si dice sia stata un tempo. Ebbene, fu proprio là che Goldberg incontrò due persone che, a quei tempi, non erano assolutamente use a frequentare locande e, tanto meno, in costumi maschili.
Già, perché si trattava di due donne: la bellissima Sabine e sua madre, la quale non pareva assolutamente tale, dimostrando, a dir tanto, quattro o cinque anni in più della fanciulla. Chi fosse il rispettivo padre e marito delle strane ed affascinanti creature, non si sapeva con certezza: correva voce che si trattasse di un ricco mercante sempre lontano per i suoi traffici con l'Oriente.
Questo - dato il comportamento riservatissimo e l'abbigliamento inconsueto delle donne - non incoraggiava nessuno ad accostarle, nemmeno il pur intraprendente Goldberg. Nonostante ciò, spinto dalla sua invincibile curiosità, una notte decise di seguirle sin dentro la loro casa, penetrandovi da una finestra.
Dopo aver attraversato alcune stanze, il giovanotto vide Sabine e la madre entrare in un grosso armadio. Non resistette alla tentazione, proseguì dietro loro. E visse così la sua più terrificante avventura.
Brancicando tra gli abiti, trovò un passaggio segreto. Vi si avventurò e percorse uno stretto cunicolo rischiarato da una luce giallognola che avrebbe potuto essere benissimo quella delle lampade della sua epoca. Gli sfuggì però, al momento, un particolare: in quel lungo budello non c'erano lampade!
In fondo al corridoio si trovava un piccolo uscio metallico. Applicando la sua consueta tecnica, brillantemente collaudata nel corso di chissà quante avventure amorose, Goldberg si fermò ancora ad ascoltare, quindi schiuse pian piano la porta. Al di là non c'era un'alcova: c'era un posto da cui proveniva un bizzarro chiarore argenteo. Interdetto, il bel Jean vi lanciò uno sguardo, poi, accertato che delle donne non si scorgeva traccia, entrò.
Capitò in uno stanzino che riceveva luce dall'ambiente attiguo e che era zeppo degli oggetti più svariati, accatastati alla rinfusa. E tutti quegli oggetti erano d'oro, d'oro purissimo! Goldberg era figlio di un uomo d'affari e non poteva avere dubbi in proposito. La scoperta gli mozzò logicamente il respiro, ma ad impressionarlo fu soprattutto un altro fatto: quelle a cui si trovava davanti non erano cose per la fabbricazione delle quali s'impiegasse il prezioso metallo: c'erano grosse pentole d'oro, catene d'oro, picconi d'oro!
La spiegazione, quindi, non poteva essere che una: le inquiline di quella enigmatica casa conoscevano il segreto della trasmutazione, erano capaci di cambiare in oro i metalli vili!
Arrivato a quel punto, il giovane Goldberg non aveva più che un desiderio: andarsene di corsa. Stava per metterlo in atto, quando incespicò in qualcosa, cadde lungo disteso. Rialzandosi, prese la via sbagliata. E, spalancato un uscio, urlò di sorpresa e di terrore.
Oltre quella soglia non c'era una stanza né un cortile, non c'era nulla che potesse ricordare un luogo chiuso o aperto, nulla di conosciuto. Dal suolo sorgevano incredibili formazioni cristalline, alte da pochi centimetri a mezzo metro circa, alcune simili a fiori, altre ad aghi, a piramidi, a prismi, a sfere, e tutte emanavano una brillante luce argentea che impediva di scorgere le dimensioni dell'ambiente.
Il giovanotto, barcollando, abbagliato, andò ad urtare contro alcuni alberelli «di vetro» che si spezzarono con un secco crepitio. La paura di venir arso dal fuoco diabolico lo paralizzò, ma subito sparì per lasciare il posto ad un'altra allucinante constatazione: quella luce era completamente fredda!
D'improvviso, come sorte dal nulla, comparvero Sabine e sua madre. Sembrò che dapprima non si rendessero conto dell'accaduto. Poi videro Goldberg, ed i loro occhi scintillarono d'ira. Una delle donne raccolse da terra qualcosa, simile ad una palla d'argento, levò una mano alta sopra il capo. E dalla misteriosa sfera si sprigionò un torrente di scintille multicolori che piovvero ad investire il giovanotto. Gli parve che mille e mille lame sottili lo trafiggessero: gridando e torcendosi, rotolò al suolo. Ma lo spavento fu più forte del dolore, ed il bel Jean riuscì ad imboccare il corridoio, l'armadio, il portone, a lasciarsi alle spalle quella casa che si era rivelata una specie di succursale dell'inferno.
Fiaccole senza fuoco
Elettricità in Francia nel 1700?
Anche prima: Blaise de Vigenère, ad esempio (lo scienziato a cui si debbono parecchie scoperte, tra cui la sintesi e la caratterizzazione dell'acido benzoico), realizzò nella seconda metà del 1500 un rivoluzionario sistema d'illuminazione, che tentò invano di divulgare.
F. Hoefer riferisce, in proposito, che lo studioso «creò artificialmente un sole tanto splendente che una grande sala ne poteva essere illuminata [...] ed esso faceva più effetto di due o tre dozzine di grosse fiaccole».
De Vigenère era un alchimista, un uomo coltissimo. E c'è chi pensa che abbia attinto i principi della sua invenzione - che avrebbe potuto dare una svolta clamorosa alla storia - da antichissime opere orientali.
A qualcosa di analogo aveva forse già posto mano Jechielé, un rabbino francese di rara erudizione, riconosciuto tale anche da Luigi IX il Santo, re di Francia (1214-70), soprattutto per l'invenzione di una lampada abbagliante che s'illuminava spontaneamente. Non conteneva olio né stoppino, ed il suo proprietario l'appendeva a volte alla finestra, di notte, destando ovviamente lo stupore dei passanti.
Jechielé non rivelò mai il segreto di quella lampada ed adottò un sistema molto persuasivo per scoraggiare gli importuni che si ostinavano a saperne di più.
«Toccava un chiodo piantato nel muro del suo laboratorio», scrive Eliphas Levi, «e subito scoccava una scintilla crepitante, bluastra. Guai a chi, in quel preciso istante, avesse toccato il battaglio di ferro della porta: l'indesiderato ospite si sarebbe piegato su se stesso, raggrinzendosi, urlando come se stesse per essere inghiottito dal suolo, scappando, infine, senza chiedere il resto.
«Un giorno una folla ostile si pigiò a quella porta con mormorii e minacce. Gli uomini si tenevano sottobraccio per resistere all'urto ed al preteso terremoto. Il più audace percosse il battaglio con furore. Jechielé toccò il suo chiodo. In un attimo gli assalitori si rovesciarono gli uni sugli altri e fuggirono urlando, come se fossero stati bruciati. Erano sicuri di aver sentito la terra aprirsi ed inghiottirli fino alle ginocchia. Non sapevano in qual modo vi erano usciti, ma per nulla al mondo sarebbero tornati a bussare alla porta dello "stregone". E Jechielé riacquistò così la sua tranquillità.
«Tutto quanto si è detto sulla sua lampada e sul suo chiodo magico prova che aveva scoperto l'elettricità o che, almeno, ne conosceva gli usi principali. Perché questa conoscenza, come la magia, si trasmette come una delle chiavi dell'alta iniziazione».
Del medesimo parere è Robert Charroux, il quale risale, in proposito, addirittura al biblico Mosè, affermando, con altri studiosi, che il patriarca potesse essere stato introdotto a tanto dai preti egizi (non dimentichiamo che la sua mammina adottiva, Thermutis, era figlia del faraone Ramsete II) e che fosse, in un certo senso, un precursore degli alchimisti. Esponendo il pensiero di Maurice Denis-Papin (discendente del celebre inventore), Charroux ci dice come l'«arca dell'alleanza», che si afferma racchiudesse le tavole della legge, la verga di Aronne ed un vaso colmo di manna del deserto (Esodo, XXV), fosse una specie di forziere elettrico capace di produrre forti scariche nell'ordine di 500-700 volt.
Una specifica descrizione dell'arca stessa e di altri passi dell'Antico Testamento è stata da noi data in «Terra senza tempo», dove si accenna anche alle vecchie pile, rinvenute a Bagdad prima e nelle vicinanze della capitale irachena poi, dall'ingegnere tedesco Wilhelm König.
Ci sembra comunque interessante aggiungere quanto ebbe a scrivere, in materia, Andrew Tomas:
«Scavando, König trovò un certo numero di vasi che, per la loro forma, facevano pensare a batterie. Si trattava di brocche contenenti un cilindro di rame, inserito nel quale c'era una barra di ferro, che serviva probabilmente da elettrodo. I bordi del cilindro di rame erano saldati con una lega di piombo per il 60% e di stagno per il 40%. La barra era sorretta da un bocchettone di asfalto ed un disco di rame era adattato al fondo del cilindro. Il bitume era stato utilizzato per l'isolamento; lo spazio tra le pareti del cilindro di rame e la barra di ferro era stato riempito con qualche elettrolito, ma le batterie erano talmente vecchie, che ogni traccia di sostanza chimica era scomparsa».
Affascinato dalla scoperta, il noto studioso Willy Ley incaricò la General Electric di Pittsfield di costruire copie esatte degli strumenti, che, riempiti di solfato di rame in luogo dell'elettrolito sconosciuto, si dimostrarono perfettamente funzionanti.
Ci pare importante ricordare, inoltre, che, ancor sempre in Iraq, altri scienziati hanno scoperto materiale risalente a 4 mila anni fa, che non può essere stato placcato se non mediante l'elettricità.
Il viaggiatore e scrittore spagnolo Barco Centenera - ci ricorda, dal canto suo, Charroux - visitò, nel 1601, le rovine chiamate El Gran Moxo, presso le sorgenti del Rio Paraguay, cioè verso i Sette Sgunas (Sette Laghi) al centro del Mato Grosso, a 14 ° 35 ' di latitudine est e 57 ° 30 ' di latitudine ovest, nelle vicinanza dell'attuale città di Diamantino.
Vi trovò una specie di grande lampada elettrica in buono stato di funzionamento. Certo, non era alimentata da pile o da accumulatori, ma splendeva senza interruzione, e c'è da credere che questa luce sia stata di natura ai nostri tempi conosciuta.
Ecco quanto emerge dalla sua descrizione: «Una colonna sormontata da una luna, o da una grande sfera, che illuminava vivamente i dintorni».
«È straordinario», scrive Charroux, «ma il segreto di questa lampada era senza dubbio universale, poiché agli antipodi, nella Nuova Guinea, nella regione dei monti Wilhelmine, se ne è trovato l'equivalente: sfere del diametro di 3-3,5 metri, composte, si pensa, di una sostanza minerale fluorescente, le quali, montate su colonne, emettevano una luce bianca analoga a quella del neon o delle lampade a vapore di mercurio».
Una scoperta sensazionale sarebbe stata fatta dall'archeologo Harold T. Wilkins: a sud di Arequipa, nel Perù, egli avrebbe rinvenuto una scritta in caratteri indecifrabili, riferita al nascondiglio dell'«oro dell'antico mondo perduto».
Questa iscrizione sarebbe fosforescente, e la sommità delle rocce del monte Ylo irradierebbe una strana luce la cui origine sarebbe ancor oggi sconosciuta. Trasportiamoci, sempre in Perù, nella misteriosa Chan-Chan, e troveremo oggetti di rame placcati d'oro, maschere, bocce, ornamenti placcati d'argento. Ed il placcaggio - nota l'americano Verrill - è tanto perfetto che lo si direbbe un rivestimento elettrolitico.
Un'altra sorpresa ci è riservata dalla tomba del generale cinese Show Chu, vissuto dal 265 al 316 d. C. Accurati esami compiuti su un ornamento metallico ne hanno indicato la composizione in 5% di magnesio, 10% di rame ed 85% di alluminio. Ma l'alluminio viene ricavato per mezzo dell'elettrolisi: è ammissibile che i Cinesi, nel IV secolo della nostra era, conoscessero l'elettricità?
Sembra proprio di sì, e non dovevano essere i soli. Ecco come un antico manoscritto indiano, l'Agastya Samhita, impartisce le nozioni atte a fabbricare una batteria ad elementi secchi:
«Un piatto di rame ben pulito dovrà essere collocato in un recipiente di terracotta. Sarà dapprima ricoperto con solfato di rame ed in seguito con segatura di legno umido. Si metterà poi sulla segatura un piatto di zinco amalgamato con mercurio, al fine di prevenire la polarizzazione. Il contatto produrrà un'energia liquida conosciuta con il doppio nome di Mitra-Varuna. L'acqua è separata da questa corrente in pranavayu ed udanavayu. Si afferma che l'unione di un centinaio di questi elementi produce un effetto molto forte».
Commenta Tomas: «Mitra-Varuna è un'espressione identificabile come catodo-anodo, mentre in pranavayu ed in udanavayu non è difficile scorgere idrogeno ed ossigeno. L'Agastya è conosciuto anche come kumbhayoni, una parola derivata da kumbha, che significa brocca: sono le anfore usate per costruire le batterie».
Parecchi testi del nostro remoto passato - notano Carles e Granger - furono dedicati all'elettricità. Ed il «fuoco che non brucia», fonte di luce ed innocuo per gli adepti, è rimasto vivo nelle tradizioni di molti paesi, in particolare in quelle cinesi e nipponiche. Numerosi anziani giapponesi affermano addirittura di avere conosciuto, nell'infanzia, «maghi» capaci di creare tale fuoco. Ed alcuni recenti lavori sembrano provare che esistevano in Giappone sette segrete come quella degli On Take Jinsa, affiliata allo Shien Toist, che celebravano, ancora alla fine del secolo scorso, «cerimonie del fuoco». Ed esse custodivano il segreto del «fuoco che non brucia».
Il serpente celeste
Indubbiamente, l'elettricità, nel passato, ha già avuto i suoi meriti ed i suoi demeriti. Tra i primi, seguendo le deduzioni di certi audaci studiosi, andrebbe annoverato quello di avere contribuito all'illuminazione di locali che ben difficilmente avrebbero potuto in altro modo conoscere la luce: si allude qui a luoghi totalmente oscuri in cui vennero effettuati disegni miniaturizzati di una perfezione assoluta, disegni che, con tutta sicurezza, non furono introdotti dall'esterno, ma eseguiti nell'interno.
Può darsi che si siano applicati sistemi oggi del tutto ignoti, ma noi, con le nostre conoscenze, non possiamo pensare che all'elettricità.
Giganteschi falò non sarebbero infatti valsi in alcun modo a procurare un'illuminazione tanto forte quanto costante per il compimento di quelle opere ed avrebbero, comunque, lasciato i segni del fumo, mentre specchi riflettenti la luce esterna, per quanto disposti con sistemi ingegnosissimi, non sarebbero serviti a nulla. La dimostrazione è stata tentata nelle profondità delle cripte egizie alcuni anni fa, senza il minimo risultato.
Dobbiamo dunque ricorrere, per una spiegazione, agli «elettricisti occulti» a cui abbiamo appena accennato? Sappiamo benissimo che un «sì» a questa ipotesi suona fantascientifico, ma per ora - ripetiamo - non disponiamo di altro.
I guai combinati dall'elettricità in tempi remoti sono ugualmente assai poco conosciuti: alcuni testi dell'India antica (come quello, tra i tanti, del Mausola Parva, il quale cita «un ferro che lancia la folgore, un gigantesco messaggero di morte che ridusse in cenere le razze dei Vrichnis e degli Anhakas») parlano di armi tremende, ma nessuno è in grado di dire di che cosa in effetti si trattasse.
Sembra di poter procedere su un terreno un po' più sicuro con gli Etruschi ed i loro re di Roma, i quali a più riprese dovettero tentare di usare la tremenda forza del fulmine contro i loro nemici: andò piuttosto bene a Numa Pompilio, malissimo a Tulio Ostilio, che rimase folgorato, mentre una coroncina tutta luccicante andrebbe a Porsenna, il quale, servendosi dell'elettricità, avrebbe liberato i suoi sudditi dalla ferocia di un mostro chiamato, per una bizzarra coincidenza, Volt.
Per i nostri remoti antenati di tutto il mondo, il fulmine fu portatore di vita e di morte, addirittura generatore di forme mostruose.
Le leggende relative alle creazioni ed alle distruzioni operate da «serpenti piumati», «rettili volanti», «uccelli del tuono», non si contano in tutta l'America precolombiana, ed è logico come vengano oggi rinfocolate da considerazioni in parte fantascientifiche, ma in parte tali da fare riflettere anche gli studiosi.
Ne abbiamo già parlato diffusamente nei nostri precedenti lavori, ma, a proposito dell'argomento che stiamo qui trattando, ci sembra interessante accennare ad una versione venuta alla luce soltanto negli ultimi tempi grazie a frammenti raccolti da Charroux e dai suoi collaboratori.
Già una volta - si dice - il grande serpente di fuoco era sceso a sfiorare la Terra, scagliando lampi ammonitori sugli uomini. Gli uomini avevano molto peccato, avevano dimenticato gli dei e le loro leggi. Per generazioni il reprobo si era levato contro il pio, il reo contro l'innocente.
Soltanto pochi, solo i saggi compresero l'ammonimento, costruirono una grande collina in onore degli dei, alta tanto da giungere al cielo, e posero sulla sua sommità la «casa dei giusti».
I tempi si succedettero ai tempi ed il grande serpente di fuoco tornò, più minaccioso che mai, scaraventando fulmini che fecero ribollire le acque, mentre le pianure si aprivano e le montagne vomitavano fiamme. Tutti coloro che, colti dal terrore, avevano tentato di arrampicarsi sulle pendici della collina sacra all'ultimo momento, per trovarvi scampo, perirono.
Solamente i giusti si salvarono e, discendendo dopo che il grande serpente di fuoco fu risalito al cielo, la sua eterna dimora, abbandonarono la collina. E là dove prima fioriva la vita, non trovarono che piccoli esseri, creature mai viste, striscianti sulle tracce delle folgori.
Questo è il sunto di una tradizione ancora viva in molte parti del Messico, oggi trasformata in favola. Ma in una favola che non viene raccontata con leggerezza: in fondo ad essa si percepisce qualcosa d'inquieto, d'incompreso.
A colpire è il fatto che la troviamo presso moltissimi gruppi amerindi, ma soprattutto presso quelli isolati nei dintorni della capitale, i Yuki, i Keres ed altri. Ma la leggenda, più o meno alterata, ha raggiunto anche popolazioni lontane per cui oggi i serpenti mostruosi non rappresentano più che la raffigurazione folcloristica dei peccati capitali.
Prima di proseguire, ci sembra opportuno precisare che il Messico è uno dei paesi più interessanti dal punto di vista etnologico, comprendendo, oltre i bianchi ed i creoli, amerindi e meticci di cui, nonostante i censimenti, non si conosce ancora il numero esatto: vi distinguiamo una vasta concentrazione di Uto-Aztechi al centro e al sud, seguiti da Maya all'est, poi da Hoka, da Oromi, da Atapaski, dai Mixe-Lenca e dagli altri che abbiamo in parte citato.
Le lingue parlate dagli amerindi sono 53, con 137 dialetti aztechi. Ora viene da chiedersi: perché la leggenda è viva da una parte all'altra del paese? Quando è nata e come?
Sono interrogativi a cui possiamo rispondere soltanto per approssimazione. La storia può essersi benissimo diffusa da popolo a popolo, da generazione a generazione. È una vicenda librata a metà fra la torre di Babele, il diluvio universale e le loro innumerevoli varianti che s'incontrano in tutte le parti del mondo, arabescate - per esprimerci in termini semplici - fra il desiderio di avvicinarsi alla divinità, la collera celeste per i misfatti compiuti dagli uomini malvagi e gli sconvolgimenti scatenati da quest'ultima, che possono benissimo identificarsi con catastrofi naturali.
Nel caso della nostra leggenda, osservando che gli elementi più precisi ci vengono forniti dai Yuki e dai Keres, se ne potrebbe vedere l'origine in quel disastro che si scatenò in un'epoca difficilmente databile, ma certo ben remota.
«Nel tardo periodo Ticoman», scrive Hermann Trimborn, «sorse anche la prima piramide cultuale in Messico, che si può definire la più antica costruzione in parte conservata. Essa è situata a Cuicuilco, oggi compresa nella periferia della capitale come Pedregal de San Angel, coperta dalla lava in seguito all'eruzione di un vulcano a sud-ovest, databile prima della nascita di Cristo. Sotto essa giacciono tombe del tempo arcaico, ma anche la piramide in questione fu sommersa dalla lava per un terzo della sua altezza. Si tratta di una costruzione quasi circolare a quattro livelli, elevata su una superficie dal diametro di 135 metri, con un'altezza di 20, composta d'argilla pressata con un mantello di pietre non squadrate. Sul lato orientale, una gradinata conduceva all'altare posto sulla piattaforma».
Fin qui tutto potrebbe sembrare più o meno chiaro. A far scervellare i ricercatori, però, restano il serpente di fuoco e le curiose creature che si direbbero generate dai fulmini da lui scagliati.
Il «rettile volante» non rappresenta certo una novità per gli studiosi delle civiltà dell'America precolombiana, ma nella nostra storia entrano elementi estranei alle altre. Abbiamo senza dubbio a che fare con una catastrofe naturale, ma le sue conseguenze non ci possono impedire di pensare a «qualcosa» che sfugge ad ogni nostro tentativo di spiegazione.
Alla creazione, ad esempio, di quegli indefinibili e quindi inclassificabili esseri che vi compaiono.
A questo punto, su abissi di secoli, ci potrebbe anche tornare alla mente l'incredibile esperimento del dottor Crosse.
Frankenstein 1837
 | Fig. 55. Uno degli "Acari elettrici" prodotti dal dottor Crosse. (Da "Lectures on Electricity", Londra 1849). |
Dopo Cagliostro, Paracelso è tornato alla ribalta nel mondo editoriale e, di conseguenza, tra gli appassionati di magia. Si chiamava, in realtà, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, era medico, filosofo e naturalista, ma i cultori delle cosiddette «scienze esoteriche» lo vedono soprattutto come uno dei creatori dell'Homunculus, un essere tratto (per dirla in termini molto semplici) dalla materia inerte.
Che cosa si può pensare di quest'oscura storia? Nessuno è in grado di chiarirlo, ma il rinvenimento di alcuni curiosissimi documenti ci ha portati a scoprire un suo emulo vissuto nel secolo scorso.
Attorno alla sua casa, di notte, ballavano i diavoli, si davano convegno le anime dannate, mentre dal cielo si scatenavano i fulmini, quasi a maledire quel Prometeo redivivo, l'ateo, il bestemmiatore supremo, colui che tentava di competere con l'Onnipotente, «creando dal nulla la vita».
Questo, almeno, dicevano i vicini di Andrew Crosse. Ma chi era, in realtà, quest'essere infernale, parente prossimo dell'allucinante dottor Frankenstein?
La cosa incominciò nel 1837. Crosse stava indagando sulla formazione artificiale dei cristalli, impregnando con una semplice miscela (acido idrocloridrico ed una soluzione di silicato di potassio) un frammento di roccia porosa (ossido di ferro del Vesuvio) elettrizzato per mezzo di una batteria. Ed ecco, nelle sue parole, quanto accadde:
«Il quattordicesimo giorno dall'inizio di questo esperimento osservai attraverso una lente alcune escrescenze biancastre, pressoché emisferiche, fuoruscenti dalla pietra elettrizzata. Il diciottesimo giorno esse crebbero, emettendo sette o otto filamenti, ognuno dei quali di misura superiore a quella dell'emisfero da cui si erano sviluppati. Il ventesimo giorno queste formazioni avevano assunto l'aspetto di perfetti insetti, sistemati in posizione eretta su alcuni peli che sembravano costituire la loro coda.
«Fino a questo punto non aveva pensato ad esse se non come ad incipienti formazioni minerali. Ma il ventottesimo giorno le minuscole creature mossero le zampe. Devo dire, ora, che ne fui non poco sorpreso. Qualche giorno dopo si staccarono dalla roccia, muovendosi in ogni direzione. Nel corso di poche settimane, circa un centinaio di esse fecero la loro comparsa sulla pietra. Le esaminai al microscopio, notando che le più piccole possedevano sei zampe, le più grandi otto. Pare che questi insetti appartengano al genere degli acari: c'è chi afferma che la loro specie è sconosciuta e chi lo nega.
«Non mi sono mai azzardato ad esprimere un'opinione circa la causa della loro nascita, e ciò per un'ottima ragione: perché non sono capace di farlo. La soluzione più semplice che mi si presentò alla mente mi indusse a collegare la loro origine a uova deposte da insetti, schiusesi in seguito all'azione dell'elettricità, ma non so immaginare uova tali da emettere filamenti divenuti poi peli. Inoltre non sono riuscito a scoprire, nemmeno con le più acute osservazioni, i resti di un guscio.
«Pensai più tardi, come pensano altri, che fossero nati dal liquido ed esaminai quindi attentamente numerosi recipienti contenenti la stessa miscela. In nessuno trovai però traccia di insetti, come non ne scoprii in alcuna parte della stanza».
Crosse eliminò, in esperimenti successivi, la roccia porosa, giungendo ugualmente a produrre i suoi «acari» in soluzioni concentrate di nitrato di rame, solfato di rame e solfato di zinco. La cosa gli riuscì anche con un frammento di quarzo immerso per cinque centimetri in acido fluoridrico contenente silicio in soluzione. «Attraverso il liquido», scrive, «venne fatta passare corrente elettrica per dodici e più mesi... e tre di questi insetti si mostrarono sul pezzo di quarzo. Se uno di essi era gettato, poi, nel liquido in cui era stato generato, annegava immediatamente».
Notevole è il fatto che gli «acari» erano in grado di procreare: essi deponevano uova da cui nascevano esseri identici, i quali sopravvivevano fino all'avvento della stagione fredda, che conduceva fatalmente alla loro estinzione.
Crosse passò a ricerche sempre più complicate, riuscendo ad ottenere un «acaro» persino in una soluzione caustica, che sarebbe stata fatale ad ogni essere vivente. Li creò addirittura nel cloro, ma, benché avessero la forma di insetti perfetti e non si decomponessero fino alla rimozione dell'apparecchio, avvenuta oltre due anni dopo, non si mossero mai e non diedero alcun segno di vita.
Un altro studioso, Weeks, riprese gli esperimenti di Crosse, preparandoli in modo ancor più accurato, prendendo tutte le precauzioni immaginabili per escludere la presenza della sia pur minima traccia di vita animale all'inizio dei lavori. Come il suo maestro, inviò una relazione all'Electrical Society di Londra, sottolineando in particolare due fatti: che senza l'impiego dell'energia elettrica non nascevano dalle soluzioni impiegate insetti di sorta, e che il numero degli «acari prodotti elettricamente» variava a seconda della percentuale di carbonio esistente nelle soluzioni stesse.
Persino Faraday (lo scopritore delle correnti d'induzione, che rese possibile la realizzazione della luce elettrica e la costruzione di motori elettrici) ammise che simili formazioni si presentarono anche nel corso dei suoi esperimenti, sia pur dichiarando di non sapere se esse dovessero venir considerate «creazioni o rivivificazioni».
Più tardi Crosse, dopo le riflessioni del caso, noterà:
«Esiste una similitudine considerevole fra il primo stadio della nascita degli "acari" e le cristallizzazioni di certi minerali prodotti elettricamente. In molte di queste ultime, e specialmente nella formazione di solfato di calcio o di solfato di stronzio, l'inizio è caratterizzato dalla comparsa di macchioline biancastre, come la nascita degli "acari". Le minuscole chiazze si allargano e si allungano in senso verticale, poi il minerale emette filamenti biancastri: lo stesso accade con gli "acari". Sin qui appare arduo scoprire la differenza tra le formazioni minerali e quelle animali, ma poi nelle prime i filamenti si trasformano in prismi a sei facce, rigidi, lucenti, trasparenti, mentre nelle seconde divengono molli, ondeggianti e dotati, infine, di movimento e di vita».
Un'interessantissima osservazione ci viene dallo studioso britannico Rupert Gould, che scrive: «È possibilissimo far crescere dalla materia inerte forme artificiali simulanti creazioni organiche in modo tanto sorprendente quanto misterioso. In certe soluzioni, ad esempio, possono essere create piante artificiali formate attraverso un processo sicuramente meccanico, l'osmosi. Esse sembrano del tutto vive e sono in grado d'imitare addirittura la proprietà ed i movimenti delle cellule organiche. Le "crescite osmotiche" realizzate da Stéphane Leduc, di Nantes, non solo presentano la struttura cellulare della materia vivente, ma ne riproducono alcune funzioni, come l'assorbimento del cibo, il metabolismo e l'escrezione dei rifiuti».
«Crosse ed altri», scrive, dal canto suo, Jacques Bergier, «hanno dunque costruito dei sistemi pseudocristallini che indiscutibilmente possedevano la riproduzione e l'adattamento. Ma una dimostrazione più approfondita ha accertato che questi pseudorganismi non avevano alcuna reazione verso il mondo esterno, alcun organo di senso.
«Si è dunque tentato di perfezionarli aggiungendovi dei colloidi. Si sono in tal modo realizzati dei sistemi che erano alternativamente attratti dalla luce o, al contrario, che si rifugiavano negli angoli oscuri del recipiente da esperimento quando questo veniva parzialmente illuminato.
«Verso il 1950 la scienziata sovietica Lepcinskaja ha sostenuto di aver realizzato sistemi di questo tipo aventi esattamente il comportamento delle cellule.
«Tutti i tentativi, tra cui i miei, di ripetere questi esperimenti, sono falliti, e gli studi della Lepcinskaja sembrano anch'essi finiti nel dimenticatoio. Questo però non vuol dire che con le conoscenze attuali non si possano realizzare sistemi pseudoviventi con una base molto diversa o poco diversa dalla nostra».
Che siamo giunti, senza volerlo e senza sospettarlo, talvolta, a sfiorare la chiave della Creazione? Nessuno è in grado di dirlo. Seguendo tali esperimenti, però, la scienza potrebbe forse aprire uno spiraglio sul grande problema.
Capitolo XI - Viaggi dal passato: Presenze ignote
Si parla con troppa facilità - lo abbiamo detto - di età del rame, del bronzo, del ferro, quasi livellando a tali periodi tutte le civiltà, e si dimenticano spesso (o le si vuole dimenticare, o le si considera strane eccezioni che non fanno testo) le scoperte che dovrebbero indurci a rivedere numerosi concetti, a rigettare pregiudizi ormai insostenibili, a scavare più a fondo in quella preistoria di cui ci limitiamo a mettere alla luce ed a rivoltare i cocci.
Della lavorazione dei metalli abbiamo già discusso abbondantemente nei nostri lavori precedenti, abbiamo cercato di abbozzare, in «Italia, mistero cosmico», le grandi officine di Medznamor, nell'Armenia sovietica, dove «gli operai lavoravano con le mani guantate e la bocca protetta da un filtro», dove si fabbricavano, tra l'altro, pinzette a molla di acciaio nel tremila a. C., ma avremmo parecchio da aggiungere se volessimo fare la storia delle scoperte sin qui effettuate nella metallurgia degli antichi.
Mentre a Medznamor, oltre a produrre acciaio, si sfornavano almeno quattordici varietà di bronzo, negli Urali si profilavano oggetti di ferro di cui non conosciamo l'uso, ad Odessa si tagliavano ossa di animali con una precisione tale da essere consentita soltanto dai nostri più moderni strumenti, come attestano i professori sovietici T. G. Gritsai e I. J. Yatsko.
Si parla ancora di acciaio, ma il più antico sembra essere quello rinvenuto dal naturalista inglese Charles Brewster nell'interno di una roccia calcarea del Cretaceo sotto forma di undici chiodi.
Nei pressi di Dorchester (Massachusetts, USA) si è trovato, in una roccia fatta saltare con la dinamite, un vaso di metallo sconosciuto coperto di incrostazioni d'argento raffiguranti fiori. Ugualmente inclassificabile è il cilindro metallico capitato in mano agli Spagnoli nel XVI secolo durante i lavori compiuti in un'antichissima miniera d'argento.
Robert Charroux, che illustra alcuni di tali casi, aggiunge la relazione pervenutagli da un amico di Lione, Marcel Giraud, concernente la scoperta effettuata in Birmania da un drappello di artiglieria coloniale.
«Il gruppo, di cui faceva parte un sottufficiale», scrive Giraud, «si era addentrato nella foresta vergine. Ad un tratto rinvenne uno strano pilastro in forma di fallo, alto una dozzina di metri, con circa due metri di diametro. Era di un metallo sconosciuto e brillava come se fosse stato appena lucidato.
«Lo si batté con martelli e scalpelli, che però non lasciarono tracce. Risuonava come un corpo pieno.
«Questo fallo era coperto di rilievi, di iscrizioni in caratteri sconosciuti (almeno per quei militari, che non erano specialisti) e di ideogrammi che assomigliavano a quelli di certi monumenti egizi.
«Gli ufficiali del genio pensarono che una buona parte del monumento fosse interrata e calcolarono che per trasportarlo sarebbe stato necessario un treno con una cinquantina di vagoni. Il gruppo dovette poi abbandonare quel teatro di operazioni e l'oggetto è ancor oggi là».
Il «giallo» di von Braun
Spostiamoci nel deserto di Mopimi, in Messico, e troveremo altri cilindri di metallo sconosciuto, sempre di color argenteo, brillanti, di un'età ignota, ma certo molto più vicina alla nostra, dato che sono stati rinvenuti in superficie, con tracce di una caduta e di un rotolio che il tempo avrebbe senza dubbio cancellato.
I cilindri, trattati con estrema precauzione dagli automobilisti che se li erano visti scintillare davanti alle ruote e che avevano subito pensato a cartucce esplosive, vennero consegnati ai primi agenti di polizia incontrati, i quali, a loro volta, li rimisero ad alcune autorità scientifiche della città di Torreon.
I rinvenitori si rivolsero più tardi a queste ultime, per curiosità, ma ne ebbero un responso tanto enigmatico quanto deludente: «Non sono oggetti esplosivi, non rivelano alcuna cavità. Non provengono sicuramente dal luogo in cui sono stati trovati. Non sappiamo a che scopo siano destinati: probabilmente sono caduti da un aereo o da un satellite artificiale».
Gli automobilisti, per niente soddisfatti, pensarono invece ai soliti «dischi volanti», che sembrano prediligere il Messico, con gran parte dell'America centrale e meridionale, tanto che trasmisero la notizia ad un periodico ciclostilato, «OVNI», di Città del Messico.
Com'è noto, noi procediamo con estrema cautela quando si tratta di UFO, e non avremmo neppure segnalato questo caso se la zona in discorso - per i fenomeni che vi si verificano - non fosse stata fatta oggetto di un'attenzione per lo meno inconsueta.
Ecco il testo di una lettera indirizzata dal «Centro culturale della Laguna di Torreon» al professor Adolfo Orozco Torres dell'Istituto di geofisica dell'Università del Messico, sezione «studi speciali»:
«Il luogo al quale alludiamo è situato a nord-est del villaggio di Ceballos (Stato di Durango) ed include una zona esplorata da San José del Centro e Mohovano fino al 27° parallelo, compreso il punto di congiunzione degli Stati di Coahuila, Chihuahua e Durango.
«Fenomeni osservati:
«1 - In certe parti di questa zona la propagazione delle onde hertziane è difficile e talvolta nulla, da cui il nome dato al luogo: Sierra o Zona del Silenzio. Abbiamo osservato il fenomeno con apparecchi riceventi ad alta e bassa frequenza. La causa possibile potrebbe consistere nell'esistenza di un vortice elettronico suscettibile di generare masse di ferro magnetico, ferro esistente a certe profondità. Non è che un'ipotesi.
«2 - Frequenti cadute di meteoriti, di cui abbiamo raccolto campioni.
«3 - Abbondanza di fossili, di cui alcuni, secondo il fisico dottor Carlos Graef Fernandez, risalgono ad oltre 60 milioni di anni. Li si possono raccogliere a fior di terra in settori perfettamente definiti, dove si trovano anche minerali cristallizzati di forma bizzarra.
«4 - Forti e subitanee concentrazioni di energia in forma sporadica, le quali fanno supporre che si tratti di raggi cosmici o neutronici.
«5 - Piccole piante del deserto con caratteri differenti dal normale, probabilmente dovuti a mutazioni.
«6 - Sabato 11 luglio 1970, alle 3,15 del mattino, un razzo nordamericano del tipo Athena cadde nel centro di questa regione, dove avevamo iniziato le nostre osservazioni dall'aprile 1966».
Fino al punto 5, è ovvio, tutto sembrava degno di attenzione, ma anche di esami più particolareggiati. /
Il punto 6, tuttavia, dava luogo ad un interrogativo più che giustificato, quello concernente la caduta dell'Athena.
Ma ecco i fatti. Il 27 marzo 1970 Wernher von Braun piomba inaspettatamente in Messico e chiede l'autorizzazione a costruire a Ceballos una base di osservazione. La richiesta viene respinta, e poco più di tre mesi dopo un razzo statunitense precipita «incidentalmente» proprio nella zona a cui gli USA sono tanto interessati da spedire a Città del Messico il più prestigioso rappresentante del loro ente spaziale.
Il razzo in questione trasporta una capsula di cobalto radioattivo, il che «obbliga» gli Stati Uniti a recuperare il pericoloso elemento ed i loro esperti a risiedere per un certo tempo a Ceballos.
In seguito a tale episodio i giornali messicani si espressero sostanzialmente in questo modo:
È inammissibile che tecnici capaci di mandare uomini sulla Luna, a 400 mila chilometri di distanza, abbiano perduto il controllo di un razzo la cui traiettoria ed il cui combustibile sono minuziosamente controllati, anche con l'ausilio di cervelli elettronici.
Ora, non soltanto il razzo fu deviato, ma si diresse in senso inverso, o quasi, e cadde a 1.200 chilometri di distanza, esattamente in una zona vietata ai Nordamericani, ma nella quale volevano giungere lo stesso.
E come spiegarsi il fatto che un razzo «sperimentale» fosse stato riempito di cobalto radioattivo, se non per giustificare un intervento allo scopo di provvedere alla decontaminazione di un'intera regione?
Una commissione militare nordamericana comandata da un colonnello e dal capitano e ingegnere Carlos Bustamante batté la zona per 24 giorni, raccogliendo vari campioni, riprendendola con fotografie e film a raggi infrarossi, secondo le direttive impartite dai piloti Edward Schultz e John Kleland, del Beach B 50 - N. 702 B, che dirigeva l'operazione. 150 uomini prelevarono saggi di ogni specie.
Il 2 agosto, circa un mese dopo l'incidente, il razzo fu localizzato in una piana presso il ranch di San Ignacio, da dove venne rimosso dal personale statunitense, che prelevò, inoltre, 200 mila tonnellate di terra, con campioni dei terreni adiacenti. Si videro a più riprese camion con rimorchi, con tecnici maneggianti apparecchi scientifici sconosciuti ai Messicani.
Poco prima, nell'aprile 1970, il giornalista Miguel Angel Ruelas, del Siglo de Torreon, aveva indagato sulla Sierra del Silencio, là dove innumerevoli tectiti si trovavano a fior di terra.
«Sono frammenti di meteoriti precipitate parecchi secoli fa», scrive Ruelas. E prosegue: «Accompagnati da Rosendo Aguilera, di Ceballos, da Caledonio Hernandez, un contadino che conosce la regione come il palmo della sua mano, dall'ingegner Harry de la Peña e da Robert Contreras Barrios, laureato in fisica ed astronomica, ci ponemmo alla ricerca delle regioni che spingevano i Nordamericani ad interessarsi a questa zona del globo.
«Fu un'avventura piena di sorprese, a cominciare dall'autenticazione della "regione del silenzio", nella quale i nostri apparecchi radio restavano muti. [...] Trenta chilometri più lontano ci trovammo, infine, sui "sentieri" di pietre nere. Da lontano si aveva la impressione di vedere formiche gigantesche su una strada incatramata.
«Raccogliemmo una quantità di pietre, che erano troppo numerose e di forme troppo bizzarre per essere naturali. Harry de la Pena trovò un pezzo curioso: lungo tre centimetri, con il diametro di uno, aveva un nucleo centrale pietrificato che faceva pensare ad un pezzo di cavo.
«I fratelli Aguilera avevano già raccolto prima pietre somiglianti a teste di viti, un cavo di acciaio con un nodo, un cavo di linea di alta tensione perforato da un capo all'altro ed utensili tra i più usuali. Nei dintorni di Ceballos si sono rinvenute piccole sfere di cristallo simili alle "perle d'etere" usate dai laboratori farmaceutici.
«In tutta la regione gli animali sono vittime di strani fenomeni che, in un altro secolo, sarebbero parsi satanici. Perdono, ad esempio, il senso dell'orientamento, i cani sono in preda ad un terrore di cui non si comprende il motivo, le tartarughe si rovesciano sul dorso e, se le si rimette sulle zampe, si voltano di nuovo e restano in tale posizione fino alla morte».
Sembra che Ceballos e Parrai y Allende, in Chihuahua, siano state definite dalla NASA «luoghi ideali che visitatori extraterrestri sceglierebbero per atterrare sul nostro pianeta». Von Braun avrebbe detto testualmente: «Se fossi un extraterrestre, è nella Sierra del Silencio che deciderei di atterrare. Se non volessi essere scoperto dai radar, dai ricevitori hertziani, né visto dagli uomini».
A proposito dello studioso scomparso e dei misteriosi fenomeni messicani, ascoltiamo Robert Charroux, che ci ha fornito, in proposito, interessantissime informazioni.
«Wernher von Braun», scrive un giornale di Città del Messico, «ricordò l'8 febbraio 1969 che una sonda sovietica del tipo Venus (senza dubbio la Venus 6) si trovò in un punto che faceva credere alla collisione con un enorme aerolite Gli astrofisici indicarono la posizione del corpo celeste ed i tecnici di Baikonur fecero eseguire una virata alla sonda.
«Il fatto strano è che l'aerolito effettuò ugualmente uno scarto nella direzione della sonda stessa, per tornare poi sulla sua rotta originaria e cadere a Ceballos!
«Le ricerche condotte dai Messicani dimostrerebbero che il corpo celeste non si disintegrò al contatto con l'atmosfera: essi osservarono al punto d'impatto una polvere metallica che mostrò al microscopio una composizione enigmatica "come di sfere cave che, prima di scoppiare, dovevano essere riempite con un certo gas".
«Infine, gli abitanti dei villaggi disseminati nel deserto di Mopimi e nella Sierra Mojada, assistono ogni settimana a spettacoli luminosi che cominciano a preoccuparli seriamente, tanto che hanno chiesto la protezione delle forze della polizia federale.
«Nella notte del 14 marzo 1973 i fratelli Ruben e Juan Hernandez vissero una singolare avventura. Lavoravano alla miniera "La Pietra" a Parrai (Chihuahua), quando videro nel cielo un oggetto tondo come una palla di fuoco, con una luce rossastra che pareva osservarli. La luce si avvicinò, tanto che essi s'impaurirono, dando l'allarme a tutto il personale ed alla segretaria di direzione attraverso l'interfono. Uno dei minatori dichiarò: "L'oggetto rimase qualche istante immobile, come se spiasse il movimento nella miniera, poi improvvisamente si diresse ad una velocità incredibile in direzione della Sierra del Silencio".
«Si tratta di una relazione banale, come se ne possono registrare tutti i giorni, ma è un fatto che oggetti sconosciuti luminosi compaiono di notte nei cieli degli Stati di Durango, Chihuahua a Coaquila e tutti spariscono in direzione della Sierra del Silenzio».
Lasciamo le deduzioni agli esperti e le illazioni agli appassionati.
Ricordi di Mu
Abbiamo accennato all'«elettricità» in Nuova Guinea, ma dobbiamo aggiungere che leggende relative a globi luminosi i quali «facevano della notte il giorno» corrono in parecchie isole della Melanesia, della Micronesia e della Polinesia, là dove si sarebbe esteso in gran parte il continente sommerso del Pacifico, Mu, di cui molti lembi di terra oggi affioranti non costituirebbero che le cime di montagne inghiottite dall'oceano.
Qualcuno afferma che fino a poco tempo fa i Pasquani illuminavano le loro abitazioni con «globi molto risplendenti», ma probabilmente si tratta di una delle tante fantasie generate dalla «patria delle grandi teste», a meno che non ci si riferisca ad insetti luminosi racchiusi in un recipiente, come si trovano pure in piena Amazzonia.
Anche i famosi ammutinati del Bounty, i quali sbarcarono nelle Pitcairn (un gruppo di isole situate a 2.000 chilometri da Pasqua) sentirono parlare dalle Tahitiane con cui si unirono, dando luogo all'attuale popolazione, di «luci magiche» accese in un passato alquanto discutibile per datazione. I marinai, però, videro ancora le rovine di antichissime case, di forni, le vestigia di un tempio e statue alte quattro metri, levate su piattaforme.
Pressapoco lo stesso si nota nell'arcipelago delle Caroline, dove si parla del fuoco di un inidentificabile «dio Sole». Qui le rovine si fanno ancora più imponenti, e le maggiori si ergono soprattutto a Ponape, dove si poteva vedere un tempio lungo 90 metri e largo 28 ed un porto con canali confluenti che, perfezionatissimo, sarebbe stato edificato, stando agli indigeni, dal medesimo «dio Sole».
James Churchward, il colonnello e ricercatore britannico (purtroppo sconfinato esageratamente nell'esoterismo) vide in tali costruzioni, come in tutte quelle dell'area del Pacifico, opere degli abitanti di Mu. Egli ci dice come il tempio in questione fosse stato eretto sopra una rete di caverne e di cripte comunicanti per mezzo di un canale, il cui centro sarebbe stato formato da una sala di forma piramidale.
Nell'arcipelago delle Marshall, in Micronesia, l'isola di Kusaie presenta tuttora ruderi analoghi: tra l'altro una collina a forma di cono, circondata da alte mura, mentre i resti titanici della vicina Lele attestano la presenza di una popolazione civile vissuta moltissimi anni fa, con piramidi analoghe a quelle delle isole della Società.
Il luogo più suggestivo sembra però essere l'isola di Tongatabu, nell'arcipelago degli Amici (o di Tonga), a sud delle Samoa, dove si leva un'«arca» megalitica della quale, stranamente, non si trovano fotografie.
«Con grandi difficoltà», scrive Robert Charroux, «siamo riusciti a procurarcene una alla fototeca del Musée de l'Homme.
«Il posto si chiama Haamunga. Vi si vedono due enormi blocchi di pietra sormontati da un terzo, adattato agli altri per mezzo di un incavo. L'arca misura circa quattro metri di altezza e il suo peso totale sarebbe di 95 tonnellate.
«Churchward sottolinea che l'isola è interamente costituita da terra coltivabile e che le cave di pietra più vicine sono situate a 400 chilometri. In queste condizioni, gli antenati dei polinesiani dovevano disporre di navi imponenti e di mezzi perfezionati per trasportare, tagliare ed edificare questa porta monumentale, che si pensa dominasse un complesso architettonico».
«Le isole Marianne o dei Ladroni», riferisce ancora lo scrittore francese, «sono situate in Micronesia, tra i 13 e i 21 ° di longitudine Nord e i 142-144 ° di latitudine Est, a settentrione dell'arcipelago delle Caroline.
«Si tratta di un paese vulcanico, colpito da terribili uragani e da terremoti. Nonostante ciò si vedono ancora importantissime rovine, tra cui, sull'isola Rota, vasti recinti circondati da colonne rotonde che un tempo dovevano sorreggere un tetto.
«Nell'isola Tinian le colonne sono piramidali, come scrisse Churchward: vennero scoperte nel 1835 da Dumont d'Urville, che credette d'identificarvi un tumulo con statue. Alcune delle colonne erano ancora sormontate da una pietra di forma emisferica.
«L'archeologo Larrin Tarr Gill scrisse, a proposito delle colonne stesse: "Tre sono cadute con il loro tasa (copricapo) ancora intatto; tre sono completamente fracassate e le due più grandi giacciono a terra, abbattute da qualche violento terremoto. A forma di piramidi tronche e sormontate da mezze sfere, i pilastri hanno 18 piedi di circonferenza alla base, 11 piedi di altezza e sono assottigliate alla sommità".
«Piramidi si levano a Swallow ed a Kingsmill, ed è possibile, se si crede a certe relazioni, che un forte di pietre vetrificate sia stato costruito in un'isola delle Samoa, sull'orlo di un precipizio di 550 piedi.
«Nelle Hawaii, nelle Marchesi, in Australia e tutto intorno a Tahiti si possono trovare vestigia imponenti, la maggior parte delle quali è rappresentata da piramidi, come quelle scoperte da Thor Heyerdahl a Rapaiti.
«Sono vestigia del continente di Mu?
«Sì, assicurano J. Churchward e L. C. Vincent. E può darsi che abbiano ragione».
Le tracce del diavolo
Le più celebri impronte di piedi umani in una remotissima antichità si trovano senza dubbio nel deserto di Gobi, su una pietra che reca la traccia di una calzatura antica di milioni di anni, e nel Sisher Canyon, nel Nevada, dove si vede la suola di una scarpa con tracce di cuciture risalenti al Triassico.
Non mancano neppure in Europa. La più chiara ci sembra quella - con tanto di tacco - rilevata nei pressi di Caprie, in Val di Susa, da Mario Salomone, un'impronta che gli abitanti del luogo chiamano ancora oggi «zampata del diavolo».
Altre tracce del genere si trovano in Bolivia, conservate nel museo di Cochabamba, nelle montagne peruviane ed a nove chilometri da Tahiti, presso Punauia, dove, secondo le leggende, non Belzebù, ma il dio Hira avrebbe posato il piede.
Sia che guizzino tra i fumi della tradizione divinità o demoni, queste impronte non hanno nulla di eccezionale (data la diversità del terreno da quello attuale), se non una cosa: quella riguardante la loro età, che risale addirittura al periodo dei giganteschi sauri, il "che fa concludere ad Andrew Tomas: «Si giunge a due sole deduzioni: o l'uomo apparve sulla Terra milioni di anni prima di quelli assegnatigli dalla scienza, o visitatori provenienti dal cosmo sbarcarono sul nostro pianeta. E sono due deduzioni ugualmente fantastiche».
Vista la forma delle orme, considerate le incisioni di Ica, con moltissimi altri fattori, la prima ipotesi ci pare senz'altro la più attendibile.
Ma è a qualcos'altro che vorremmo qui accennare: alla teoria secondo cui le peste sarebbero state impresse su una roccia in precedenza «ammorbidita» artificialmente, poi tornata al suo stato naturale. Tale processo ci sembra per parecchie, ovvie ragioni, del tutto assurdo, ma dà l'avvio ad un altro problema che, per quanto ci sembri fantastico, venne a suo tempo prospettato da pubblicazioni serie di tutto il globo.
Si trattava, in poche parole, di questo: un religioso avrebbe scoperto, in Sudamerica, una miscela di succhi vegetali tali da sciogliere la roccia, la quale si sarebbe, in seguito, spontaneamente riconsolidata. Va da sé che tanto spiegherebbe come i massi di numerosissimi monumenti siano così esattamente connessi da non consentire l'intrusione di una lama di coltello, sia pure sottilissima.
Negli anni 1967-68 una rivista scientifica internazionale ci incaricò d'indagare in tal senso. Riuscimmo a sapere che il presunto scopritore risiedeva in Perù ed apparteneva alla congregazione cattolica dei Salesiani. Ci informammo presso autorevoli rappresentanti della «Pia Società», ma non riuscimmo ad avere la minima indicazione.
Più tardi, Charroux sembrò avere maggior fortuna, tanto che ci disse testualmente: «Nel giugno 1967 si apprese che un prete peruviano, padre Jorge Lira, aveva scoperto il procedimento usato dagli Incas, basato su un succo di erbe il quale rendeva il materiale malleabile a volontà. Padre Lira avrebbe effettuato con successo alcuni esperimenti, facendo macerare piccole pietre nel liquido estratto dai vegetali miracolosi. Il suo nome non si conosce, ma Beltran Garcia, un discendente di Garcilaso de la Vega, sembra conoscere il segreto, che andrebbe ricercato in tre varietà di piante».
Se tanto corrisponde a verità, ci sorprende come il signor Garcia non intenda divulgare il segreto stesso: oltre a non nuocere a nessuno, esso apporterebbe un grandioso contributo sia al progresso che alle nostre conoscenze scientifiche in genere.
Capitolo XII - Viaggi dal passato: Realtà fantastiche
Osservato ed utilizzato in Cina, e probabilmente anche altrove, fin da tempi remotissimi, il magnetismo rimase sconosciuto in Occidente sino al XII secolo, con l'introduzione della bussola da parte degli arabi e di alcune invenzioni portate dai crociati e dagli invasori mongoli.
Lo studioso Jules Duhem ci fa però notare che l'idea di vincere la pesantezza attraverso un campo magnetico è antichissima, ed è Plinio a parlarne per primo nell'area mediterranea, nella sua Naturalis Historia, accennando a certe levitazioni prodigiose compiute dagli Egizi, dicendoci come l'architetto Dinocrate (chiamato anche Timocrate o Chirocrate) avesse rivestito di lastre calamitate la volta del tempio di Arsinoe (oggi el-Fayyûm) per mostrarvi simulacri sospesi in aria.
Si ha ragione di credere che i preti egizi conoscessero bene quest'artificio: uno dei loro «prodigi» più famosi consisteva nel provocare l'ascesa di un disco di metallo raffigurante il Sole nel grande tempio di Serapide, presso Alessandria. Rufino, il monaco di Aquileia che lo vide con i suoi occhi, pensò ad un effetto magnetico, pur senza immaginare la manovra di parecchie calamite nascoste, capaci di sostenere l'idolo.
San Prospero esprime il medesimo parere, ma parla di una quadriga di ferro rappresentante il carro solare, in luogo del semplice disco. E crede che l'artificio «sia fatto dal demonio».
Luciano, dal canto suo, dice semplicemente di aver visto i preti siriaci mostrare in pubblico il simulacro del loro dio «sospeso in aria»: un ingegnoso impiego di calamite realizzava senza dubbio il «miracolo».
Cassiodoro parla di un Cupido di ferro che «si teneva sospeso nel tempio di Diana senza toccare nulla». Il segreto appare comunque diffuso in varie parti del globo che ebbero rapporti con l'Egitto.
Un prodigio notissimo nel mondo islamico è quello della bara di Maometto, trattenuta al soffitto della moschea di Haram, nella città di Medina, senza alcuna causa apparente, ma con ogni probabilità attratta da potenti calamite, come già sospettò verso la fine del 1400 l'umanista greco Demetrio Calcòndila, vissuto a Firenze ed a Milano, con il suo collega protestante Celio Secondo Curione, il quale studiò il problema circa un secolo dopo.
Più sorprendente ancora è il fenomeno della «bacchetta volante», mostrata a lungo nella cappella del monastero del Bizan (oggi Bidjen), in Etiopia.
Una lunga relazione in proposito venne stesa da padre Francisco Alvarez, inviato laggiù come segretario dell'ambasciatore portoghese nel 1515. Il religioso attesta di aver ammirato, come innumerevoli pellegrini prima di lui, «una bacchetta d'oro o dorata, sospesa in aria senza sostegno di sorta», della quale afferma di aver verificato in tutti i modi l'isolamento.
Il racconto di Alvarez venne confermato da moltissimi eruditi europei, ai quali fu concesso ugualmente di assicurarsi che non esisteva alcun trucco. Circa l'esperienza fatta dal medico francese Charles-Jacques Poncet, che attraversò l'Etiopia dal 1690 al 1700, così riferisce un cronista:
«Poncet volle vedere con i propri occhi il prodigio, e la sua testimonianza è esplicita. Ad altezza d'uomo "galleggiava" nell'aria una bacchetta d'oro lunga quattro piedi, tonda, grossa come un forte bastone. Dubitando dell'esistenza di qualche artificio, egli ricevette dall'abate il permesso di verificare a proprio piacere. Passò quindi una verga sopra, sotto, da ogni lato, giungendo alla constatazione che la bacchetta era davvero sospesa in aria. Ne fu più che stupito, non avendo accertato - come assicura - alcuna causa naturale di un effetto tanto prodigioso».
Altrettanto stupefatti restarono certo gli esploratori e studiosi britannici, tedeschi, francesi, italiani e spagnoli che, sia pure in maniera frammentaria o a titolo di curiosità, ci parlarono del fenomeno.
La bacchetta scomparve forse verso la metà del secolo scorso, tanto che il ricercatore Guillaume Lejean, ancora nel 1863, espresse il proprio rammarico per essere transitato nei pressi del monastero e non aver avuto occasione di vederla.
La bussola degli uomini-giaguaro
Alcuni testi scolastici italiani di qualche anno fa, evidentemente non riveduti con molta cura dalle precedenti edizioni del periodo fascista, insegnano ancora ai poveri pargoli che fu l'amalfitano Flavio Gioia, nel 1302, ad aver inventato la bussola.
Altri volumi stesi con criteri ben diversi non ne parlano fortunatamente più e, consultando le enciclopedie apparse in tempi recenti, apprendiamo finalmente la verità: Flavio Gioia non è mai esistito, è un personaggio creato dalla tradizione popolare in seguito ad un equivoco sull'interpretazione di alcuni testi nautici.
Sembra rispondere a verità, comunque, il fatto che gli Amalfitani furono i primi ad usare in Europa la bussola, importata dai navigatori arabi. Secondo alcune fonti, questi l'avrebbero, a loro volta, ereditata dai Cinesi.
Quanto ci sia di vero nella storia, non ci è dato sapere. Sembra che, nel corso di una furiosa battaglia svoltasi nel 2634 a. C. tra un principe ribelle ed un sovrano del «celeste impero», quest'ultimo abbia avuto partita vinta raggiungendo l'avversario, eclissatosi in cortine fumogene, grazie ad una statuetta mobile (invenzione di uno scienziato di corte) che, con un braccio, indicava sempre il sud: in breve, una bussola.
In Europa, il primo ad accennare al magnetismo terrestre pare essere stato, nel VI secolo, il più antico filosofo greco, Talete di Mileto, ma della bussola si parlò ben più tardi, come abbiamo visto.
I Cinesi, da secoli e secoli, la sapevano più lunga in proposito, ma sembra che gli Olmechi, il misterioso popolo messicano su cui possediamo, purtroppo, ben poche informazioni, li abbiamo preceduti di almeno mille anni. Lo proverebbe un oggetto di ossido di ferro lungo 34 millimetri scoperto a San Lorenzo (Veracruz) nel 1967 dal professor P. Kroster, dell'università di Yale, membro della spedizione diretta dal professor M. D. Coe.
Il frammento (denominato M-160, da «Michigan», l'università in cui venne depositato ed esaminato) si comporta esattamente come un ago magnetico, disponendosi in direzione nord-sud.
In proposito lo scienziato belga Ivan Verheyden ci fa notare che esistono tre tipi di bussole.
1 - La bussola di ordine zero. È la conoscenza della polarità magnetica e delle proprietà di orientamento geomagnetico della pietra calamitata. Sospendendo la calamita ad un filamento al riparo delle correnti d'aria o deponendola su un galleggiante sull'acqua o sul mercurio liquido, la si può vedere orientarsi in una direzione particolare, non importa quale. Non è una vera bussola, poiché lo sperimentatore può ignorare che la Terra agisce come una gigantesca calamita, con i suoi poli Nord e Sud, corrispondenti approssimativamente al Nord e al Sud celesti. Tuttavia la polarità magnetica può essere constatata direttamente.
2 - La bussola di primo ordine. È la conoscenza dell'orientamento reale dei poli verso il Nord e il Sud dei punti cardinali. Anche qui la polarità diviene apparente, puntando un'estremità sempre verso il Nord (o il Sud, poco importa). Una lunga barra o un ago calamitato tenderanno a presentare i loro poli magnetici alle estremità orientati verso Nord-Sud. Tale tendenza - occorre rilevarlo - può essere indipendente dalle conoscenze dell'artigiano. Egli potrebbe, in effetti, avere ricavato il suo strumento da un deposito di minerale orientato originariamente verso Nord-Ovest, ma potrà calibrarlo o compensarlo in modo che si orienti da solo verso tale direzione. Si noti che chi lo adopera ignora ancora la deviazione magnetica, cioè il fatto che la sua bussola punta al Nord magnetico, e non al vero Nord.
3 - La bussola di secondo ordine. È la conoscenza della polarità magnetica come quella della deviazione geomagnetica e del fatto che questa varia con il tempo e secondo i vari luoghi. Quest'idea è ben più sofisticata e non fu enunciata che nel XII secolo, benché l'origine e le cause non fossero ancora sufficientemente conosciute.
Gli esperimenti compiuti sul «frammento M-160» hanno dimostrato che si tratta senza dubbio di una bussola di primo ordine. Nulla, assolutamente nulla può far supporre che si abbia a che fare con un oggetto cultuale, benché notiamo che i monumenti olmechi sono disposti costantemente in una medesima direzione.
«Mille anni prima dei Cinesi», conclude Verheyden, «gli Olmechi disponevano, quindi, della bussola. Essa è all'origine della loro ossessione consistente nell'allineare i centri cerimoniali ad otto ° ovest. Ecco un altro problema. Oppure la loro scienza era esclusivamente astronomica? L'archeologo M. Hatch ha difeso le tesi secondo cui La Venta (la capitale olmeca) sarebbe orientata sull'azimut del tramonto dell'Orsa Maggiore tra -1.000 e -500. Ma non vi sarebbe stato bisogno di bussola. Il "frammento M-160" è, per il momento, unico nel suo genere».
I famosi creatori delle enigmatiche statue degli «uomini-giaguaro», le tracce inquietanti dei quali sembrano affiorare anche in altre parti del globo, se ne servivano dunque per la navigazione?
Ogni tentativo di risposta ci sembra per ora azzardato.
Telescopi senza età
Altri oggetti ancora più curiosi per la scienza sono stati rinvenuti a San Lorenzo, certamente di fattura olmeca: perle polite e forate in diversi punti, specchi piani, grossi come l'unghia di un pollice, levigati da una sola parte, il che fa supporre che fossero usati «in incrostazione», specchi concavi più grandi, aventi fino a 10 centimetri di diametro, di forma circolare o ellittica, con la superficie di alta qualità ottica da un lato e dall'altro incompiuta, non presentanti tracce né di pittura né d'incrostazione. Tali specchi concavi sono parabolici, vale a dire che il loro raggio di curvatura aumenta quando si allontana dal centro dell'asse di simmetria. Anche questi sono bucati, senza dubbio come ciondoli o pettorali, e lo si può constatare su una figurina olmeca.
Ce ne informa Ivan Verheyden, aggiungendo che un fiorente commercio di tali specchi aveva luogo dalla costa pacifica a quella atlantica del Messico, su centinaia di chilometri. E non è affatto escluso che si estendesse ancora di più, toccando regioni meridionali in questo senso poco o per niente esplorate.
Le rovine della città maya di Chichen Itzá, nello Yucatàn, sono sovrastate da un imponente edificio. È il Caracol, che si dice sia stato un grande osservatorio astronomico e che con i nostri, nella struttura, ha davvero molto in comune. I Maya se ne servivano dunque per «guardare le stelle», come pare facessero altri popoli precolombiani talvolta per noi senza nome, senza date, senza storia?
È probabile. Ma con quali mezzi? Forse con quelli degli Olmechi o con qualcosa di simile?
Esiste a Parigi un'associazione che vorrebbe far rivivere le credenze degli antichi peruviani e diffonde un notiziario mensile, in un numero del quale è detto, fra l'altro:
«Il Lexicon è un dizionario redatto nel 1540 dal monaco domenicano Domingo de San Tomas, presso gli Incas, che riporta vocaboli in runa-simu (quechua) ed i loro corrispondenti spagnoli. Vi si trovano molte cose insospettate. E questo è effettivamente - fra il resto - che cosa vediamo a pagina 132 a proposito della parola quilpi, tradotta in spagnolo con "apparecchio di anteojos con espejuelos curvos".
«Gli espejuelos sono specchi e vetri concavi e convessi.
«Anteojos significa "vedere da lontano".
«Quilpi dev'essere dunque reso con l'espressione "strumento ottico per vedere lontano". O, se si preferisce, "telescopio"!
«Inoltre, quilpi è etimologicamente in relazione con quillcaquipo (strumento per contare), quilcadaricurn-gui (leggere, apprendere) e quilla quiz (pianeta, sistema cosmico)».
Telescopi, dunque, funzionanti assai prima di Galileo. Chi l'avrebbe mai creduto? Eppure sembra che tanto sia avvenuto in varie parti del globo. Nella nota opera storica cinese Chu King è detto, ad esempio, come l'imperatore Yao (morto nel 2258), «entrando nella Sala degli Antenati, dove sono raffigurati gli astri», avesse visto «il tubo con cui li si osservava».
Ricordiamo, poi, che lenti di cristallo perfettamente sferiche, fabbricate con altissima precisione, sono state rinvenute da ricercatori sovietici in Egitto, in Iraq e addirittura nell'Australia centrale. Esse - abbiamo scritto in occasione della prima scoperta - possono venir oggi ottenute soltanto con un abrasivo speciale, a base di ossido di cerio. Da ciò scaturisce una straordinaria domanda: gli Egizi conoscevano l'elettricità? Infatti l'ossido di cerio si produce con un processo elettrochimico ed è assolutamente impossibile isolarlo senza disporre di energia elettrica.
La prima scoperta di lenti risalenti ad una remota antichità venne effettuata dal celebre fisico inglese David Brewster, verso la metà del secolo scorso: fu infatti nel 1852 che mostrò a Londra una lente trovata a Ninive, la grande città dell'impero assiro posta tra la sponda sinistra del Tigri e il fiume Khusur, di fronte all'odierna Mossul.
All'astronomo francese Theodor Moreux ne furono mostrate due da un dotto religioso, padre Delattre, il quale le aveva portate alla luce nel 1903 in Tunisia, là dove un tempo sorgeva Cartagine.
Sempre nell'area mediterranea, rammentiamo il presunto osservatorio di Meroe, l'antica città della Nubia, sul Nilo, e lo strumento che (affermano alcuni storici), posto sul faro di Alessandria d'Egitto, avrebbe permesso di «scorgere le navi lontane».
Democrito, infine (si fa notare), non avrebbe potuto certo sostenere che la Via Lattea è un titanico ammasso di stelle, se non avesse disposto di strumenti atti a constatarlo.
Riandiamo al cosiddetto «nuovo mondo». Nel museo di Ica del dottor Cabrera si trovano, tra le moltissime pietre graffite da un popolo senza età, raffigurazioni di esseri che sembrano chiaramente esaminare oggetti servendosi di lenti. Alcuni di questi oggetti paiono, a loro volta, petroglifi, ma, a giudicare dalle figure, potrebbe anche trattarsi di fossili. Vi sono, poi, rappresentati uomini intenti a scrutare il cielo attraverso strumenti tubolari che, senza il minimo ricorso alla fantasia, possiamo soltanto definire telescopi. In alto si scorgono stelle stranamente disegnate, forse anche pianeti e comete.
Rieccoci a Tiahuanaco: alla fine della sua strada più imponente sorge una costruzione monumentale, il Kalasasaya, «un edificio», scrive un cronista della Conquista, «così sontuoso e immenso da poter essere giudicato una delle meraviglie del mondo».
È chiamato «il grande tempio del Sole», costituito da una piattaforma quadrata piramidale con 130 metri di lato, un tempo ornato da gigantesche statue che gli Spagnoli dissero di una perfezione meravigliosa, certo edificato con enormi massi che non esistevano sul posto, trasportati chissà come da chissà dove, com'è il caso di tantissimi monumenti dell'antichità.
Sulla traccia di remote testimonianze, l'archeologo Bartolomé Mitre parla di «un gran numero di sculture antropomorfe, di animali o di divinità fantastiche, ora purtroppo scomparse, senza dubbio opere di grandi artisti vissuti in tempi immemorabili».
C'è anche chi fantastica di raffigurazioni astrali, e infatti Arthur Posnansky pensa che l'edificio sia stato un laboratorio astronomico. Considerato il suo orientamento, un altro ricercatore, Rolf Müller, lo ritiene costruito tra i 7 ed i 14 mila anni fa.
Lenti, telescopi, strumenti di osservazione celeste: forse tutto questo esistette in un passato remoto cancellato dalla storia del genere umano da avvenimenti catastrofici. Ma anche dopo, quando le «nuove» civiltà raggiunsero livelli che non ci sono ancora del tutto noti, gli studiosi guardarono al cielo, con mezzi che oggi giudicheremmo certo primitivi, ma che posseggono un fascino a cui non ci si può sottrarre.
C'è chi si chiede a chi si sia ispirato Ulug Bek, nipote di Tamerlano, il «Leonardo da Vinci uzbeco», costruttore di un osservatorio che ancor oggi lascia sbalorditi ed affascinati i visitatori della favolosa Samarcanda. E se lo chiede a ragione, poiché, in seguito alle metodiche ed appassionate ricerche degli studiosi sovietici, vengono fatte in questo campo sempre nuove scoperte.
Dobbiamo, comunque, risalire a nord-ovest, all'Armenia, per incontrare l'espressione più enigmatica di queste opere, l'osservatorio studiato dalla professoressa E. S. Parsamian, di Biurakan. Esso risale al 3.000 a. C. ed era costituito da tre piattaforme, di cui una triangolare, con la punta orientata nella direzione in cui «sorgeva» Sirio in quell'epoca.
Perché proprio Sirio? Perché per la stessa, ignota ragione, l'anno degli Egizi cominciava il giorno in cui la stella del Cane Maggiore, la più luminosa dopo l'astro che ci dà vita, appariva alla stessa altezza del Sole?
Da questi interrogativi ne nascono altri, ancor più sconfinanti nel mistero: da chi e come gli Egizi, i Dogon dell'Africa centrale e gli antichi Armeni avevano saputo che Sirio è una stella doppia e che ha una «compagna oscura», scoperta solo con i moderni mezzi di osservazione?
Non è affatto escluso che sorprese analoghe ci attendano nel vicino Azerbaigian, la Repubblica sovietica che si affaccia sul Mar Caspio a sud-ovest sino ai confini con l'Iran. Qui i sommozzatori della sezione archeologica dell'Accademia delle scienze dell'URSS hanno infatti scoperto i resti di tre grandi città, in parte sommerse ed in parte inghiottite dalla zona semidesertica costiera. Sono stati portati alla luce attrezzi di vario genere, vasi, oggetti di metallo, gioielli che sinora sfuggono ad ogni classificazione, pur essendosi evidentemente trattato di centri un tempo molto evoluti e influenti.
Passiamo ora ad un altro campo in cui i nostri lontanissimi antenati avrebbero compiuto progressi insospettati: quello della chirurgia.
Millenni prima di Barnard
Nel 1969, nel corso di una spedizione nell'Asia centrale condotta dal professor Leonidov Marmagianian e composta da un gruppo di ricercatori dell'università di Leningrado e di Askabad, si rinvennero in una grotta trenta scheletri che risultarono, all'esame con il carbonio 14, vecchi oltre 20 mila anni, ma ai quali indagini più accurate assegnarono un'età di circa 100 mila anni.
Di questi resti, otto mostravano i segni di gravi ferite, dovute evidentemente a morsi ed a graffi profondi di animali feroci. Alcuni presentavano, però, delle incisioni alla cassa toracica molto precise, incisioni le quali non potevano essere state effettuate se non con strumenti di pietra affilatissimi o di metallo.
Si era trattato senza dubbio di interventi chirurgici nella regione cardiaca, interventi ai quali i pazienti erano sopravvissuti per almeno 3-5 anni, «come dimostrano» - affermano gli specialisti di Leningrado - «le rilevazioni dello spessore del periostio sovrastante». Ricordiamo che il periostio è lo strato del tessuto connettivo che riveste certe parti delle ossa, contenente vasi sanguigni e nervi, svolgente funzioni di nutrimento, protezione e accrescimento del tessuto osseo.
Interventi del genere erano già stati osservati in scheletri portati alla luce nel Medio Oriente e databili oltre 50 mila anni fa.
Ma andiamo più indietro, torniamo alle pietre del dottor Cabrera di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro libro, quelle che ci mostrano, insieme, uomini e dinosauri.
Uno di questi ciottoli ci presenta addirittura il trapianto di un cuore completo (niente a che fare, quindi, con i trapianti di Barnard), un altro un complicatissimo attacco al cervello, se non addirittura una sua sostituzione!
Allo stadio attuale della nostra scienza ed alla visione dei nostri futuri, sia pur grandiosi progressi chirurgici, non ci è possibile accettare idee del genere, anche se realizzate dalle menti eccelse di una progreditissima civiltà.
Non possiamo comunque scartare a priori il sogno, l'immaginazione, proiettati sull'unico materiale disponibile - la pietra - come noi oggi li proiettiamo sulle pagine stampate e sulle pellicole.
Ancora in Perù, in un'epoca senza data, fra popolazioni senza nome, si ha notizia, dalle «pietre di Ica», di altre straordinarie operazioni, tra cui un parto cesareo effettuato con una tecnica diversa dall'attuale. Due delle incisioni mostrano il bebè nel ventre materno «vestito» con un indumento simile ad uno slip. È stato appunto questo curioso particolare a far gridare al falso, un falso che (a detta degli increduli) risalirebbe al XVI secolo, quando i tuoni della Chiesa avevano già perentoriamente legato la visione degli organi genitali al peccato. Strano è, però, che un'altra figura della stessa serie presenti il nascituro nudo.
Il falso ci sembra comunque da escludere - come abbiamo detto - dato il numero dei graffiti peruviani collezionati (11mila), quelli ancora da reperire (migliaia e migliaia), l'arte, le nozioni scientifiche in ogni campo, il numero di persone, il tempo per realizzare, nascondere e diffondere una biblioteca di petroglifi, gli sforzi immani richiesti, insomma, da una «truffa» di questo genere.
«Truffa»? Ma a quale scopo sarebbe stata perpetrata, poi, quest'impresa che non ha paragoni?
Se veniamo a tempi assai più recenti, infine, ma ancora tali da creare molte perplessità circa l'efficacia della chirurgia, incontriamo un esempio che, una ventina di anni fa, lasciò gli studiosi dapprima scettici, poi sbalorditi.
Negli anni Sessanta un grande clinico di Lima ebbe modo di studiare alcuni strumenti chirurgici rinvenuti nel suo paese, composti di una lega d'oro, argento e rame e risalenti ad almeno 3 mila anni fa.
Parecchi archeologi li avevano già esaminati, giungendo a varie conclusioni: vi fu chi li giudicò semplici scalpelli destinati a chissà quali usi, chi assegnò loro il sinistro compito di servire da mezzi sacrificali, chi, ancora, confessò di non capirci nulla, affermando semplicemente che trenta secoli fa nessuno avrebbe potuto realizzare una simile lega.
Il professor Francisco Grana, tuttavia, era di parere diverso, e tanto gli venne confermato dall'esame di alcuni crani della stessa epoca, in cui erano state praticate aperture poi perfettamente rimarginatesi.
Quegli strumenti erano dunque veri e propri ferri chirurgici dimostratisi efficacissimi nell'antichità! Grana ne era tanto convinto che decise di tentare un esperimento il cui fallimento gli sarebbe costato la fama, il posto e forse anche la libertà. Nel 1963 effettuò un difficilissimo intervento sulla vittima di un incidente automobilistico servendosi appunto degli strumenti fabbricati tremila anni prima e chiedendo che il suo lavoro venisse filmato.
In un nostro libro («Terra senza tempo») abbiamo pubblicato tre fotografie dell'operazione, riuscita tanto bene che, mentre scriviamo, il paziente gode ottima salute, non accusando da anni alcun disturbo al capo.
Capitolo XIII - Viaggi dal passato: I dominatori del cielo
«Si possono costruire macchine per la navigazione senza vogatori, così che navi più ampie navigheranno nelle acque dei fiumi e del mare, mosse da un solo uomo e con maggiore velocità che se fossero cariche di uomini. Anche i carri potranno muoversi senza animali a velocità incredibile... si possono costruire anche apparecchi per volare nei quali un uomo, seduto nel mezzo della macchina, facendo ruotare un certo congegno, azioni le ali che battono l'aria, come un uccello che vola. Si costruirà anche una macchina di piccola mole per alzare o abbassare pesi enormi... Si può costruire un congegno per mezzo del quale un uomo può trascinare a sé per forza mille, contro la loro volontà e attrarre altre cose nella stessa maniera. E possono farsi congegni per camminare sul mare e sui fiumi o anche al fondo senza danno... e tante cose si possono fare, quasi senza limiti, come, per esempio, ponti sui fiumi senza piloni od altri sostegni e meccanismi e congegni inauditi...».
Tutte queste previsioni non ci vengono dai «futurologi» (così sarebbero ora definiti) della fine del secolo scorso o dell'inizio del nostro, ma da Ruggero Bacone, il francescano inglese, filosofo e scienziato, vissuto dal 1214 al 1294. Ed ogni cosa da lui predetta è stata realizzata, se si esclude il «raggio traente», di cui (per ora) ci parlano soltanto gli autori di fantascienza.
Chi era Bacone che, rigidamente teocratico in filosofia, affermò la validità di una scienza segreta sperimentale inimmaginabile per i suoi tempi?
La sua figura, pur oggetto di analisi e speculazioni a non finire, resta e resterà misteriosa anche solo per quanto, delle sue sconcertanti previsioni, abbiamo appena citato.
«Neppure Nostradamus», scrive, tra l'altro, la studiosa Edy Minguzzi, «poté permettersi di preannunciare con una sicurezza così spudorata le scoperte del Duemila... e ciò dopo aver disinvoltamente parlato della possibilità di circumnavigare la Terra e degli effetti correttivi delle lenti.
«Tutto questo ci pone davanti ad un problema. Si trattava di preveggenza? È anche possibile che questo fosse uno dei tanti poteri acquisiti dagli Adepti. Ma non è da escludere che avesse raggiunto attraverso l'Alchimia una conoscenza scientifica paragonabile alla nostra. Oppure aveva attinto queste conoscenze da un remoto passato di cui la tradizione Ermetica è l'ultima sopravvivenza. E infine Bacone afferma, ad un certo punto: "Queste macchine sono state costruite in passato"».
Non sappiamo certo quali, come e dove, ma siamo perfettamente d'accordo con la professoressa Minguzzi quando scrive: «Non si può escludere che ci siano state civiltà precedenti che abbiano raggiunto risultati pari o superiori ai nostri».
Miti tra le nubi
«Si possono costruire anche apparecchi per volare», preannuncia, tra l'altro, Bacone. Ebbene, occorrerebbe una nutritissima enciclopedia per raccogliere almeno la parte principale di quanto è giunsino a noi dai tempi andati e da ogni parte del mondo sul volo umano, dalle favole alle tradizioni, dai racconti sul volo magico e sul volo mistico alle testimonianze.
Il grande studioso francese Jules Duhem lo ha fatto, riassumendo soltanto l'essenziale in 450 fittissime pagine, ricche fino all'incredibile di note bibliografiche che attingono a fonti precise, esaurienti, inoppugnabili.
La sua opera, a cui rimandiamo i lettori appassionati all'argomento, s'intitola Histoire des ìdées aeronautiques avant Montgolfier. Ovviamente non vogliamo né potremmo qui affrontare uno studio del genere, sia pure su scala assai più modesta. Ci limiteremo quindi a qualche citazione essenziale per il lavoro che ci proponiamo, cominciando da una sua fondamentale osservazione.
«Il posto che il volo occupa è di grandissima importanza: le fiabe, il folklore, le leggende, i miti, lo illustrano in centinaia e centinaia di modi. Le storie di dei e di eroi volanti hanno addirittura fatto supporre l'esistenza di una scienza segreta, di nozioni acquisite dagli iniziati sulla possibilità reale del volo umano. Il mito non tradisce la natura, nemmeno quando fa volare esseri fantastici. Il cavallo di Perseo, quello di Bellerofonte, i leoni alati di Rea-Berecinzia, i draghi che salvano Medea dalla collera di Giasone, l'ariete sul quale Frisso ed Elle fuggono la severità di Atamante, come i capri volanti che gli antichi Scaldi donano al dio Thor, avevano già un tempo un senso iniziatico».
E questo, naturalmente, senza accennare alle innumerevoli tradizioni di popoli lontanissimi.
Nell'epoca cristiana si passa alla levitazione mistica ed a quella delle streghe e degli stregoni, nettamente divise a seconda che a fungere da mezzo di teletrasporto siano l'odore di santità o le arti nefande del diavolo.
Charroux si chiede quanti iniziati, quanti autentici studiosi siano stati torturati e arsi vivi in nome della Chiesa. Non lo sapremo mai, neppure per approssimazione: quelli citati dalle cronache e dagli atti dell'Inquisizione non rappresentano che una minima parte.
Satanasso provvede in numerosi modi allo spostamento aereo dei suoi adepti: di persona, incaricando del pilotaggio i demoni minori, fornendo agli interessati polveri, pomate e brodaglie ripugnanti, formule strettamente riservate.
«Più strana», nota Duhem, «è la metamorfosi del diavolo in vascello, in macchina, in ordigni volanti. Questa sua capacità appare già nella vecchia storia cavalleresca di Doolin di Magonza, rielaborata da Alxinger e, sotto aspetto differente, nella visione di S. Antonio rappresentata da Hieronymus Bosch.
«Un caso sorprendente è quello del demonio che, per ordine del mago, nel poema eroico di Gerolamo Graziani ("La conquista di Granata", Modena 1690) s'incorpora in una nave subito mutata in drago volante. Una curiosa incisione ha fissato il momento della trasformazione: la prua si allunga in forma di punta di spadone, due ali si spiegano sul pennone e la coda lanceolata del mostro comincia ad uscire all'indietro, mentre sussiste ancora il corpo del naviglio con i cordami e le pulegge [...].
Accade ancora che Satana non si trasformi, ma crei una macchina che guida o fa portare dai suoi. A volte non è che un ordigno fatto da mani umane o addirittura un mobile. Così Torello d'Istria è portato via nel suo letto. Una vecchia incisione su legno di Conrad Wimpina (Sectarum, errorum, allucinationum et schismatum ad origine christianae, Francoforte sull'Oder 1528) rappresenta l'ascensione di un vascello magico recante a bordo Lutero e i suoi seguaci.
«Il poeta Firdusi fa viaggiare il re Gemshid su un trono aereo trascinato da demoni (Shah Nameh, versione di Italo Pizzi, Torino 1888) e nella cronaca di Thâlebi l'eroe persiano è posto su un carro ugualmente trainato nell'aria da demoni.
«Ma il capolavoro del genere è rappresentato dal vascello aereo che Hieronymus Bosch introduce nella sua citata "Tentazione di S. Antonio", un lungo naviglio a forma di uccello con ponte, pennone, sartie, e con l'anticipazione prodigiosa di un'antenna e di un goniometro di bordo. Un piccolo demone agile guida questa meravigliosa aeronave».
Lasciamo i diavoli, veniamo ad altri tempi e ad altre terre.
Luciano di Samosata, lo scrittore greco del II secolo d. C., che immaginò per primo un viaggio sulla Luna e una battaglia spaziale, fa dire a Cleodemo, in un altro lavoro, di avere realmente visto un iperboreo volare, in pieno giorno, mentre scrittori vissuti in epoche diverse, tra cui Erodoto, Giamblico, Imerio ed altri accennano ad uno «scita» chiamato Abaris che «volava su una freccia d'oro, dono magico dell'Apollo venerato dagli Iperborei».
Ora, come si sa, i favolosi Iperborei vengono posti in collegamento con gli Atlantidei. Non è dunque curioso il fatto che molte leggende precolombiane, dal Messico al Perù, parlino di «frecce d'oro» e di «piatti d'oro» volanti?
Presso gli Indiani del Nuovo Messico, riferisce W. Cozzens (Le contré merveilleuse, Parigi 1876), «i bianchi si credevano venuti dalle nubi», mentre «il nome di Soyota, "uomo disceso dal cielo", serviva a designarli».
Il colonnello A. Braghine, autore del libro L'énigme de l'Atlantide (Payor, Parigi 139, esaurito) scrive, tra l'altro: «Ho visto a San Salvador, nell'America centrale, un piatto d'argilla con disegni rappresentanti uomini volanti al di sopra dei palmizi in curiose macchine dalle quali uscivano fiamme e fumo».
Anche più a sud si hanno rappresentazioni del genere, a cui si richiamano parecchie leggende, alcune delle quali hanno dovuto essere riprese (ed ovviamente trasformate) addirittura dalla Chiesa cattolica, tanto erano radicate. Nella chiesa dei gesuiti del Paraiba del nord, ad esempio - ricorda Jules Duhem - un vecchio dipinto rappresenta la Vergine, o qualche santo, con magnifici ornamenti, vaganti su una sorta di navicella a forma di mezzaluna attorno alla quale è avvolto un serpente.
Eccoci dunque ancora alla favola dei «draghi volanti»!
Quella che sembra la più realistica ed impressionante descrizione di un mezzo volante - e di un mezzo volante propulso a razzi - è però certo costituita dalla netta incisione che va sotto il nome di «astronave di Palenque».
Si tratta di una nave sepolcrale rinvenuta in una piramide maya, che copre lo scheletro di un uomo con una maschera di giada: alcuni vogliono che sia addirittura quello del dio bianco Kukulkan, altri quello di un insigne personaggio.
L'incisione - descritta e riprodotta nel nostro precedente lavoro "Non è terrestre" - sembra raffigurare nettamente, in ogni dettaglio (compresi gli ugelli posteriori da cui fuoriescono le fiamme) un fuso spaziale. Ai suoi comandi siede un uomo proteso in avanti, fornito di un casco e di un inalatore, e le sue mani sembrano muovere leve, premere pulsanti, mentre i suoi piedi paiono impegnati ad agire su pedali.
Alcuni studiosi tradizionali lo hanno definito «dio della pioggia», ma non sono riusciti a spiegare neppure per approssimazione che cosa possa mai fare un dio della pioggia seduto in una macchina sputafuoco di quel genere.
Il personaggio - a giudicare dai lineamenti e dal costume - è senza dubbio un maya. Ora, sarebbe assurdo sostenere che i Maya conoscessero il volo o addirittura l'astronautica, ma non è astruso pensare che abbiano riprodotto con i loro tratti ed il loro abbigliamento un essere vivo soltanto più nei ricordi.
Non farebbero lo stesso i nostri discendenti che, isolati da tempo dall'attuale civiltà, volessero rappresentare un cosmonauta? Evidentemente non potrebbero che dipingerlo simile a loro, vedendo il veicolo sulla traccia delle descrizioni tramandate.
Le macchine volanti
I personaggi volanti - lo abbiamo visto - sono innumerevoli nelle mitologie di tutto il globo, come numerosissime sono ancor oggi le popolazioni più o meno primitive che si adornano di penne o di ali, per cui prendono a modello quelle degli uccelli loro familiari, spiccanti per la forza, per l'altezza, per la velocità e per la maestria del volo.
Perché lo fanno? Alcuni per l'alleanza totemica con gli uccelli, altri nella credenza di un'origine comune o nella reincarnazione degli uomini in volatili, altri ancora per il semplice, innato desiderio di possedere il dono di librarsi nell'aria.
Ma, se escludiamo quest'ultimo punto, vedremo che alla base di tutti gli altri, più o meno perduto o svanito nel tempo, esiste il vago ricordo delle leggende di grandi progenitori, o civilizzatori, o dei, o tutte le cose insieme, discesi dal cielo.
Come divenire loro simili, come raggiungerli o, se non altro, come evocarli?
Per gli antichi e per i primitivi non c'è che una risposta: imitando gli uccelli.
Pressoché tutti i popoli hanno il loro Dedalo e il loro Icaro, sia nei miti, sia nelle presunte cronache.
Quanto a queste ultime, Beyerlink (1656) riferisce che a Roma, in occasione di una festa, un uomo salì su un muro come un ragno (ma che precursore di certi stucchevoli fumetti!), per poi munirsi d'ali e volare. A quale fonte lo scrittore abbia attinto, si ignora del tutto, come nel caso di Sabellico (1487), che narra una storia simile.
Molto più credibili sono gli episodi a cui accennano Svetonio e Marziale, parlandoci di due disgraziati (probabilmente schiavi o prigionieri) costretti, il primo sotto Nerone, il secondo sotto Domiziano, a salire alla sommità del circo ed a lanciarsi nel vuoto con ali posticce, andando a sfracellarsi nell'arena.
Leonardo da Vinci credette, all'inizio, alla possibilità del volo remigante umano, per dovere poi ammettere che l'imitazione dell'ala dell'uccello è impossibile. Vi credette Benvenuto Cellini, che nel 1538, dalla sua prigione di Castel S. Angelo dov'era rinchiuso per risse e litigi, propose di volare fino a Prato con un paio di ali di lino cerato. Non glielo si permise, ed egli scelse un'altra strada per lasciare il poco gradito albergo.
Parecchi studiosi cercarono, in seguito, di realizzare il volo umano ad ali battenti, ma nessuno vi riuscì. E chi vi si provò di persona, non fu in grado di raccontare l'esperienza. Un famoso esempio vicino ai nostri tempi è quello di Clem Sohn, morto in Francia. Lanciatosi il 25 aprile 1937 da 3.000 metri con due membrane tese tra braccia e gambe, riuscì a volteggiare fra le correnti, ma quelle appendici non bastarono, il loro effetto planante non lo sostenne: aprì il paracadute a 300 metri da terra, ma tanto non lo salvò.
Se, poi, vogliamo tratteggiare a brevi linee la storia del volo meccanico, dobbiamo necessariamente partire dagli «automi volanti», cominciando con il primo ricordo pervenutoci indirettamente attraverso gli scritti del sofista Favorino (I-II secolo d. C.) e di Auro Gellio (130-175 d. C. circa), concernente una colomba metallica costruita dal filosofo e matematico greco Archita di Taranto, il fondatore della meccanica scientifica vissuto dal 430 a. C. alla metà del IV secolo prima della nostra era.
Lo studioso avrebbe appunto inventato un uccello-robot capace di volare per un lungo tratto battendo le ali. Secondo Auro Gellio, esso sarebbe stato «ben sospeso per mezzo di contrappesi ed animato dal soffio di un'aria nascosta».
«Per contrappesi», osserva Jules Duhem, «si può intendere l'equilibrio automatico ottenuto con un sistema di zavorre mobili o di meccanismi attivi all'interno della macchina, mentre il vago accenno al "soffio" potrebbe far pensare al principio del volo a reazione».
Molte altre spiegazioni circa il funzionamento dell'oggetto sono state tentate nel corso dei secoli, ma nessuna può essere presa in considerazione, poiché gli unici elementi descrittivi di cui disponiamo sono quelli che abbiamo esposto.
Greci, bizantini e orientali fabbricarono parecchi preziosi giocattoli, tra cui uccelli capaci di pigolare, saltellare ed agitare le ali, ma del volo non ci è pervenuta alcuna notizia.
Occorre giungere sin verso la fine del medioevo per incontrare macchine volanti: sono quelle del matematico e astronomo Johann Müller, nato a Königsberg, in Franconia (1436-1476).
«Il primo di questi congegni», scrive Duhem, «fu una mosca di metallo tanto ben costruita che il suo inventore, durante un banchetto, la mostrò ai convitati, dandole lo slancio. Tutti la videro volare intorno al tavolo, ronzando, per poi tornare nella mano del suo padrone. Il secondo, della mole e della figura di un'aquila, di legno secondo alcuni, di ferro secondo altri, venne presentato nella circostanza solenne di un ingresso dell'imperatore a Norimberga. Lanciata dall'alto dei bastioni, l'aquila di Johann Müller (detto Regiomontano, dal nome latino della sua patria) volò ad una grande distanza davanti al sovrano, girò e lo precedette, battendo le ali, fino alla porta trionfale».
Per circa un secolo, di queste storie circola solo la versione orale, poi esse vengono raccolte da un certo numero di scienziati, alcuni dei quali di fama, che in parte le accreditano, dando varie spiegazioni.
Duhem crede, piuttosto, che la famosa mosca sia stata tenuta, con un'illuminazione appropriata, da qualche capello (un procedimento ben noto ai prestigiatori) e sospesa ad una guida obliqua che le avrebbe consentito di compiere, con una leggera spinta, il giro del tavolo e tornare tra le dita del suo ideatorc. Quanto all'aquila, potrebbe essersi limitata a battere le ali, resa volante solo dalla fantasia.
Nel 1612 il gesuita Juan de Valcaçar, celebrando le solenni esequie della regina Margherita di Spagna, afferma tra l'altro, nella sua opera, che l'arte di Archita non andò perduta, dicendo come alla sua epoca esistesse ancora a Cipro una scuola di artigiani atti a fabbricare uccelli meccanici «capaci non solo di volare, ma di cantare, di razzolare, di fuggire, d'ingannare il cacciatore, di rompere le reti». Ora, è vero che la tradizione degli «uccelli di Cipro» è antica, risalendo forse al tempo dei crociati, ma riteniamo che le loro virtù siano state almeno un pochino esagerate dal religioso.
Parecchi studiosi, artigiani genialoidi e improvvisatori tentarono d'ingigantire il piccolo capolavoro di Archita con i più svariati accorgimenti o di ricorrere al volo meccanico associato a quello remigante per portare l'uomo verso il cielo, ma tutti fallirono.
Quello di Leonardo, che sfiorò il successo senza raggiungerlo, è un altro discorso, che ovviamente non possiamo qui affrontare se non ammirando la grandezza della sua opera e notando che purtroppo gli mancarono i mezzi ed i principi per realizzare l'aereo a motore.
«L'uomo, cercando di volare, non riuscì ad azionare un congegno che lo sostenesse, battendo, nell'aria in cui pretendeva di navigare», scrive Jules Duhem. «Ma fuori dal corpo volante esistono forze naturali che lo toccano, gli sono vicine e lo dominano. Di qui l'idea di sostenersi per mezzo di superfici sulle correnti che lo possono raggiungere e persino, con l'aquilone, su quelle fuori di portata.
«Il volo planato, una discesa nell'aria calma, non è che un effetto di paracadute. A tanto è sufficiente un biplano senza guida, inferiore ai 5 metri e pesante 16 chili. Volare a vela significa, invece, sostenersi ed acquistare altezza utilizzando i venti e le forze ascendenti, sia nuvolose, sia termiche, sempre che l'oggetto offra possibilità di manovra e di alto tecnicismo. Si tratta dell'aliante».
Di questo sistema troviamo applicazione tra gli uccelli, i pesci volanti, i rettili alati, con parecchi batraci, e persino nel regno vegetale, con certi semi volanti. Ma l'uomo non guardò subito a tali esempi: la vela marina, conosciuta da tanto tempo e proporzionata alla forza delle correnti, la slitta, gli sci, le slitte a vela dei groenlandesi e dei lapponi, il pattinaggio a vela dei cacciatori danesi, il maneggio a vele combinate dei vecchi giocolieri, costituiscono altrettante pratiche che preparano l'uomo a volare. Due mezzi, tuttavia, vi contribuirono più degli altri: l'aquilone (o cervo volante, drago volante) e il carro a vela, uniti in seguito, talvolta, a formare piccoli veicoli librati nell'aria.
«La relazione esistente tra la corsa di un carro a vento e il volo a vela è ben stabilita, verso la fine del XVI secolo, dai lavori di Simon Stevin sulla statica dell'aria. Per studiare l'azione di questo fluido sulle superfici mobili, il meccanico fiammingo costruisce un carro propulso dal vento, ed è basandosi sul suo successo che Pasch giunge alla conclusione che il volo a vela è possibile».
L'aquilone è senza dubbio un'invenzione cinese, la cui comparsa si perde in una remota antichità. Lu Pan, uno scienziato vissuto ai tempi di Confucio (551-479 a. C.) ne parla con estrema naturalezza, come il filosofo Mo Ti, il quale afferma di averne costruito uno con legno leggero, molto grande, capace di reggersi in aria per un giorno intero. Nel II secolo della nostra era, poi, Han Sin dovrebbe averlo applicato alla topografia ed all'arte militare.
Mentre i Cinesi davano a questi oggetti le forme di draghi e di uccelli, i Giapponesi preferivano i pesci, mentre i Cambogiani vi appendevano festoni multicolori, gabbie e lanterne, ed i Siamesi lanterne e campanelle. I Tartari, dando loro l'aspetto di mostri orrendi, li resero ordigni di guerra, facendoli volteggiare e precipitare sui nemici terrorizzati.
Il fatto che l'aquilone venga conosciuto in Europa soltanto verso la fine del medioevo induce a credere che vi sia stato introdotto dall'Oriente, non certo dalla Grecia o da Roma.
In Italia, il medico e matematico Gerolamo Cardano ne scrisse, irridendo le credenze che lo volevano «strumento di sortilegio», nel 1557, ma fu il versatile scienziato partenopeo Giovanni Battista della Porta che ne spiegò per primo il principio, parlando delle leggi della resistenza che l'aria oppone al movimento di un piano inclinato nella sua traiettoria (Magiae Naturalis, Napoli 1589) ed associandole al problema del volo umano. Per lui, tra l'altro, l'uccello di Archita non sarebbe stato che un aquilone.
Curioso è il fatto che il 18 febbraio 1579 un «serpente o drago volante» volteggiò su Parigi dalle due del pomeriggio alla sera, seminando il panico tra la popolazione. Sul fenomeno venne pubblicato in tutta fretta un opuscolo, ma solo due anni dopo lo studioso François de Belleforest chiarì che si trattava semplicemente di un cervo volante.
Quello che potrebbe sembrare un giocattolo per bambini ha dato e dà, comunque, seri contributi alla scienza. L'idea (adottata ancor oggi) di affidare all'aquilone strumenti di registrazione meteorologici venne già ad un fisico di Glasgow, Alexander Wilson, nel 1749, mentre il francese Romas e l'americano Franklin (ignorando a vicenda i loro studi paralleli) lo impiegheranno per lo studio dei fenomeni elettrici nell'atmosfera.
Dobbiamo riandare in Cina per trovare i primi carri a vento, veicoli forniti di vela, a due o a quattro ruote, che vediamo già in dipinti molto antichi e che un missionario ci descriverà (G. De Mendoça - J. Arnaud, Histoire du grand Royaume de la Chine, Ginevra 1606, traduzione di una precedente opera), parlandoci dell'abilità con cui i guidatori «sanno adattare con un colpo di piede le loro vele al vento e fare destramente roteare i loro carri». Al nord del grande paese essi venivano ancora usati come mezzi di trasporto almeno fino agli inizi del secolo in corso.
Ma c'è, laggiù, qualcosa di ben più fantastico, nato in tempi in cui si è persa la memoria. Un antichissimo manoscritto, il Chan Hai Chin («Il libro delle montagne e dei mari») narra di un vascello a vela, atto sia a navigare che a correre sulla terraferma e a volare, usato nel favoloso regno del Ki Kung (o Ki Kuang), un luogo abitato da strani esseri ermafroditi con tre occhi.
Il matematico e fisico fiammingo Simon Stevin (? - 1620) è il primo a realizzare il carro a vela in Occidente, favorito dalla natura delle zone costiere olandesi. «Maurice de Nassau, vincitore degli Spagnoli a Nieuport nel 1600», riporta Duhem, «se ne divertì con il suo prigioniero Francisco de Mendoza. In meno di due ore andarono da Schweling a Putten, coprendo 14 miglia. Sei anni più tardi, andato in Olanda per visitare Grotius, Peiresc vide il carro, sempre posteggiato a Schweling, e si decise a provarlo. Si sa da Gassendi come andò quest'esperienza: spinta da un vento favorevole, la vettura, rasentando pozze d'acqua e pantani, correva così forte che i pedoni e gli oggetti lontani apparivano e sparivano in un istante».
Questi carri comparvero anche in Spagna, ma la loro pesantezza, il volume, la scomodità del viaggio e la dipendenza della direzione dal vento li fece ben presto passare di moda, benché l'avvento della ferrovia abbia poi condotto ad un loro breve impiego sulle rotaie per il trasporto di salnitro in Cile e per la costruzione della linea Kansas-Pacifico negli Stati Uniti (1878).
È ancora in Cina che troviamo quelle che sono le primissime tracce del volo a vela. La tradizione cinese, almeno a partire dal XX secolo a. C., rifacendosi forse a racconti più antichi, abbonda di riferimenti in proposito.
A loro si aggiungono gli Indiani, secondo i quali Vâta, dio delle tempeste, avrebbe viaggiato su un carro spinto dal vento. Nel Râmayana di Valmiki (il poema del IV-III secolo a. C. che canta le gesta di Râma, incarnazione di Visnu, contro il gigante Ravana), il re di Lanka, rapita la sposa di Râma, combatte su un carro aereo portato da vele, e Hanuman, la scimmia divina, si lancia a braccia tese, «coperta di fiori», verso l'isola del malvagio sovrano. Di un veicolo che «va sulla superficie dell'aria» si vale, infine, un re del romanzo sanscrito di Bâna (VII secolo).
Gli antichi Etiopi affermavano di servirsi della pelle di un favoloso «drago volante», gli Arabi di oscuri procedimenti (secondo una loro tradizione del XII secolo l'architetto costruttore della torre di Mansurah, presso Tlemcen, avrebbe volato dalla sommità della torre stessa ad una collina), moltissimi pellerossa statunitensi e canadesi di penne, mentre anche Loki, il dio scandinavo del fuoco, vola al paese dei giganti con un mantello di piume fornitogli dalla dea Freya.
«Il volo a vela è il padre dell'aviazione», afferma Duhem. E, dopo averne ricordato i precursori poco noti, scrive: «Vennero alfine i pionieri più fortunati, Chanute e i suoi allievi, Herring, Avery, poi i due segnati dal destino, Wilburg e Orville Wright. Per un sorprendente effetto di verità, è il primo maestro dell'aviazione a motore ad attestare la superiorità del volo a vela. Realizzatore di quanto è sfuggito ad Ader (virata, circuiti, lunghi voli), Orville Wright, mentre il mondo attende il rombo degli aerei, studia la struttura del vento, prova e modifica superfici plananti, inventa uno stabilizzatore e, finalmente, elabora un congegno per volare.
«Il 24 ottobre 1911 si pone sul fianco della collina di Kitty Hawk, di fronte ad un vento di ottanta chilometri orari, che l'ostacolo naturale rende ascendente, e di là, dopo aver ottenuto le condizioni che giudica favorevoli, si slancia, si leva, sale a sessanta metri, si sostiene dieci minuti in aria e torna al suolo senza danni».
Così nasce l'aviazione a motore, precedente, per un bizzarro caso, lo sviluppo di quella a vela, che s'imporrà poi soprattutto in campo sportivo, trovando tuttavia anche altri impieghi: sono infatti noti i grandi alianti usati (a rimorchio di aerei a motore) nel trasporto di materiale e truppe.
Ci sembra opportuno, a questo punto, spendere qualche parola sul paracadute. L'idea empirica di questo mezzo è conosciuta dal più remoto passato, ma non altrettanto la sua vera storia.
Secondo Sseu-Ma-Tsien, il leggendario imperatore cinese Shun, si salvò (come ci dice l'opera Chu King), circa duemila anni prima della nostra era, da un pagliaio in fiamme lanciandosi nel vuoto aggrappato a due calotte fatte di canne. L'«uomo volante di Ki Kung» si sarebbe servito di una specie di ombrellone come, assai più tardi, avrebbe fatto il giocoliere di un re siamese di cui parla Simon de la Loubère in una sua cronaca del 1687.
In Occidente Luciano di Samosata, nel II secolo d. C., narra di esseri cavalcanti mostruose bestie volanti, i quali avrebbero portato, per salvarsi da eventuali incidenti, ampie vesti assicurate a cinture. Di episodi aventi a protagonisti donne e bambini caduti incidentalmente e salvati dalle loro ampie gonne sono piene le cronache e gli ex voto.
Va comunque a Leonardo da Vinci il merito di avere per primo concepito scientificamente un paracadute. Purtroppo un tale congegno, ingombrante, a telaio fisso, non avrebbe potuto trovare applicazione. Maggior praticità, pur se non determinante, avevano le invenzioni del vescovo dalmata Fausto Veranzio (1595) e dell'ingegnere veneziano Tito Livio Burattini, che, nel 1648, a Varsavia, adattando un paracadute ad una specie di aliante, fece volare un gatto.
Nel 1771 un ignoto saltimbanco di Avignone (com'è provato da una lettera di Vincent Niel e da altri documenti), con una stranissima applicazione su piccola scala del rientro dei mezzi spaziali, lanciò in aria cani e gatti con razzi, facendoli poi discendere appesi ad ombrelloni.
Fu l'ingegnere tedesco Otto Lilienthal ad anticipare con le sue ali ricurve l'idea del paracadute. In realtà egli studiò il volo librato degli uccelli, giungendo a costruire i primi tipi di alianti e sperimentandoli di persona da colline o tetti di edifici, finché perì in uno di questi esperimenti, abbattuto da un colpo di vento.
Ancora oggi si legge in varie enciclopedie, sotto la voce Montgolfier (fratelli Joseph-Michel e Jacques-Etienne): «Inventori dell'aerostato ad aria calda e del paracadute». Ora, mentre la prima affermazione è esatta, almeno in parte, la seconda, che vuole l'impresa datata 1784, non lo è per niente.
Il vero inventore del paracadute è Louis-Sébastien Lenormand, nato a Montpellier nel 1757, chimico, fisico, meccanico e studioso di molte altre materie ancora.
Preso sotto l'interessata «protezione» dell'astuto Pierre-Nicolas Bertholon, detto «l'abate Bertholon di Saint-Lazare», sperimentò con quest'ultimo l'apparecchio, facendo atterrare cani e gatti, e lo provò di persona, con pieno successo, il mattino del 26 dicembre 1783, lanciandosi dalla torre dell'osservatorio di Montpellier.
I Montgolfier, forti della fama ottenuta con l'aerostato, fecero loro l'invenzione e il nome della stessa, dovuto a Bertholon.
Stregoni, eliche e missili
Due missionari della Compagnia di Gesù, i padri Gabriel de Magalhaes nel 1668 e Louis Le Comte nel 1696, di ritorno dalla Cina, riferirono la tradizione relativa ad un antico imperatore che avrebbe viaggiato «al di sopra delle nuvole seduto su un trono portato da cigni».
Per loro non si sarebbe trattato che di una favola, ma un altro religioso, padre Joseph-Marie Amiot, dopo la realizzazione della mongolfiera, trascorsi 40 anni nel «celeste impero», manifesta un parere diverso, sia pure a titolo d'ipotesi: i simulacri di dragoni volanti sarebbero stati riempiti con un fluido più leggero dell'aria.
Bernardin de Saint-Pierre, dal canto suo, pensa che l'imperatore si sia servito di palloni trainati da cigni, uccelli più facili da addomesticare di altri, e che molti Cinesi abbiano viaggiato così, «di giorno e di notte». L'abate Grosier, alfine, ritiene che i cigni non siano stati che figure ornamentali «contenenti nel loro interno gas infiammabile, principio di ascensione di tutte le macchine».
Come credere che ricordi simili, se non identici, si ritrovino laggiù in tempi diversi?
Un particolare interessante anche a tale proposito: parecchi testi cinesi parlano di «un diluvio che avrebbe fatto scomparire numerose invenzioni».
Quanto ai palloni volanti, i loro realizzatori si sarebbero potuti servire (come in altri paesi) di gas naturali scaturiti dal suolo. Ne abbiamo accennato in un lavoro precedente: aggiungiamo che simili fonti abbondano anche in Georgia, in Persia, in Mesopotamia ed in America. Ma prima di vedere in Europa il primo aerostato ad aria calda, occorrerà attendere il 1709, con Gusmâo.
Bartholomeu Lourenço (chiamatosi poi de Gusmâo, dal nome del suo padrino di battesimo) nacque nel 1685 a Santos, in Brasile, per trasferirsi presto in Portogallo ed entrare nella Compagnia di Gesù.
Ricevuta l'ordinazione nel suo paese natale (forse a Rio de Janeiro), torna a Lisbona, dove incomincia le sue ricerche.
Agli inizi del 1709 indirizza una petizione al re, Joâo V, annunciando di «avere inventato un apparecchio per viaggiare nell'aria molto più velocemente che per terra o per mare, fino a superare le 200 leghe al giorno».
Ce lo riferisce Duhem, aggiungendo: «Seguivano altre considerazioni sui vantaggi di una tale macchina: dirigere le armate nei paesi lontani ed amministrare le loro conquiste, cose di un'importanza essenziale per un re del Portogallo; portare aiuto ai luoghi assediati; trasportare le merci; esplorare il mondo sconosciuto fino ai poli».
Il sovrano accoglie la richiesta, conferendo a Gusmâo un'alta carica presso un'università di Coimbra ed una pensione vitalizia. Il 6 maggio 1709 l'intraprendente gesuita comincia a costruire il suo apparecchio: lo prova il 3 e il 5 agosto dello stesso anno (non l'8, come alcuni sostengono) al palazzo reale di Lisbona. Il congegno sale, ma prende fuoco: non è più così, però, il 30 ottobre, quando, dopo l'ascesa, atterra felicemente.
Perseguitato dall'Inquisizione per aver usato un'arte nâo divina, incarcerato per stregoneria, il povero Gusmâo fuggirà poi a Toledo, dove morirà nell'ospedale della Misericordia il 18 novembre 1724.
Sul suo conto disponiamo oggi di una ricca bibliografia, ma si pensi che sono occorsi almeno cento anni per mettere insieme la documentazione che lo riguarda, tenuta in parte ben celata da certi ambienti.
La scoperta dell'idrogeno, annunciata dall'inglese Henry Cavendish nel 1766, sembra schiudere l'era della locomozione aerea. Un altro illustre chimico britannico, Black, compie con questo gas vari esperimenti prima della realizzazione della mongolfiera, e lo stesso fa l'italiano Tiberio Cavallo, la cui relazione giunge in Francia e in Inghilterra.
Ecco quanto scrive testualmente Jules Duhem: «Pubblicata favorevolmente dalle gazzette, la notizia si diffonde nei salotti e nei circoli scientifici, frequentati da un giovane provinciale in viaggi d'affari a Parigi, Joseph Montgolfier. Costui è un fabbricante di carta, e la porosità dei "sacchi" è giustamente di sua competenza. Si mette dunque al lavoro per vincerla, ma senza riuscirvi. Dopo alcuni mesi di ricerche infruttuose, un'osservazione fortuita (dicesi il gonfiarsi di una camicia posta ad asciugare presso il fuoco) dà ai fratelli l'idea di sostituire al gas, ostinatamente ribelle, l'aria calda, senza tregua rinnovata dalla combustione di un piccolo braciere».
Joseph-Michel e Jacques-Etienne Montgolfier lanciarono per la prima volta il loro pallone, senza passeggeri, il 5 giugno 1783. Un altro esemplare attraversò Parigi il 21 ottobre dello stesso anno, portando a bordo due persone.
Pochi mesi dopo, il francese Charles realizzava l'aerostato ad idrogeno, in tela impermeabile, con una navicella di vimini.
Dall'inizio del 1800 i primati si susseguono: nel 1804 Gay-Lussac raggiunge i 7.000 metri, nel 1932 Auguste Piccard tocca i 16.201 metri, nel 1934 il terzetto sovietico Fedosenko, Vasenko e Usiskin i 22.000, nell'ultimo dopoguerra l'americano Simson i 33.000.
Oggi i palloni vengono usati soltanto più a scopi scientifici, portando in alto strumenti di rilevamento, poi sganciati automaticamente e paracadutati.
È ovvio che, in balia dei venti, la mongolfiera mostra ben presto, a dispetto dei perfezionamenti, la sua impotenza. Nasce così l'idea di applicare eliche agli aerostati, ma, in mancanza del motore, i risultati sono ovviamente deludenti. Si pensi che nel febbraio 1872 il francese Dupuy de Lôme riesce ad ottenere a malapena una velocità di 8 chilometri orari per un brevissimo percorso e con il tempo calmo, impiegando otto uomini per azionare l'elica del suo pallone volante.
Agli inizi del XX secolo il dirigibile ebbe una certa diffusione, soppiantato poi dall'aeroplano. Il primo dirigibile fu costruito in Francia nel 1884 dai capitani Renard e Krebs. In Italia fu studiato da Crocco e nel 1908 Enrico Forlanini realizzò il Leonardo da Vinci. Modelli di piccole dimensioni per l'osserva zione militare vennero costruiti su piani dell'ingegner Usuelli.
Nel 1919 l'R-34 britannico effettuava la doppia traversata dal Nord Atlantico; nel 1923 il «Dixmude» francese compiva un raid di 7.100 chilometri, mentre gli «Zeppelin» germanici (così chiamati dal nome del loro creatore) coprivano il percorso Friedrichshafen (Germania) - Lakehurst (USA), per darsi poi ad altre imprese ed iniziare un servizio passeggeri Europa-America.
Il «Norge» e l'«Italia», infine, progettati e comandati dal generale Umberto Nobile, trasvolavano il Polo Nord.
L'impiego del dirigibile venne però abbandonato per i problemi che i gas destinati alla riempitura dell'involucro comportavano: l'elio troppo caro, l'idrogeno estremamente infiammabile.
Era giunto il tempo dell'aeroplano, segnato dalla comparsa dell'elica a motore.
Comparsa o ricomparsa?
Gli appassionati delle «scienze antiche» sono tuttora in dubbio.
Se cerchiamo l'elica più antica del mondo, dobbiamo andare a Monte Albán per trovarla, presso Oaxaca, in Messico, nel paese che vide, in tempi senza data, il fiorire della favolosa civiltà degli Olmechi, i creatori delle gigantesche teste di pietra raffiguranti gli «uomini-gatto» o «uomini-giaguaro», probabilmente rappresentanti di una enigmatica razza scomparsa, come abbiamo sottolineato in «Terra senza tempo» e «Non è terrestre».
In tale località, una stele ci presenta l'incisione di quello che pare un apparecchio con un'elica a tre pale.
«Il disegno», scrive Robert Carras, del Centre d'Étude et de Recherche d'Élements Inconnus de Civilisation di Nizza, «è uno schizzo tecnico che fa pensare a quegli aerei mostrati senza rivestimento, con la sola ossatura e l'apparato motore. Osservandolo, si ha l'idea di uno scafo con un abitacolo, del motore stesso, insomma, di un mezzo volante. È evidente la propulsione ad elica: vi si scorge, poi, una "coda" che doveva servire a dirigere il veicolo».
Lo studioso e scrittore francese Robert Charroux nota, a commento:
«Quest'espressione grafica, propria a Tiahuanaco, a Palenque e a Monte Albán (espressione che si trova anche nei manoscritti maya), è del tutto estranea alla scrittura abituale dei messicani. Essa costituisce un'anomalia molto interessante, che indica il carattere eccezionale di un'avventura ai margini della storia dei/popoli americani. È chiaro che essi non hanno potuto inventare motori ad elica, né razzi come quello di Palenque. Se hanno inciso il disegno di queste macchine, tanto significa che esse esistevano nei loro ricordi, sempre - è ovvio - con le deformazioni dovute al tempo».
Venendo ad epoche posteriori (ma anche queste difficilmente databili) troviamo eliche applicate ai veicoli aerei del leggendario regno del Ki Kung, a cui abbiamo già accennato.
Ma si sarà trattato di eliche «attive», cioè collegate a qualche congegno, oppure di eliche «passive», mosse soltanto dalle correnti aeree, come si dice di quella forse applicata alla colomba meccanica di Archita e ad altri oggetti?
Si sa per certo che i Tibetani usavano quest'ultimo tipo per quelli che definiremmo giochetti magico-religiosi ed i Tartari buddisti per i loro mulinelli da preghiera, ma un'applicazione impressionante l'abbiamo soltanto verso il 1460, quando Roberto Valturio, ingegnere militare di Sigismondo Malatesta, signore di Rimini, fa avanzare un carro d'assalto per mezzo di due eliche a quattro pale, mosse dal vento.
In campo aeronautico troviamo parecchie idee, ma nessuna realizzazione: occorrerà attendere le eliche azionate dal piccolo motore a scoppio dei fratelli Wright, nel 1903, per vederle applicate finalmente al volo.
Dopo quella dell'aeroplano doveva giungere la creazione dell'elicottero, le cui radici sembrano però essere assai più lontane nel tempo.
Anche quest'idea va cercata in Cina, in epoche immemorabili. Se sia stata applicata, non sappiamo. Duhem, tuttavia, riferisce l'esistenza di una vecchia illustrazione in cui «un principe viaggia con il seguito su tre carri volanti senza ruote. Ognuno di essi è mosso da quattro eliche, alle quali degli ingranaggi trasmettono l'azione di un meccanismo interno».
La vera teoria scientifica che sta alla base dell'elicottero è però quella elaborata da Leonardo da Vinci, ma tutto dipende ancora dalla forza muscolare, ed i progetti rimangono tali.
Enrico Forlanini, costruttore del primo dirigibile italiano e di altri apparecchi del genere impiegati durante la prima guerra mondiale («dirigibili F»), presenta nel 1877 a Milano un elicottero mosso da un motore a vapore, che riesce a raggiungere i 13 metri di altezza.
Dal 1904 i pionieri dell'elicottero sono numerosissimi, ma la prima vittoria viene conseguita da La Cierva, che nel 1928, con il suo «autogiro», sorvola la Manica. Vengono poi, rispettivamente nel 1935 e nel 1938, i «giroplani» di Bréguet-Dorand e di Raul Harner, ma il trionfo che preluderà allo sviluppo ed all'impiego su vasta scala del mezzo che oggi ben conosciamo arride ad Heinrich Focke, il quale, nel 1939, presenta in Germania, come ci ricorda Duhem, «un elicottero che può volare alla velocità oraria di 150 chilometri, muovendosi avanti, indietro, di fianco, salire e scendere verticalmente: il pilota cambia l'angolo delle eliche con una sicurezza tale che, dopo aver compiuto evoluzioni sulla folla di un anfiteatro, s'immobilizza, parla al pubblico ed atterra nel punto scelto».
Veniamo a qualcos'altro, a qualcosa di molto attuale.
«Un proiettile carico di una sostanza violentemente espulsa dalla sua parte posteriore riceve, per reazione, una spinta in avanti»: questo è, in parole semplici, il principio per cui si muove un razzo.
Non vogliamo qui fare la storia di questi ordigni attraverso i secoli, storia che abbiamo già tratteggiato in «Ombre sulle stelle», insieme ad altri argomenti relativi al volo spaziale, ma sottolineare soltanto la verità di quanto Konstantin Eduardovic Ziolkovski anticipò sin dal 1930:
«All'era degli aerei ad elica deve seguire l'era degli aerei a reazione o degli aerei stratosferici».
Poi, con i missili, di cui egli fu l'indiscusso precursore, si apriranno le rotte cosmiche. Notevolissimo è il fatto che Ziolkovski avesse già visto in quelli a più stadi la soluzione ideale, ma ancor più strana è la constatazione che qualcuno precedette sia lui che i realizzatori delle sue idee, qualcuno spuntato verso la metà del 1500, scomparso poi con la sua invenzione, lasciando però tracce che non danno adito a dubbi.
Un razzo a tre stadi nel 1955 in Romania?
Incredibile?
Certo si sarebbe portati a giudicare così la notizia. Ma la realtà è questa, documentata rigorosamente da Doru Todericiu, professore di scienze e tecnica all'università di Bucarest.
Riesumata, nel 1961, una serie di manoscritti dimenticati nella biblioteca di Sibiu, lo scienziato giunse alla straordinaria scoperta. Si tratta di tre lavori rilegati in volume dopo il 1570. Il primo è steso da Hans Haasenwein e datato addirittura 1417, il secondo, non firmato, è del 1460 e il terzo è redatto da Conrad Haas, capo del deposito di artiglieria di Sibiu dal 1550 al 1570.
Le ricerche, iniziate appunto nel 1400, interrotte e riprese in seguito, condussero al lancio, nel 1529, di un razzo a due stadi e di una «freccia volante» a vasto raggio d'azione. Nel 1555 seguì un razzo a tre stadi e venne anche progettata (ma non volò) una «casetta» propulsa da un missile: un'anticipazione, quindi, degli attuali veicoli spaziali!
Capitolo XIV - Viaggi dal passato: Sbarcano gli «alieni»
Abbiamo appena cercato di orizzontarci tra alcuni dei numerosissimi accenni concernenti epoche in cui l'aeronautica diede i suoi primi vagiti (o i suoi primi ruggiti?), soffocati poi dal silenzio di secoli bui o dalla mancanza di elementi tali da poter condurla a successi precedenti di molto la sua reale affermazione.
C'è però sempre ancora chi le prepone un'astronautica extraterrestre, e gli indizi di cui disponiamo - come abbiamo detto - ci possono lasciare dubbiosi, ma non possono cancellare in noi il senso di un'affascinante inquietudine.
Riandiamo qui ad elementi di quella che non ci piace definire «archeologia spaziale», come qualcuno l'ha chiamata (i segni, per quanto impressionanti, sono sempre qui, sul nostro globo), ma che non possiamo trascurare per i loro riflessi cosmici.
Nessuno dei nostri lettori ha sentito probabilmente parlare di Sanchoniathon: ci dicono sia stato un saggio vissuto circa nel XX secolo a. C., autore di un'opera grandiosa, la «Storia fenicia».
La traduzione del lavoro in discorso venne effettuata nel I secolo d. C. da Filone di Biblo, ma scomparve misteriosamente e non ne troveremmo più traccia se non fosse stata fatta oggetto di un'accesa vertenza tra il filosofo greco Porfirio e il vescovo di Cesarea Eusebio agli inizi del 300 d. C.
Porfirio sostenne che la «Genesi» (il primo libro dell'Antico Testamento e del Pentateuco, attribuito a Mosè) era stato copiato quasi interamente dalla «Storia fenicia», mentre Eusebio contestò tale asserzione.
Non vogliamo certo fare dell'esegesi biblica, ma ringraziare i due coltissimi rivali per averci trasmesso una parte dell'opera perduta. E il merito va anche all'accademico francese Séguier de Saint-Brisson che, nel 1846, ci presentò la traduzione degli scritti del vescovo intitolati «La preparazione evangelica».
Sparvieri galattici
Ci limiteremo ad alcuni passi relativi alla nostra trattazione, passi che si riferiscono ad un misterioso «serpente» che non è certo un rettile, ma «una cosa luminosa vagante nelle nubi, rombante e rapida come il lampo».
«Taautos, e, dopo lui, i Fenici e gli Egizi», riporta Filone dall'opera di Sanchoniathon, «hanno divinizzato la specie dei draghi e dei serpenti come animali rampanti la cui respirazione è più forte di tutti gli altri, dicendo che la specie stessa appartiene alla materia ignea e che c'è in essa una velocità la quale non può essere superata da nulla a causa del suo soffio».
Qui incontriamo le prime, clamorose discordanze con le idee che generalmente abbiamo circa i serpenti: come può un rettile «vagare nelle nubi», «appartenere alla materia ignea» ed essere capace di una velocità irraggiungibile, generata dal suo soffio?
E siamo appena agli inizi:
«Dà la velocità che vuole alle eliche che descrive nella sua marcia», aggiunge il vescovo Eusebio, «il che fa sì che questo animale entri come parte essenziale nel templi e nei misteri...
«Questo animale non muore di morte naturale. I Fenici lo chiamano Agathodemon, il buon genio, e gli Egizi Kneph: essi gli aggiungono una testa di sparviero, a causa dell'energia di quest'uccello».
Uccello o serpente? Gli attributi che gli vengono dati appartengono spesso ad entrambi gli animali, ma soltanto nelle sue rappresentazioni, perché nel concetto vi sfuggono del tutto.
Ecco come ce ne parla Epeis, gran sacerdote e grammatico, tradotto in greco da Areio di Eraclopoli: «La prima e la più eminente divinità è il serpente con la testa di sparviero (tutto pieno di grazia), che quando apre gli occhi riempie di luce l'intera distesa della Terra protogenita, o prima generata, e quando li chiude succedono le tenebre».
E Zarathustra: «Il dio con la testa di sparviero è il primo, eterno, indivisibile, ineguagliabile, la guida verso tutto quanto è bello, non lasciandosi conquistare da regali...».
Certo, vituperato o adorato, il serpente domina moltissime religioni: vituperato da quelle che si sostituirono al suo culto come divinità benefica, adorato sin da tempi antichissimi e rappresentato in innumerevoli disegni, in innumerevoli monumenti in Fenicia, in Assiria-Babilonia, in Frigia, in Egitto, in Grecia, nel Perù, nel Messico, nel Guatemala, in Colombia, nell'America del Nord, in molte regioni africane e persino in Polinesia e in Australia.
È curioso notare come il serpente venga rappresentato avvolto a spirale, disposto nel segno dell'infinito o rigido, a volte alato ed a volte rostrato. Ora, la forma della spirale è quella della maggior parte delle galassie, ed è per lo meno strano che presso tanti popoli antichi sia il simbolo tanto della creazione quanto dell'universo, del cielo, dello spazio. Ma come, con quali mezzi, con quali indispensabili conoscenze scientifiche i nostri progenitori giunsero a tali identificazioni?
La risposta va forse cercata nel serpente rigido alato o rostrato, nel «dio» onnisciente, benefattore e civilizzatore venuto dalle profondità del cosmo. Ecco come Robert Charroux esprime, riallacciandosi a quanto abbiamo scritto, questo fantastico concetto:
«Incontestabilmente - e Sanchoniathon lo precisa - non si tratta di un serpente-animale, ma di un serpente-ordigno volante, poiché è velocissimo e lo si rappresenta con una testa di sparviero.
«Questo oggetto imprime la velocità desiderata alle "eliche" che descrive. La frase è enigmatica, nondimeno emerge dalla descrizione generale che il serpente si muove nello spazio mediante un "soffio" posteriore che è l'immagine stessa della reazione e mediante un sistema elicoidale anteriore: Sanchoniathon parla di un "serpente ad elica" ed "a propulsione", gli Egizi lo chiamano "vipera-fiamma".
«La parola "elica" viene dal greco helix, helissein - arrotolare, che dà ilinx - vortice, turbine. È questo turbine che colpisce la nostra immaginazione... il parallelo con l'aeronautica del ventesimo secolo fa sì che s'identifichi il serpente volante con un turbo jet, propulso per reazione, con un'elica davanti.
«Notiamo ancora l'aspetto scintillante dell'aereo, la cui fonte di energia - si precisa - è eccezionale ed appartiene alla materia ignea, senza dubbio resa visualmente dal fuoco emesso dagli ugelli, il cui rombo (il "soffio") impressionò tanto Sanchoniathon.
«Questo "serpente" conosciuto dai Fenici e dagli Egizi corrisponde bene alla definizione che gli venne finalmente data: macchina volante extraterrestre pilotata da Iniziatori».
Si tratta di una definizione certo alquanto azzardata, ma lo scrittore francese pensa non possa esistere un'altra spiegazione.
Come la mettiamo, allora, con le parole di Zarathustra, che ne fa un dio, e con le raffigurazioni spesso antropomorfe o semiantropomorfe che troviamo presso tante civiltà antiche?
La spiegazione sarebbe semplice: quei popoli avrebbero così raffigurato tanto l'astronave quanto i suoi occupanti.
Le mitologie di tutto il mondo abbondano - lo sappiamo - di dei volanti con mezzi propri (ali, elmi, corazze e calzari alati) o a bordo di oggetti che la scienza «ufficiale» esita a qualificare e, tanto meno, a definire veicoli aerei.
Di questo abbiamo già parlato a sufficienza nei nostri lavori precedenti, ma ci sembra opportuno aggiungere qualcosa di sorprendente, riferitoci ancora da Charroux:
«In Honduras le leggende raccontano che un tempo scese dal cielo una giovane donna dalla pelle bianca, di una bellezza incredibile. Atterrò nella città di Cealcoquin, dove fece costruire un palazzo ornato con strane figure di uomini e di animali.
«Nel tempio venne posta una pietra verde, che presentava su tre delle sue facce disegni altrettanto misteriosi di quelli incisi sulle mura del palazzo: era una pietra magica, un autentico talismano che dava alla dea bianca il potere di vincere tutti i nemici.
«Un giorno, vedendo la sua bellezza declinare, la divinità divise il suo regno tra i figli e fece portare il suo "letto volante" sulla più alta terrazza del palazzo, scomparendo di lì a poco nel cielo sotto forma di un bell'uccello».
Anche l'URSS conta i suoi... astronauti in anteprima. Nel 1965 alcuni archeologi sovietici portarono alla luce, in Siberia orientale, incisioni rappresentanti personaggi con il corpo umano e la testa di uccello. Il professor Alexandr Lipski osservò che queste raffigurazioni avevano una grande analogia con il Toth e l'Horus degli Egizi.
Una scoperta ancora più importante venne compiuta a Perghana, nell'Uzbekistan, in piena Asia centrale sovietica, dove il professor G. V. Satski, dell'Istituto archeologico di Samarcanda, rinvenne nei pressi di una grotta un disegno rappresentante uno strano personaggio munito di un casco ermetico con antenne e di qualcosa che assomiglia ai propulsori dorsali di cui si pensa di fornire i «passeggiatori spaziali».
L'identità o, per lo meno, le affinità di tanti miti e di tante testimonianze, forniscono un'ulteriore prova circa la matrice comune di quasi tutte le civiltà.
Quanto ai «colonizzatori» extraterrestri, parliamone pure: non siamo soli nell'universo. Ma prima di lasciarci andare ad affermazioni tanto decise quanto azzardate, cerchiamo ancora.
I Maya e l'aviazione
In un modo o nell'altro, gli antenati dei precolombiani conoscevano dunque il volo? C'è, come abbiamo visto, chi lo afferma, collegando incisioni e disegni a leggende, tradizioni, antiche credenze religiose che vogliono tante divinità e tanti eroi discesi dal cielo o saliti nello spazio.
Senza dubbio la famosa lastra di Palenque rimane la più impressionante documentazione di qualcosa che ci sfugge eppure sentiamo tanto vicino, addirittura del volo cosmico. Ma alcuni studiosi pensano che in materia esistano altri indizi, se non altre prove, e senza dubbio, scorrendo gli enigmatici codici maya, ci troviamo di fronte a motivi di cui non possiamo evitare la suggestione.
Il Codice Troano, ad esempio, tradotto dall'abate Brasseur de Bourbourg sulla chiave dell'interpretazione di Diego de Landa, sembra iniziare con la descrizione del diluvio universale. Ecco come ci viene presentata:
Ovviamente tra gli esperti esistono parecchie discordanze circa questo o quel significato, ma, in sostanza, il testo reso da Brasseur de Bourbourg, nelle sue linee generali, risulta convincente.
Esaminando il codice in discorso, noteremo con Charroux che gli ideogrammi più ricorrenti ci parlano, oltre che della catastrofe che sconvolse la Terra, di energie sconosciute, di fuoco, di sollevamento, di volo. Li riproduciamo qui con il significato che è stato loro attribuito:
 | Fig. 80. (1) Ugelli (2) Sollevamento (3) Motore (4) Serpente volante (5) Piramide (= energia?) (6) Fuoco (7) Scala volante (8) Potenza - cumulo - massa. |